
Prefazione
Ho scelto di scrivere un libro di facile accesso anche per chi non ha una approfondita preparazione scientifica. Forse ho ecceduto perché ad esempio non ho incluso una bibliografia, ma oggi internet permette di rintracciare qualsiasi fonte di informazione. Molte delle notizie particolari sono ampiamente sviluppate nell'ultima edizione del mio libro “I ritmi segreti dell'Universo”, Aracne Editrice, del 2010; ad esso perciò rimando il lettore che voglia compiere approfondimenti su i cicli naturali, le variazioni del livello marino, la grande trasgressione che ha caratterizzato il Tirreniano, le puntate glaciali, la subsidenza, i cambiamenti climatici indotti dall'attività umana nell'età industriale, le suddivisioni stratigrafiche, la formazione dell'Appennino, la tettonica delle placche, la costituzione della Terra, le variazioni della forza di gravità ed altro.
Diverse affermazioni che verranno lette non figurano o sono in netto contrasto rispetto a quanto è riportato nella letteratura geologica: per esempio, quando sostengo che 4800 anni fa è stato raggiunto il culmine dell’interglaciale, che l’Appennino si è formato poco più di un milione di anni fa, che 270 mila anni fa il mare ha sommerso metà delle aree continentali o che il nucleo esterno della Terra non è costituito da ferro. Non sono ipotesi di fantasia ma idee giustificate da precisi dati accumulati in decenni di lavoro. Anche nuovi elementi che vengono ora presentati a due anni dall'uscita di quel libro sono documentati; essi hanno dato spunto per nuove riflessioni e anche sensibili modifiche delle conclusioni raggiunte in precedenza.
Mi sono lasciato andare alla fine a previsioni talvolta azzardate, almeno stando al giudizio di chi ne è stato messo a parte. Mi giustifico facendo presente che si tratta di ipotesi maturate dopo ampie riflessioni.
Mi sarebbe piaciuto completare il quadro con catastrofi di natura biologica e fisica come le epidemie e le inversioni del campo magnetico, l’ampliamento del buco dell’ozono, le tempeste magnetiche, ma non ho voluto strafare, e poi si tratta di campi in cui non ho competenza. Credo che con quello che ho affrontato ce ne sia abbastanza per riflettere a lungo.
Introduzione
La profezia maya si riferisce sicuramente a una catastrofe di grandi proporzioni. Mentre la cultura comune, popolare, è sempre molto attenta quando si parla di catastrofi naturali, il mondo della scienza è per lo più restio a trattare questo argomento fino in fondo, con il risultato che spesso, quando le catastrofi avvengono, si arriva impreparati ad affrontarle.
Questo libro passa in rassegna tutte le catastrofi che le forze fisiche della natura hanno messo in atto nel passato anche remoto e potrebbero ripresentare nel futuro e cerca di spiegare i modi e le ragioni con cui chi si occupa istituzionalmente di disastri naturali tende a trascurare gli aspetti più sconvolgenti del problema.
La teoria delle catastrofi ha preso l’avvio da una grande scoperta compiuta all'inizio dell' '800. George Cuvier, esaminando i fossili contenuti nella successione di strati del Bacino di Parigi, si accorse che per 11 volte avveniva la scomparsa contemporanea, improvvisa, di un buon numero di specie di organismi. Non aveva dubbi che qualcosa di assai rapido e catastrofico doveva avere determinato quelle scomparse cosicché nel 1825 ne diede notizia in una nota dal titolo “Discours sur les révolutions à la surface du globe”.Quei “discorsi” vennero accolti con grande entusiasmo poiché molti vi vedevano la prova che le sacre scritture dicono il vero quando parlano di un evento catastrofico quale è stato il diluvio universale. L'ottima accoglienza riservata al catastrofismo di Cuvier durò tuttavia per breve tempo, fino a quando, nel 1830, uscì il primo dei tre volumi dei Principles of Geology di Charles Lyell, che, nelle intenzioni dell'autore espresse in un sottotitolo, era un “tentativo di spiegare i cambiamenti del passato della superficie terrestre con riferimento a cause tuttora operanti”. L'autore, anche se non lo dichiarava apertamente, mirava a evidenziare che alcuni contenuti della Bibbia, in cui si forniscono elementi per calcolare la durata dell'esistenza della Terra e si narra di un diluvio universale, possono essere contraddetti dagli studi geologici. Contro le poche migliaia di anni che sarebbero trascorse dalla “creazione”, vi erano prove che sono state necessarie centinaia di migliaia di anni perché si accumulassero serie sedimentarie anche di modesto spessore. Per quanto riguarda il diluvio, Lyell ne negava la realtà sottolineando l’idea che tutti i cambiamenti avvenuti sulla superficie terrestre devono essersi verificati lentamente e gradualmente. Partendo dall’osservazione che al giorno d’oggi è così che i fenomeni si presentano, arrivò alla conclusione che “dai tempi più antichi non hanno mai operato cause diverse da quelle che operano ora, e queste non hanno mai agito a livelli di energia diversi da quelli attuali”, convinto dell’esistenza di una uniformità nell’ordine della natura ovvero che l’uniformità facesse parte dell’ordine della natura.
Lyell stabiliva così il principio dell'Attualismo, radicalizzando il pensiero del suo maestro Hutton, sostenitore della uniformità con cui si presentano i fenomeni naturali e della possibilità di interpretare il passato osservando quanto avviene nel presente.
Nel fermento di idee nuove, frutto del trascorso illuminismo, purtroppo Cuvier si trovò a lottare, e a soccombere, anche su un altro fronte: il trasformismo delle specie sostenuto da Jean Baptiste Lamarck nella sua Philosophie zoologique del 1809, che in seguito, nel 1849, lascerà posto alla teoria dell'evoluzione di Charles Darwin. Tra l'altro, anche Darwin condivideva le idee dell'uniformismo lanciate da Hutton e pensava dunque a trasformazioni lente e graduali, senza eventi catastrofici che potessero cambiare in modo drammatico il panorama dei fenomeni osservabili.
Cuvier aveva avuto un'idea corretta riguardo alla scomparsa improvvisa delle specie ma rimaneva purtroppo ancorato a idee obsolete per quanto attiene al modo in cui specie nuove compaiono dopo la catastrofe: il ripopolamento delle aree osservate avveniva, a suo avviso, con l'apporto successivo di nuove specie provenienti da altre aree. In questo, Cuvier era fissista. Malauguratamente il fissismo richiamava il creazionismo di Linneo, che aveva riferimenti tutt'altro che scientifici.
Fu così che l'interesse per le catastrofi svanì per circa un secolo e mezzo, fino a quando Luis e Walter Alvarez nel 1980 riportarono alla ribalta il problema delle grandi estinzioni esponendo la loro ipotesi che l’impatto di una grande meteorite fosse responsabile dell’estinzione di massa che 65 milioni di anni fa coinvolse, tra gli altri esseri, tutti i grandi dinosauri. Non mi soffermo ora a commentare tale ipotesi rinviandola oltre, quando tratterò questo argomento.
C'è da sottolineare il fatto che l'attualismo, in aggiunta allo studio sulle grandi estinzioni, ha mietuto un'altra vittima: la geodinamica, cioè quella importante branca della geologia che studia le catene montuose. Essa si è sviluppata solo a cavallo del 1900 poiché le catene oggi non si formano, le vediamo solo innalzarsi, seppure molto lentamente; i processi formativi dei sistemi montuosi intervengono in momenti eccezionali, non osservabili con frequenze minori di milioni di anni.
Considerate le premesse, sarebbe potuto soccombere anche lo studio delle glaciazioni, ulteriore argomento che poteva attrarre le censure di Lyell in quanto denotano anch'esse un carattere catastrofico. Tra il 1825 e il 1833 Jean de Charpentier aveva osservato sulle Alpi svizzere che i ghiacciai erano soggetti a variazioni di dimensioni, come mostravano i loro fronti morenici. Tali fronti indicavano che nel passato i ghiacci dovevano coprire tutta la catena alpina con una coltre di notevole spessore. Queste osservazioni sono state portate avanti da Louis Agassiz, che nel 1840 le ha raccolte in un suo “Étude sur les glaciers”.
La scoperta delle glaciazioni che avevano interessato la Terra nel passato non andava ovviamente nel senso in cui Lyell voleva incanalare la scienza, dato che tale fenomeno contravveniva a una delle condizioni da lui dettate cioè che le cause dei vari fenomeni “non hanno mai agito a livelli di energia diversi da quelli attuali”.
Probabilmente veniva comunque riconosciuto ad Agassiz il merito di non essersi ispirato agli eventi biblici. Infatti, alla fine del secolo precedente, un problema che non si riusciva a risolvere in modo razionale era quello dei massi erratici: nei depositi morenici allineati a sud di Berlino si trovavano inglobati massi di rocce tipiche della Svezia centrale. Che cosa li aveva trascinati fin lì, a una distanza di 1000 km dalla loro collocazione originale? I naturalisti immaginavano che il fenomeno fosse dovuto a un flusso di acque conseguente al diluvio biblico. Agassiz aveva almeno contribuito a sottrarre questo argomento alla fantasia dei diluvisti.
Il lavoro di Agassiz dimostrava che nel passato lo spessore di ghiaccio sulle Alpi era stato di gran lunga maggiore di quanto si riscontra adesso e che dovevano aver agito cause di intensità molto diversa da quella che constatiamo attualmente, contraddicendo clamorosamente un fondamento dell'attualismo.
La conseguenza sarebbe dovuto essere un ripensamento sui principi di Lyell; al contrario, ha subito un considerevole rallentamento lo studio delle glaciazioni. Per un riavvio di queste conoscenze bisognerà aspettare i primi anni del '900, con un classico lavoro osservativo di Penck e Bruckner.
Poco dopo, nel 1940, i complessi calcoli di Milutin Milankovic hanno fornito al succedersi delle glaciazioni una spiegazione teorica; essa si basa sull’assunto che i fenomeni glaciali dipendano dal modo in cui la radiazione solare si ripartisce alle varie latitudini. Il modo è funzione di tre principali fattori astronomici: la precessione degli equinozi, la variazione dell’obliquità dell’asse terrestre sul piano dell’eclittica e la variazione dell’eccentricità dell’orbita. La teoria astronomica delle glaciazioni è stata accolta con molto favore in quanto, stabilendo implicitamente che la radiazione solare doveva essere una costante e che le trasformazioni climatiche avvenivano in modo graduale, si conformava perfettamente al principio dell’attualismo. Perciò essa ha resistito ed è tuttora generalmente accettata, anche se è risultato presto evidente che non è corretta, da quando ci si è accorti che i ghiacci si sono espansi contemporaneamente all'equatore e ai poli, dimostrando così che la radiazione solare non è costante nel tempo.
Inoltre ancora oggi si ritiene che l'espansione e il ritiro dei ghiacci debbano avvenire lentamente e gradualmente, mentre al contrario la prima fase è ben più rapida della seconda, come sta lentamente emergendo dagli studi più recenti. Poiché l'ultima puntata glaciale ha dei limiti precisi (tra circa 27500 e 10000 anni fa) e vi sono prove evidenti che la massima espansione si era già completata 25 mila anni fa, se ne può dedurre che la fase di avanzamento è stata molto più rapida della successiva fase di ritiro. Eppure si continuano a leggere articoli che trattano del “culmine glaciale di 18000 anni fa”, considerato pertanto a metà dell'intervallo freddo. In più, l'esame delle morene frontali della calotta europea indica che il ritiro è stato episodico, e anche questo è in contrasto con l'attualismo, che vuole che i fenomeni avvengano gradualmente, senza discontinuità.
Per Lyell i risultati scientifici non potevano alimentare interpretazioni di tipo catastrofico in quanto egli aveva una visione limitata della realtà. Questa limitazione lo induceva anche a giudicare negativamente un lavoro rigettandolo a priori senza prenderne conoscenza. I dati di Cuvier erano obiettivi: alcune specie scompaiono improvvisamente al disopra di un ben determinato limite stratigrafico, altre non si trovano più sopra un limite successivo e così via. Quale spiegazione sapeva fornire Lyell? Ha tentato di darne una o invece ha ritenuto che erano tutte invenzioni? Ironia della sorte: per un uomo che discendeva orgogliosamente dall'illuminismo il suo era un atteggiamento prettamente oscurantista.
La questione mi riporta all'episodio, descritto da Brecht nella sua “Vita di Galileo”, di quando Galilei si recò a Firenze e invitò due scienziati, un matematico e un filosofo, a guardare nel cannocchiale per appurare direttamente che la Luna non era un corpo perfetto, una perfetta sfera di cristallo, come invece asseriva Aristotele, ma mostrava montagne e avvallamenti come la Terra. I due si rifiutarono di guardare perché, se il cannocchiale ingrandiva le immagini, doveva significare che alterava la realtà. In effetti i due temevano che venisse alterata la realtà che la Chiesa dogmaticamente presentava come vera.
Analogamente Lyell non poteva tollerare che la realtà geologica che andava costruendo venisse alterata da quel Cuvier che si esprimeva come un rivoluzionario francese, desideroso di inserire le rivoluzioni addirittura nei comportamenti della superficie del globo. Forse si figurava nei panni di Wellington, il cui intento era quello di riuscire a sistemare definitivamente quel diavolo di Bonaparte. O meglio si identificava coi diplomatici che nel 1814 a Vienna stabilivano come si deve governare questo mondo.
Non vi è dubbio che Cuvier si sentisse un rivoluzionario: era entrato anche nel Consiglio di Stato ai tempi di Napoleone, poco prima del Congresso di Vienna! E non esito a credere che Lyell si sentisse un restauratore o quantomeno un conservatore; non era neanche un conservatore illuminato, a dispetto della sua impostazione illuministica, secondo la quale è la ragione che dovrebbe guidare il nostro modo di pensare ed agire. A mio avviso la ragione si può spingere fino ai confini del noto; poi intervengono altre componenti naturali, quali la creatività e l'intuizione. Lyell invece non ammetteva che il noto non è il limite del conoscibile. Meglio sarebbe stato se avesse posto alla base degli studi geologici un solo principio, più generale, cioè che le ricostruzioni della realtà devono essere coerenti con i dati che risultano dalle osservazioni.
Lyell credeva di scrollarsi di dosso superstizioni di carattere religioso, come una creazione realizzata in sei giorni o un diluvio scatenato da Dio per punire gli uomini, mentre in realtà introduceva ancora superstizioni di natura religiosa quando accoglieva il modo di pensare del suo maestro. Hutton riteneva che i fenomeni del mondo dovevano essere sempre gli stessi e ordinati, immaginando che, avendo Dio creato il mondo, il progetto divino non poteva essere altro che così, ordinato e ripetitivo alla scala della vita dell'uomo.
Mentre Hutton concepiva una uniformità nelle modalità di manifestazione della natura, Lyell vedeva una uniformità anche nella intensità delle cause sottostanti la manifestazione. Con le loro convinzioni sia Lyell che Hutton hanno condizionato non soltanto il modo di vedere la realtà, ma anche il modo di pensare come va vista la realtà. Nonostante la sua derivazione illuministica, anche Hutton era un illuminista inattendibile: egli ha captato l'uniformismo della sua educazione religiosa, che non ammette deviazioni dall'interpretazione ufficiale della verità rivelata, e lo ha tradotto nella ricerca geologica. L’effetto, come vedremo, è stato catastrofico.
La scienza non riesce a scrollarsi di dosso la cappa di conservatorismo, sia a causa della rigida impostazione di Hutton, sia per i principi arbitrari introdotti successivamente da Lyell: prima le scoperte scientifiche erano frenate dalla fede, oggi lo sono da false regole dettate dalla ragione. Ispirandosi ai sacri principi di Lyell, la comunità scientifica manifesta i suoi atteggiamenti dogmatici tramite le varie associazioni; queste si comportano come corporazioni con lo scopo non tanto di fare progredire la conoscenza quanto di difendere i propri associati, che temono di vedere il proprio sapere e le proprie certezze scalfiti ogni tanto da un Cuvier di turno.
Mi auguro che le critiche sollevate possano intaccare la rigidità con cui si muove l'ambiente scientifico e il personalismo delle idee, che non permettono una libera e obiettiva discussione su molti temi. Ciò sarà possibile tanto più quanto maggiormente le previsioni qui presentate si avvicineranno agli eventi che si stanno preparando a manifestarsi.
La profezia dei Maya
Sulla collina di Tortuguero, non lontano da Palenque, nel sudovest dello Yukatan si possono ancora osservare le rovine di un tempio maya apparentemente modesto che, pur soffrendo l'inclemenza del tempo, da pochi anni fa parlare di sé tutto il mondo. Da qui è stata tratta una stele calcarea parzialmente erosa e ridotta in sette frammenti, conservati in vari musei, su cui una iscrizione annuncia che il 21 dicembre 2012 il dio Bolom Yokte, che rappresenta le forze della creazione e della distruzione, scenderà sulla Terra e ...
Le parti cancellate contenevano gli effetti dell’intervento del dio. Ci si è chiesto che cosa realmente volesse dire quella frase quando era completa, e la fantasia popolare con la sua creatività ha cercato di aggiungere alle parole ancora leggibili tutte le interpretazioni possibili.
Ma aldilà della conoscenza di ciò che avverrà realmente nel 2012, occorre assolutamente sapere se le civiltà amerinde più di 5 mila anni fa hanno fatto una previsione molto precisa o se questa eventuale precisione debba essere considerata solamente frutto del caso.
Quando ho cominciato ad occuparmi del problema del 2012, sono partito dall'idea di una semplice casualità per la coincidenza della data del 21 dicembre, come fine di un certo periodo della civiltà maya, con il giorno del solstizio d'inverno. Ci potremo orientare in questo dilemma esaminando come i Maya scandivano il tempo.
Si ritiene comunemente che i Maya si servissero, a seconda dei casi, di tre calendari: uno di 260 giorni per le cerimonie religiose, uno di 360, a cui bisogna aggiungere 5 giorni considerati infausti, per uso civile e infine un supercalendario assai particolare, che conosciamo come “lungo computo”.
Per comprendere come fosse strutturato questo lungo computo, pensiamo che il nostro calendario si basa sulla ripetizione di un ciclo di una trentina di giorni, che è il mese, e di un ciclo 12 volte maggiore, che è dato da un anno. Il ciclo base del lungo computo è di 20 giorni; dopodiché ci sono altri 4 cicli, che sono rispettivamente 18, 20, 20 e 13 volte maggiori del loro precedente. Quando il ciclo massimo sarà completo, il calendario segnerà la data 12.19.19.17.19; a quel punto il computo non continua ma si ferma poiché il giorno dopo tutti i cicli si azzereranno e la scrittura sarà quindi 0.00.00.00.00. Infatti i Maya, diversamente da noi, che passiamo dall’anno 1 a.C. all’1 d.C., avevano adottato lo zero. E, mentre noi abbiamo un calendario caratterizzato da uno scorrere degli anni che, calcolati a partire dalla nascita di Cristo, non hanno una conclusione, i Maya vivevano sapendo che il loro computo avrebbe avuto una fine e restavano in attesa di una inevitabile conclusione drammatica. A dire il vero anche una nostra credenza popolare, alimentata da un passo delle sacre scritture, pone un termine al tempo, e allora per tutti gli uomini arriverà un giudizio inesorabile.
Se ci limitassimo a ragionare su come appaiono concepiti i tre calendari, riuscirebbe difficile credere che 5125 anni prima della scadenza della quinta era, o più precisamente 1872000 giorni prima del 21 dicembre 2012, gli antenati dei Maya potessero prevedere il momento esatto del solstizio d’inverno. Ma, se non vogliamo fermarci alla prima apparenza, abbiamo l’opportunità di consultare il Codice di Dresda, uno dei soli quattro codici pervenutici direttamente della cultura maya, anche se è una copia riprodotta almeno cinque secoli dopo la stesura originale. Vi sono elencate le eclissi di Sole che si sarebbero verificate dopo il 600 d.C.; per l'eclisse dell'11 agosto 1999 è stato riscontrato un errore di appena 33 secondi. Ci sorge perciò la domanda: come potevano fare previsioni del genere? E ci accorgiamo che le loro conoscenze astronomiche erano talmente accurate da fare risultare il loro anno, di 365,242129 giorni, più preciso del nostro. Nel 1582 noi siamo passati dal calendario giuliano, in vigore dai tempi di Giulio Cesare, di 365,25 giorni a quello gregoriano, per il quale la durata dell'anno è di 365,2425 giorni. I moderni calcoli astronomici indicano una durata di 365,242214 giorni.
Sta prendendo dunque consistenza l'ipotesi che i predecessori dei Maya non abbiano indovinato per caso la data del solstizio d'inverno con 5125 anni di anticipo (è bene tenere presente che, quando hanno iniziato il lungo computo, nel 3113 a.C., il solstizio d’inverno cadeva ai primi di marzo), bensì l'abbiano calcolata con esattezza perché conoscevano molto approfonditamente il ciclo della precessione degli equinozi, quel lentissimo cambiamento dell'orientamento dell'asse terrestre che fa spostare nel tempo i momenti dell'anno quando si hanno solstizi ed equinozi e fa cambiare l'intersezione dell'asse sulla volta celeste, per cui tra 13 mila anni la stella polare diventerà Vega. A causa di questo movimento le costellazioni dello zodiaco si spostano di 1° ogni 72 anni circa.
Gli antichi egizi indubbiamente conoscevano anch'essi tale movimento e per seguirlo non esitavano a ricostruire alcuni templi al fine di mantenere l'allineamento originale con determinate stelle. I caldei 3000 anni fa ne erano a conoscenza e molto probabilmente anche gli antichi cinesi ed indiani. Eppure solitamente si attribuisce la scoperta della precessione all'astronomo greco Ipparco di Nicea, che l'ha descritta nella sua opera “Sullo spostamento dei punti solstiziali ed equinoziali”, redatta intorno al 130 a.C..
Ipparco, confrontando le proprie osservazioni con quelle di altri due astronomi che avevano messo insieme un catalogo di stelle 150 anni prima, valutò che la precessione si manifestasse con uno spostamento di longitudine di 46'' all'anno, abbastanza vicino al valore stimato oggi, che è di 50,26''. 265 anni più tardi, nel II secolo d. C., Claudio Tolomeo ha ripetuto i calcoli di Ipparco trovando un valore di 36''.
Non ci deve sorprendere che Tolomeo, pur disponendo di una situazione più favorevole poiché in oltre 4 secoli lo spostamento delle costellazioni era diventato ben maggiore e quindi più facilmente misurabile, abbia avuto risultati meno precisi rispetto al suo predecessore. Ancora oggi, specialmente tra i fisici, vi è una notevole differenza tra ricercatori sperimentali e teorici. Ipparco era un abile scienziato sperimentale. Tolomeo lavorava soprattutto sul piano teorico: a lui infatti dobbiamo le elaborazioni matematiche del moto del Sole, della Luna e dei pianeti contenute nell'Almagesto, adottate fino ai tempi di Copernico.
Riflettendo sui valori delle misure della precessione eseguite da Ipparco e Tolomeo si intuisce che, per formulare previsioni molto precise a 5000 anni di distanza, non bastano pochi secoli di osservazioni.
Il caso di Ipparco, considerato lo scopritore del fenomeno in questione, costituisce dunque un vero paradosso. Per capire come ciò sia avvenuto occorre andare un po' indietro nel tempo e ricostruire quel travaso di conoscenze che avvenne a partire dal VI secolo a.C. dalla cultura dei sacerdoti egizi e mesopotamici ai sapienti dell'antica Grecia, quali erano Solone, Talete, Pitagora e tanti altri.
Si cominciò così a creare una cultura laica, il cui scopo non era più quello di conoscere il carattere divino dei fenomeni, che dagli antichi sacerdoti venivano visti come manifestazione di volontà superiori, ma di applicare le capacità razionali dell'uomo per svelare l'ordine intrinseco delle cose.
Talete, dopo una visita in Egitto, in cui ebbe lunghi contatti con i sacerdoti locali, fu in grado di predire l'eclisse di sole del 28 maggio 528 a. C. mentre stava combattendo come mercenario nell'esercito del re Creso, ma non spiegò come avesse fatto a giungere a quella conoscenza, che necessita di molti anni osservativi.
Platone invece, raccontando nel Fedro e nel Crizia la storia di Atlantide e della sua fine, non nascose che Solone un secolo prima di lui aveva avuto la notizia dal sacerdote egizio Sonchis durante una sua visita a Sais. Se non fosse stato per Platone, oggi non sapremmo nulla di Atlantide, nemmeno il nome, poiché i sacerdoti che possedevano quella informazione non hanno lasciato nulla di scritto in proposito. Analogamente non hanno lasciato nulla di scritto su una quantità enorme di conoscenze che si tramandavano oralmente da generazioni e generazioni.
Non credo dunque che ci si possa basare su testimonianze scritte per conoscere qual era realmente il loro sapere. In Mesopotamia, considerata la culla dell'astronomia, dove una previsione sbagliata veniva pagata con una punizione capitale, hanno trovato una tavoletta d'argilla con la registrazione di una eclisse, avvenuta il 19 marzo 721 a.C.; questa viene ritenuta non solo la prima eclisse storicamente documentata ma anche la prima ad essere stata osservata con intento astronomico-predittivo. Ma i sacerdoti non pubblicavano le loro osservazioni e tanto meno su tavolette che erano state concepite per necessità amministrative.
Così deve essere accaduto presso i Maya. Anche nelle Americhe erano i sacerdoti a compiere le osservazioni del cielo e a trasmetterne la memoria per generazioni, secoli e millenni. Poi purtroppo il contatto dei conquistatori con le civiltà delle Americhe ha assunto il carattere devastante che conosciamo. La storia è ricca di queste iniziative distruttrici: l’incendio della biblioteca di Alessandria, la distruzione della cultura tibetana durante la rivoluzione culturale cinese, l'annientamento delle culture indigene da parte dei missionari cristiani in molti luoghi da loro visitati tra cui, per fare un unico esempio, l’isola di Pasqua con la perdita, fortunatamente non completa, delle importanti tavolette rongo rongo.
Per quale ragione nella storia dell'umanità è così comune il saccheggio con la devastazione della cultura del popolo conquistato? Da una parte c'è la volontà di annullare l'identità culturale, ma dall'altra c'è una presunzione assoluta di superiorità.
Un esempio eclatante dimostra come questo criterio è stato applicato non solo a popolazioni meno progredite incontrate dall'uomo moderno, ma anche alla sottospecie del genere Homo, l’Homo sapiens neanderthalensis, che qualche decina di migliaia di anni fa ha preceduto l'Homo sapiens sapiens: basta andare a vedere sull’atlante storico Zanichelli del 1996 la storia della evoluzione del genere umano. Questa storia è segnata da uno sviluppo della capacità cranica, e contiene una colossale mistificazione: l'Homo sapiens neanderthalensis notoriamente aveva in media una capacità maggiore dell'H. sapiens sapiens di circa 10 %, eppure è stato declassato ingiustamente sotto questo aspetto, facendolo figurare della stessa capacità dell’uomo attuale.
Nel caso dei Maya, probabilmente l'opera di degradazione della loro cultura è stata altresì determinata dalla incapacità generale di volerla e poterla conoscere a fondo. Spesso su di essa vengono espressi giudizi sommari che stanno ad indicare una cattiva informazione.
Anche se il materiale di cui disponiamo è veramente scarso, cercheremo di approfondire il nostro discorso sulle conoscenze che i Maya avevano del tempo.
L'era, della durata di 5125 anni, che si conclude il 21 dicembre del 2012 è stata preceduta da altre quattro ere, di durata poco inferiore. Queste cinque ere, comuni alle popolazioni che abitavano dal Messico al Perù, sono raffigurate simbolicamente al centro della mirabile Pietra del Sole degli aztechi, un monolite di basalto del peso di 25 tonnellate conservato nel museo archeologico di Città del Messico e riprodotto in copertina. Al centro è raffigurata la divinità che domina l'era attuale, Toniatuh, il dio Sole; egli ha la bocca spalancata per mettere bene in evidenza un coltello di ossidiana, col quale i sacerdoti aztechi compivano i sacrifici (gli amerindi non conoscevano la fusione dei metalli). Intorno, leggendo da destra a sinistra e dall'alto in basso compaiono le quattro divinità che hanno caratterizzato le ere precedenti: il giaguaro, il vento, la pioggia di fuoco e l’acqua. Bisogna tener presente che le loro divinità non sempre erano personalizzate come lo erano quelle greche o romane, che agivano come degli individui: esse erano perlopiù identificate con le varie grandi forze della natura, o anche un complesso di forze, le quali avevano assegnati periodi di tempo determinati per le loro azioni. Lateralmente in questo stesso giro compaiono due cuori trattenuti da artigli d'aquila.
Nel secondo giro troviamo le divinità che regolavano ciascuno dei 20 giorni componenti i 13 mesi dell'anno religioso o i 18 mesi dell'anno civile. Partendo dall'alto e procedendo in senso antiorario, abbiamo: coccodrillo, vento, casa, lucertola, serpente, morte, cervo, coniglio, acqua, cane, scimmia, erba divina, canna, giaguaro, aquila, avvoltoio, movimento, coltello di ossidiana, pioggia e fiore.
Nel terzo giro nascono raggi del sole che occupano anche il quarto giro, dove sono vari elementi che simbolizzano l'universo.
Il quinto giro è occupato quasi interamente da due serpenti dalle cui fauci, in basso, spuntano i volti del dio della guerra e del dio del sole, ovvero del cielo notturno e del cielo diurno. Tra le code dei due serpenti è scolpita la data dell'inaugurazione della pietra, avvenuta nel 1479 del nostro calendario. I corpi dei due serpenti sono infine circondati da numerosi piccoli cerchi, che rappresentano le stelle. È probabile che questa pietra, così ricca di significati simbolici, servisse ai sacerdoti per trarne indicazioni sul destino della comunità.
Ritornando al centro, alle cinque ere, abbiamo informazioni sulle loro caratteristiche dalle storie raccolte nel 1533 attingendo a varie fonti (sparse dal Messico al Perù) e conservate nel cosiddetto Codice latino-vaticano.
Ciascuna era è terminata con distruzioni. Nella prima, durata 4008 anni, vivevano uomini giganti. La dea dell'acqua Chalchiuhtlicue colpì questa umanità con una grande alluvione e la trasformò in pesci.
La seconda era durò 4010 anni; fu dominata da Ehecatl, il dio dell'aria dalla testa di serpente, che imperversò con forti venti ed uragani. Gli uomini superstiti furono trasformati in scimmie e trovarono rifugio sugli alberi.
La terza era fu governata dal dio del fuoco Tleyquiyahuillo e durò 4081 anni; alla sua fine tutte le case vennero incendiate da una pioggia di fuoco e di lava. Sopravvissero coloro che vennero trasformati in uccelli.
Nella quarta era, durata 5026 anni, si racconta che l'umanità venne sterminata da una carestia che seguì una pioggia di sangue e di fuoco.
Per quanto riguarda l'ultima era, l'attuale, essa è iniziata il 9 agosto del 3113 a.C. e avrà termine nel 2012, dopo 5125,37 anni. Il dio dominante è Toniatuh, considerato il dio del movimento.
Per quanto attiene alle durate di queste ere, è possibile che riflettano tempi reali e che il loro conteggio sia iniziato nel momento in cui questi popoli lasciarono l’Asia e misero piede per la prima volta sul nuovo continente 22250 anni prima del 2012, ovvero nel 20238 a.C.. Poiché non era ancora stato inventato un mezzo per spostarsi via mare, essi poterono compiere la loro migrazione via terra durante l’ultima puntata glaciale, quando lo stretto di Bering, profondo attualmente al massimo circa 50 metri, era emerso. Un'altra condizione favorevole era il fatto che, anche nel culmine della puntata glaciale, la zona dello stretto e delle terre adiacenti non sono state occupate dalla calotta di ghiaccio che ricopriva più ad ovest quasi tutta la Siberia e ad est il Canada e parte dell'Alaska. L’intervallo di tempo in cui il passaggio era emerso dal mare è ben definibile tra 25 e 15 mila anni fa, stando alla ricostruzione delle variazioni del livello del mare, riportate nella fig. 1. Nell'anno ipotizzato del passaggio la deglaciazione era già iniziata e il livello del mare era salito da -115 a -97 m rispetto allo zero attuale.
Immagino che, quando queste popolazioni di cacciatori lasciarono l’Asia e giunsero sul nuovo continente, avessero già, entro la loro cultura e le loro tradizioni, la convinzione che le grandi forze della natura concedano periodi di protezione e prosperità di lunga durata. Alla fine di ogni periodo c'era però da attendersi qualche calamità; allora il patto doveva o poteva essere sigillato con un'altra divinità.
Riflettendo sui motivi possibili per cui le prime tre ere hanno durate molto simili, comprese tra 4008 e 4081 anni, e che anche la quarta e la quinta era hanno durate simili tra di loro, anche se maggiori, farò alcune considerazioni, utili a formulare successivamente una ipotesi.
I popoli del Centroamerica hanno dimostrato di prestare grande attenzione verso i vari aspetti della natura; essi attribuivano molto valore al ripetersi ciclico degli eventi, credendo che le forze naturali si manifestano in tempi e con scadenze abbastanza regolari. L'osservazione fondamentale è senza dubbio l'alternarsi del giorno e della notte, caratterizzato dalla presenza del Sole e dalla sua assenza. Poi c'è la convinzione dell’esistenza di un ciclo immediatamente maggiore, composto da 20 giorni in cui dominano altrettante forze naturali (animate o inanimate secondo il nostro moderno modo di vedere), come abbiamo osservato nel primo giro della Pietra del Sole. L'impiego del numero 20 nella costruzione del lungo computo ci dimostra la valenza magica di questo numero, e altrettanto possiamo dire del numero 13, che troviamo non solo come caratterizzante del ciclo massimo del loro supercalendario ma anche del ciclo dell'anno religioso, composto da 260 giorni. Infine il terzo numero magico è il 18, impiegato per determinare la durata dell'anno civile di 360 giorni.
La somiglianza delle durate della quarta e della quinta era rende possibile che anche la quarta fosse regolata da un lungo computo. Ed inoltre è possibile che le prime tre ere fossero anch'esse regolate da un computo, sia pure un po' più breve, che risultasse dall'uso degli stessi tre numeri magici: 13, 18 e 20, ma con una diversa distribuzione. Occorrerà chiarire perché i Maya hanno sentito il bisogno di questo aumento di circa mille anni per il loro supercalendario.
L'ipotesi dunque è che siano stati creati due distinti lunghi computi, prima un computo A di 20x18x18x18x13 giorni e pari a 4151 anni per le prime tre ere, poi un computo B, che conosciamo, di 20x18x20x20x13 giorni, pari a 5125 anni, per le ultime due ere.
Ad eccezione dell'era attuale, che avrebbe dovuto terminare nell'anno previsto, le precedenti ere sono state più brevi di un valore tra 70 e 143 anni rispetto al computo che le regolava; ciò dovrebbe significare che per la fine della quinta era essi sapevano che cosa esattamente sarebbe successo e quando. Per le ere precedenti essi probabilmente sceglievano un evento o un momento particolare come conclusione, leggermente anticipata, del patto stilato con il dio dominatore di quell'era.
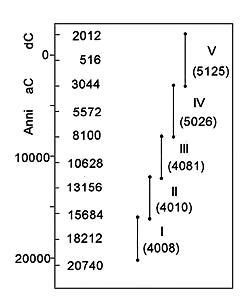
Figura 1 – I segmenti verticali e i relativi numeri tra parentesi indicano le estensioni temporali delle cinque ere dell’umanità nella tradizione popolare del Centroamerica. Sulla sinistra appaiono gli anni in cui sono stati calcolati i limiti di cicli naturali ricorrenti ogni 2528 anni.
Possiamo osservare questa successione di tempi nella Figura 1, dove le durate reali delle varie ere sono indicate tra parentesi, le durate teoriche sono rappresentate dai tratti verticali secondo l'ipotesi dei lunghi computi A di 4151 anni e B di 5125 anni, mentre a sinistra sono i tempi in cui terminano cicli di 2528 anni, che abbiamo già conosciuto nell’introduzione a proposito delle variazioni del livello marino durante l’ultima puntata glaciale (v. fig. 1). Non si può escludere che i cicli di 2528 anni non siano perfettamente uguali ma si alternino con due caratteri leggermente diversi, sicché avrebbe un significato obiettivo considerare un ciclo doppio, di 5056 anni, anziché uno semplice. Ma è possibile anche che l'accorpamento di due cicli soddisfi il bisogno dei Maya di approssimarsi il più possibile alla durata prestabilita di un supercalendario in uso fin dall’inizio della loro storia.
La decisione di cambiare il calendario deve essere stata presa durante la terza era; immagino che sia intervenuta dopo essersi accorti che il periodo di 4151 anni era troppo breve per stare al passo con il periodo di 5056 anni, col quale si manifestavano alcuni fenomeni osservati o forse un solo particolare tipo di fenomeno.
È possibile che la lunghezza di questo superciclo sia stata determinata con una precisione che è andata aumentando nel tempo, man mano che si succedevano diverse scadenze del ciclo di 2528 anni. Nella terza era l'incertezza di qualche anno non sarebbe stata comunque un ostacolo per decidere di passare dal lungo computo A a quello B, mentre invece nella quarta era vi sono state due occasioni, nell'8100 e nel 5572 a.C. per valutare con precisione la durata dei cicli e sapere quando sarebbe stato necessario fare iniziare la quinta era in modo che terminasse esattamente alla scadenza di un superciclo di 5056 anni.
Vedremo più avanti che nel 2012 in effetti dovrebbe avvenire la conclusione di un ciclo, caratterizzato da un periodo di 2528 anni, e che tale conclusione si accompagnerà a una complessa serie di fenomeni. Per diversi aspetti dovremo però considerare che il nuovo ciclo si manifesterà in modo sfumato, e questo particolare dovrebbe avere fatto decidere di scegliere come data di fine della quinta era il giorno del solstizio d’inverno, il più indicato a segnare l'inizio di un nuovo anno (e di un nuovo e più lungo periodo) in quanto il sole a mezzogiorno raggiunge la minima elevazione sull'orizzonte e da quel momento le giornate cominciano a diventare più lunghe.
Se dunque i Maya conoscevano questo ciclo della natura, sapevano che cosa poteva accadere alla fine della quinta era. Le parole mancanti del tempio di Tortuguero potrebbero riguardare perciò i fenomeni (o il fenomeno) che i Maya hanno osservato allo scadere dei cicli di 2528 anni.
Pur essendo difficile svelare la natura di tali fenomeni tramite i racconti popolari, faremo ugualmente per questa via un nuovo tentativo, dopo il Codice latino-vaticano, di sondare il passato che ci interessa. Sfoglieremo il libro del Popol Vuh, un testo che appartiene a uno strato culturale inferiore rispetto a quello che caratterizza il Codice latino-vaticano (e che perciò potrebbe contenere racconti con radici più profonde nel tempo).
Il Popol Vuh, il cui nome significa letteralmente “fogli scritti”, è il libro sacro del popolo Quiché di lingua maya del Guatemala, redatto intorno al 1550, una raccolta di miti che trattano della cosmologia e della storia dell'umanità. Esso non ha solo nel titolo analogie con la Bibbia. Comprende tre parti distinte.
Nella prima parte è descritta la creazione delle terre emerse e della vita animale e vegetale in un mondo dove prima esistevano solo cielo, mare, silenzio e tenebre. Quando la Creatrice e il Creatore si accorsero che gli animali appena creati non parlavano e non potevano né invocarli né adorarli, decisero di passare a una seconda fase, in cui vi fosse qualcuno che si rivolgesse a loro con riconoscenza. Plasmarono degli uomini con del fango, ma videro che essi non erano capaci né di camminare né di moltiplicarsi. Li sciolsero nell’acqua e modellarono altri uomini con il legno. Costoro furono capaci di popolare tutta la terra, ma, anche se erano dotati della parola, i loro visi rimanevano inespressivi: erano privi di sentimento.
Pertanto il loro destino era segnato; una grande alluvione si abbatté sugli esseri di legno: "un diluvio fu suscitato dal Cuore del Cielo... una pesante resina cadde dal cielo... la faccia della terra si oscurò, e una nera pioggia cadde su di essa, notte e giorno".
Come se questo non bastasse, animali e utensili si ribellarono agli uomini e li colpirono in volto. La storia della creazione si interrompe per un lungo tratto per raccontare quella di alcuni strani personaggi di carattere intermedio tra i creatori e gli uomini, che si combattono tra loro soprattutto per mezzo dell’astuzia e delle arti magiche. Essa riprende nella seconda metà del libro con la creazione definitiva dell’uomo, ovvero degli antenati quiché. Particolare curioso, i primi veri uomini erano in grado di vedere la realtà in modo del tutto simile a quello proprio degli dei; cosicché, quando questi se ne accorsero, velarono loro lo sguardo per impedire che si potessero mettere sullo stesso piano di chi li aveva creati. Vengono descritte quindi, nell’ultima parte, le generazioni che dall’inizio della civiltà si sono succedute popolando la regione quiché.
Sono le diversità rispetto alle storie più precise e più colte riunite nel Codice latino-vaticano a farmi ritenere che la grande alluvione di cui parla il Popol Vuh corrisponda non a ciò che pose fine alla prima era ma a un evento di carattere globale, precedente la migrazione di questa popolazione dall'Asia, che per la sua catastroficità è rimasto impresso nella memoria di tutta l'umanità. Non tutti i disastri producono questo effetto. Pensiamo per esempio alla scomparsa di Atlantide, che non ha costituito un ricordo collettivo e della quale, se non fosse stato per le citazioni di Platone, non sapremmo nulla.
Insomma, che cosa ci trasmettono i Maya? Ci informano che vi è un momento particolare in cui la natura si comporta diversamente dal solito e che ritorna dopo un periodo costante. Quindi rappresenta un motivo di riflessione.
Per il momento lasciamo le cose in sospeso. Le riprenderemo quando avremo le idee più chiare su quali eventi naturali possono essere in agguato alla fine del 2012. Dal momento che oggigiorno si parla di catastrofi di ogni entità (molti temono una fine del mondo), procederemo per gradi, scegliendo di partire dalle più devastanti, per esaminare successivamente quelle di impatto minore.
La fine del mondo
Fine del mondo è un'idea ossessiva che, più che derivare da una conoscenza della realtà della natura che ci circonda, proviene dal senso di inadeguatezza e da un inconscio desiderio di morte. Nasce da incapacità di vivere pienamente la vita o da un senso di colpa originati da presunti peccati commessi dall'umanità. È sufficiente leggere l'apocalisse di Giovanni, in cui la vita è intesa come lotta contro il male, anziché vederla come progressivo affinamento delle qualità umane. Si può vivere con la paura continua di fare incollerire l'Entità suprema? Nell'Antico Testamento l'ira di Dio è citata 158 volte. Un po’ troppe in verità.
Ho l'impressione poi che quando si parla di fine del mondo si pensi esclusivamente alla fine del genere umano. Non ci si cura che possano rimanere altri mammiferi, rettili, pesci, insetti e batteri. In fondo la vita degli altri esseri è stata e continua ad essere intesa come puramente finalizzata alla sopravvivenza dell'uomo. Se sparisce l'uomo, finisce tutto. Altro che sentirsi parte della natura!
Qualcuno crede che la fine della Terra avverrà quando il Sole si spegnerà: in effetti la vita sul nostro pianeta è possibile solamente grazie all'energia che il Sole ci fa pervenire. Ma lo studio sulla evoluzione stellare ci avverte che non sarà proprio così, poiché prima che il Sole si spenga dovrà transitare attraverso la fase di stella gigante, come è accaduto a Capella nella costellazione dell’Auriga.
Il passaggio avviene a circa nove decimi della vita di una stella che abbia la massa del Sole, allorché si è completata la trasformazione di idrogeno in elio nel nucleo; l’intera massa, non più sostenuta dal calore che si opponeva alle forze gravitazionali, comincia a contrarsi per la seconda volta nella sua esistenza, trasformando energia gravitazionale in calore. La maggiore temperatura raggiunta innesca una fusione di idrogeno rimasto nella parte inferiore dell’involucro esterno, e ne deriverà altro calore, il quale farà espandere enormemente questo involucro. Nel caso del Sole si prevede che l'espansione si spingerà fino all’orbita di Mercurio. Anche se la temperatura alla superficie della stella si abbasserà sensibilmente, il calore sulla Terra sarà insostenibile.
Ma prima di arrivare alla fase di gigante rossa il genere umano probabilmente sarà già estinto da tempo poiché al Sole, così come si presenta oggi, viene attribuita ancora una durata di 4,5 miliardi di anni. A questa stima si è arrivati supponendo che il Sole e la Terra abbiano la stessa età e che il Sole si trovi a metà della sua esistenza. In realtà sussistono motivi per ritenere che il Sole sia più vecchio del sistema che gli gira intorno e che di conseguenza la sua vita sarà più lunga di quanto viene valutata.
Finora ho accennato a una fine del mondo intesa come estinzione della vita sulla Terra, ma esiste una reale possibilità di una fine che riguarda anche l'integrità del nostro pianeta; è estremamente improbabile, ma non impossibile. Si tratta dell'impatto con un corpo dotato di una grande quantità di moto (cioè di grande massa e grande velocità) proveniente dall'esplosione di una supernova, appartenente alla nostra galassia, che lasci come residuo una stella di neutroni.
L'esplosione come supernova di questo tipo è la sorte comune a tutte le stelle che hanno una massa pari ad almeno 2÷3 volte quella del nostro sole. Le fusioni nucleari che si svolgono al suo interno coinvolgono elementi sempre più pesanti; parallelamente i valori della temperatura aumentano fino a quando si creano il ferro e gli elementi del gruppo del ferro, come nichel, cobalto. Poiché la fusione del ferro si attua assorbendo energia, inizialmente la fusione avviene grazie alla formazione di elementi più leggeri negli involucri superiori, ma poi il calore prodotto da queste fusioni non riesce più a compensare quanto viene assorbito dalla fusione che continua nel nucleo. La stella implode improvvisamente in maniera superveloce mentre la materia della parte più interna si compatta in una massa costituita unicamente da neutroni; la parte più esterna, dopo essere collassata, rimbalza verso l’esterno e proietta nello spazio la sua materia a velocità di decine di migliaia di kilometri al secondo.
Che cosa emette una supernova? Gas e, in più, frammenti solidi soprattutto di ferro, anche di notevole volume. Ne consegue che il rischio di essere colpiti è assai remoto ma non impossibile.
Nella nostra galassia esplode qualche supernova ogni secolo. La più vicina delle possibili candidate è Betelgueuse della costellazione di Orione, una delle stelle più luminose del cielo; è una supergigante rossa distante 650 anni luce. Non è possibile prevedere quando esploderà, ma potrebbe averlo già fatto, dato che questa informazione viaggia alla velocità della luce e perciò noi lo verremmo a sapere dopo 650 anni.
La distanza ha ovviamente un grande peso sulla probabilità di venire colpiti da frammenti espulsi dalla stella. Ma anche qualora vedessimo Betelgueuse esplodere trascorrerebbe molto tempo prima che i suoi frammenti possano raggiungerci. Per quanto riguarda gli eventuali frammenti provenienti da altre supernove esplose nel passato, è da tenere presente che esse sono lontane migliaia di anni luce, per cui diventa sempre meno probabile diventarne un bersaglio. Se vogliamo vedere frammenti di supernova non dobbiamo fare altro che andare in uno dei tanti musei di storia naturale presenti nelle grandi città, dove sono esposte meteoriti ferrose.
Per comprendere meglio come si può concepire un disastro che possa fare esplodere la Terra, bisogna che prendiamo in esame la questione di come è nato il nostro sistema solare, seguendo però un'ottica differente da quella comunemente diffusa. L'opinione più condivisa è che il Sole e i pianeti si siano formati dall'aggregazione di gas e polveri che popolavano un'ampia regione dello spazio. Durante il processo di aggregazione dovuto a forze di attrazione gravitazionale sarebbero rimasti indietro gli asteroidi, che sono dispersi in una fascia intermedia tra le orbite di Marte e Giove e vengono comunemente ritenuti un pianeta mancato a causa delle forti interazioni di Giove. Si tratta di circa un milione di corpi, di cui solo un decimo è stato catalogato e 220 sono più grandi di 100 km. Il maggiore ha circa 1000 km di diametro.
Purtroppo la teoria dell’aggregazione non riesce a spiegare il fatto che tutti questi oggetti hanno subito una fusione e che in alcuni di essi sono evidenti segni di intimo mescolamento e di un rapido raffreddamento; né può chiarire perché la massima parte di essi sono formati da rocce silicatiche mentre altri sono costituiti da ferro e nichel puri.
Se l’aggregazione fosse rimasta bloccata a un certo punto, non si potrebbe spiegare la presenza di grossi blocchi metallici di ferro e nichel, che non possono essersi aggregati a freddo. E anche ammettendo che si fossero aggregati a caldo, non avrebbero potuto essere costituiti da metalli del gruppo del ferro puri.
L’ipotesi più verosimile è che gli asteroidi costituissero inizialmente un pianeta simile alla Terra, che chiameremo Aster, situato in una posizione intermedia tra Marte e Giove; esso sarebbe stato colpito poi da un grande frammento di ferro espulso da una supernova. Pianeta e blocco di ferro si sono frantumati. I frantumi più grossi sono schizzati in giro per il sistema solare a colpire altri pianeti o a mettersi in orbita attorno a loro. La Luna è uno di questi frammenti. Un altro grosso frammento di Aster ha colpito un undicesimo pianeta, che viaggiava sull’orbita più esterna e che potremo chiamare Com. Era l’ultimo pianeta, composto in grandissima parte di ghiaccio. Ne sono derivate le comete, per la maggior parte distribuite in quella che viene chiamata fascia di Kuiper, tra 30 e 100 UA (unità astronomiche, pari alla distanza Sole-Terra), cioè oltre l’orbita di Nettuno, mentre ve ne sono alcune, quelle di lungo periodo, che arrivano a distanze molto maggiori. Nella fascia di Kuiper ci sono 10 oggetti di diametro di almeno 900 km; Plutone è uno di essi e, con i suoi 2320 km di diametro, non è nemmeno il più grande. Plutone non è perciò da considerarsi un pianeta, bensì un frammento del pianeta originario. Sono catalogati finora quasi un migliaio di oggetti, ed hanno la stessa natura delle comete.
Possiamo riconoscere quali satelliti sono derivati da Aster e quali da Com semplicemente osservando i valori delle loro densità: mentre per la Luna, i due satelliti di Marte, due di Giove e due di Saturno le densità sono di almeno 2,9 g/cm3, le densità degli altri satelliti variano da 1,13 a 2,09 g/cm3. Pertanto i primi sono composti da rocce silicatiche come la Terra, mentre gli altri consistono in una mescolanza di rocce silicatiche e ghiaccio. Un altro criterio di distinzione può trovarsi osservando l’albedo: i corpi derivati dalla disgregazione di Com dovrebbero avere una superficie più riflettente per la rilevante presenza di ghiaccio; è quanto accade infatti per Eris, il gemello di Plutone.
Ritornando agli asteroidi, se essi risultano dall'impatto tra un pianeta e un grande frammento di supernova, possiamo ipotizzare che l'esplosione della stella sia avvenuta a breve distanza dal Sole, e che, poco prima della disavventura capitata ad Aster e Com, un altro o altri grandi frammenti abbiano colpito il Sole strappandone brandelli che, finiti in orbita, sono diventati pianeti. L’ipotesi è grandemente confortata dal fatto che Mercurio conserva al suo nucleo una rilevante parte di ferro, che ne costituisce l'80 % della massa; è un’ipotesi che tuttavia non riscuote un grande consenso: le viene preferita di gran lunga la teoria dell’aggregazione di gas e polveri, che però non regge alle critiche elementari già esposte. È immaginabile il motivo di tale preferenza: l’impatto del Sole con proiettili lanciati da una supernova presenta un carattere altamente catastrofico, e constatiamo così ancora una volta quanto duratura sia l’influenza di Lyell.
Le meteoriti
La distruzione per impatto dei due pianeti Aster e Com ha disseminato il sistema solare di frammenti delle più svariate dimensioni. Parecchi sono andati subito ad impattare in grande numero gli altri corpi del sistema. Poi col trascorrere del tempo la sassaiola si è diradata. Le tracce più significative le troviamo sulla Luna, dove possiamo osservare anche impatti che risalgono ai tempi più remoti.
Le tracce riscontrabili sulla Terra di questi particolari corpi del sistema solare sono quasi tutte dovute ad asteroidi. Sul nostro pianeta sono stati individuati oltre 170 crateri dovuti all'impatto di meteoriti. In genere le dimensioni vanno da un centinaio di metri a un centinaio di kilometri, con una media di una decina di kilometri. Il maggiore cratere da impatto si trova in Sudafrica: ha un diametro di 300 km circa e la sua età è di oltre 2 miliardi di anni. Il più noto è un cratere di 1200 m di diametro formato in Arizona appena 50 mila anni fa e conservato perfettamente grazie al clima arido locale. Si è calcolato che la meteorite che l'ha prodotto, di natura ferrosa, doveva avere un diametro di 25÷30 m.
Con quale frequenza cadono le meteoriti? In base al numero dei crateri scoperti sulla Terra, si stima che ogni milione di anni si formino da uno a tre crateri con un diametro maggiore di 30 km. Vi sono crateri vecchi solo di qualche migliaio di anni che raggiungono 14 ÷ 29 km. L'atmosfera ci protegge da asteroidi con diametro inferiore ad una decina di metri, che sublimano prima di arrivare a terra.
Le tracce lasciate dalle comete sul nostro pianeta sono rare, principalmente perché la fascia delle comete è molto più lontana rispetto a quella degli asteroidi e poi perché la loro composizione rende molto veloce il dissolvimento per il calore sviluppato con l'attrito nell'atmosfera o per l'impatto con la superficie.
Possiamo attribuire a una cometa quanto è avvenuto nel 1908 in una regione disabitata del fiume Tunguska in Siberia. Una fragorosa esplosione nell’atmosfera, udita fino a 1000 km di distanza, si è verificata ad un’altezza compresa, secondo le stime, tra 5 e 10 km; l'effetto è stato l'abbattimento di 60 milioni di alberi in un’area di oltre 2000 km2. La notte successiva all'esplosione, sull'Europa il cielo era rischiarato da una luce diffusa, segno che nella parte alta della troposfera erano state disseminate minute particelle. L'area è stata visitata per la prima volta 20 anni dopo l'evento senza che si trovassero tracce materiali sul terreno. Recenti ricerche hanno individuato a distanza di 8 km dal centro dell'esplosione un cratere di 500 m di diametro, attribuito all'impatto di un oggetto il cui diametro è stato stimato di 5 m, che viaggiava a una velocità, bassa, dell'ordine di 1 km/sec.
Sulla natura della meteorite di Tunguska, asteroide o cometa, non esiste una interpretazione unanime. La mia opinione è che si trattasse di una cometa con un blocco roccioso al centro, il quale, subito dopo l'esplosione di Com, ha costituito un nucleo di aggregazione di frammenti più minuti di roccia e ghiaccio. È possibile che, nell’attraversare la nostra atmosfera, il calore sviluppato abbia fatto evaporare la fase di ghiaccio e portato i frammenti rocciosi a saldarsi, costituendo un involucro dal quale la fase di vapore del ghiaccio rimasto più internamente, ad un certo momento, non avrebbe più trovato vie di sfogo. Un ulteriore calore prodotto e diffuso all’interno avrebbe portato la fase di ghiaccio in una condizione di vapore surriscaldato, raggiungendo pressioni sempre più alte, fino ad esplodere.
Qualora le meteoriti avessero l'intelligenza di cadere in zone disabitate le preoccupazioni sarebbero minori, ma purtroppo non è così, per cui in futuro si potrebbe verificare qualcosa non molto dissimile dalla trama del film Armageddon. Per fortuna gli avvistamenti di possibili candidati all’impatto avvengono con diversi anni di anticipo, come è accaduto nel 2003, quando si paventò il rischio che nel 2029 la Terra venisse colpita da Apophis, un asteroide di quasi 300 m di diametro. Nel dicembre 2003 la probabilità dell'evento era stimata 1/40, poi, man mano che veniva meglio definita l'orbita, è passata a 1/40000 nell'agosto 2006 e 1/233000 nell'ottobre 2009.
I timori delle conseguenze di impatti di meteoriti di grandi dimensioni sono cresciuti da quando si è cominciato a mettere in relazione la scomparsa abbastanza rapida dei grandi dinosauri, 65 milioni di anni fa, con l'impatto di un asteroide. Il ritrovamento di una struttura sepolta nel golfo del Messico, che rappresenta un cratere avente un diametro di 180 km, ha fatto ritenere che potesse essere la prova decisiva di una serie di illazioni in merito. Tuttavia vi sono delle osservazioni che non lo confermano. La prima osservazione è che, nell'area circostante il cratere, si trovano tracce di questo impatto sotto forma di sferule dovute alla fusione di piccole parti di materiale e distribuite su un ben determinato livello; tra il livello con sferule e il limite superiore del Cretacico, dove è avvenuta la grande estinzione, ci sono diversi metri di sedimenti, che corrispondono a un intervallo stimato di 300 mila anni. La seconda osservazione è ancora più interessante perché l'analisi delle specie di organismi subito sotto e sopra tale livello indica che il numero delle specie è rimasto invariato: 52 prima e 52 dopo. Ciò sta a significare che l'impatto di una grande meteorite come quella dello Yucatan non ha le capacità distruttive addebitate solitamente a questo tipo di evento.
Anche le particolari abbondanze di iridio trovate al limite superiore del Cretacico di una serie sedimentaria dell'Umbria non rappresentano una prova a favore dell’impatto di una meteorite poiché, pur essendo vero che a quel punto della serie c'è un picco molto pronunciato di valori, è anche vero che abbondanze anomale dello stesso metallo si ritrovano anche alcuni centimetri al disotto. Questa situazione avvalora quindi l'ipotesi di un inquinamento globale avvenuto per altre cause, considerando che l'iridio non si trova con una particolare concentrazione solo nelle meteoriti (e in certe meteoriti, cioè quelle composte principalmente da ferro) ma anche nelle emissioni dei vulcani.
Prima di entrare maggiormente nel merito di questo nuovo argomento, è opportuno cercare di ampliare il panorama prendendo in esame tutti quegli analoghi eventi catastrofici che vanno sotto il nome di “grandi estinzioni di massa”.
Estinzioni di massa
Nel passato geologico si sono succedute diverse estinzioni di specie animali in contemporanea, che inducono a pensare a cause ostili alla sopravvivenza. Tuttavia non tutte le estinzioni sono state rilevanti in uguale misura, e possiamo distinguere tre livelli di importanza, dei quali il terzo sarà discusso in un prossimo capitolo. Al primo livello appartiene un numero ristretto di eventi, durante i quali è sparito mediamente il 40 % dei generi della fauna marina. Alcune di tali maggiori estinzioni sono avvenute alla fine del Cretacico, del Permiano, dell'Ordoviciano e nel Vendiano medio, cioè circa 65, 251, 442 e 600÷650 milioni di anni fa. Possiamo osservare che esse sono avvenute a distanze alquanto regolari di circa 185, 190 e 160÷210 milioni di anni, seguendo uno dei tanti ritmi che hanno caratterizzato l'evoluzione geologica del pianeta; questo particolare ci induce a pensare che esse siano accomunate da una stessa causa.
La traccia da seguire per chiarire la natura di tale causa è l'alta concentrazione di iridio che si rinviene nei sedimenti proprio al limite superiore del Cretacico, 65 milioni di anni fa. È da scartare l'idea che questo particolare sia dovuto alla caduta di una meteorite per le ragioni anzidette. Come accennato, le eruzioni vulcaniche hanno concentrazioni di iridio altrettanto anomale, in particolare le eruzioni alimentate da zone profonde del mantello. È proprio indagando in questa direzione che troviamo interessanti coincidenze tra le maggiori eruzioni basaltiche e le maggiori estinzioni di massa. Non può essere un caso che la massima estinzione in assoluto, quella della fine del Permiano, quando si sono estinte il 96% delle specie che vivevano negli oceani e il 70 % dei vertebrati dei continenti, sia accaduta in coincidenza dell’acme di emissione delle lave del più imponente espandimento basaltico conosciuto; esso è accaduto in Siberia in un breve intervallo di tempo intorno al passaggio Permiano-Triassico, e l’emissione lavica a cui appartiene ha raggiunto complessivamente il volume record di 2,5 milioni di km3.
L'estinzione della fine del Cretacico, con il 65 % di specie scomparse, è avvenuta in corrispondenza di un’altra grande emissione basaltica, nel Deccan, in India, di oltre 500.000 km3, che ha costituito il maggiore evento vulcanico degli ultimi 200 milioni di anni. Il culmine di questa attività, durato circa 10 mila anni, si colloca proprio al limite superiore del Cretacico.
Altre due grandi estinzioni, intervenute verso la fine del Triassico, e precisamente alla conclusione dei piani Carnico e Norico, sono avvenute contemporaneamente a espandimenti basaltici: uno nel bacino del Paranà e un altro nel Karroo, in Sudafrica, con volumi emessi di alcune centinaia di migliaia di kilometri cubi.
Nei brevi intervalli di tempo in cui queste attività vulcaniche effusive si sono protratte, sono state immesse nell'atmosfera e nell'idrosfera quantità ingenti di metalli pesanti tra cui l'iridio, che possono avere avvelenato il ciclo alimentare naturale.
A un secondo livello di importanza appartiene un più folto numero di estinzioni, le quali hanno interessato mediamente il 10% circa dei generi. Più difficile è conoscere in quale percentuale sono scomparse le specie, che comunque è notevolmente superiore poiché sono rimaste coinvolte anche numerose specie dei generi sopravvissuti.
Anche le estinzioni di questo livello meritano l’appellativo di estinzioni di massa, generalmente riservato a quelle del primo livello, dato che, quando si realizzano, gli individui di tutte le specie subiscono una più o meno elevata riduzione di numero.
Similmente per questo gruppo di secondo livello possiamo pensare a una causa comune, considerando che uno studio recente ha messo in evidenza una ricorrenza delle estinzioni, con un periodo di 11 milioni di anni.
Grandi innalzamenti del mare
Per comprendere il significato di tale ricorrenza possiamo esaminare quanto è successo l'ultima volta che si è verificato un evento che ha modificato notevolmente le condizioni di vita sulla Terra nell'arco di tempo rappresentato dagli ultimi 11 milioni di anni.
L'evento più significativo è avvenuto nel mar Mediterraneo, dove tra 6 e 5 milioni di anni fa si è verificata la cosiddetta “Crisi di salinità del Messiniano”, cioè dell’ultima età del Miocene. Per un periodo di circa un milione di anni il Mediterraneo è rimasto isolato dall’Oceano Atlantico trasformandosi in un grande bacino endoreico, come attualmente è il Mar Caspio; poiché all’epoca l’evaporazione prevaleva nettamente sugli apporti meteorologici e fluviali, come succede al giorno d’oggi, il livello del mare si è abbassato di circa 3 km. Una misura degli effetti si ha considerando che la valle del Nilo all’altezza de Il Cairo ha subito un approfondimento di 2400 m.
Nelle parti in cui le acque sono rimaste, i sali contenuti si sono concentrati fino a raggiungere condizioni di saturazione per poi precipitare, dando origine a depositi evaporitici di grande spessore, formati da salgemma e, soprattutto, gesso.
Alla fine del periodo di crisi di salinità, sui depositi evaporitici si sono sedimentati, senza gradualità ma con uno stacco netto, depositi contenenti microfossili tipici di acque molto profonde e attribuibili alla base del Pliocene. Perciò il ripristino della comunicazione tra il mare Mediterraneo e l'oceano Atlantico deve essere stato un evento estremamente rapido, non graduale.
Durante l’ultima puntata glaciale, all’incirca tra 27500 e 12500 anni fa, un fatto analogo, ma a scala più ridotta, è accaduto al mar Nero, rimasto isolato dal Mediterraneo. Oltre a una differenza di dimensioni del fenomeno, è avvenuto anche un meno sensibile abbassamento di livello, cosicché non si sono raggiunte le condizioni per la formazione di evaporiti. Quando poi si è ripristinata la comunicazione tra i due mari, il ritorno al precedente livello deve essere stato piuttosto graduale. Tuttavia, secondo alcuni autori, le aree abitate al disotto del livello definitivo sarebbero state sommerse ugualmente in modo drammatico, alimentando la leggenda del famoso diluvio biblico. All’origine di quanto accaduto all’area del Mar Nero c’è stato un abbassamento del livello del Mediterraneo fino a una quota di 115 m inferiore all’attuale, causato dalla formazione di calotte di ghiaccio su buona parte delle aree continentali dell’emisfero settentrionale.
Ma per il Mediterraneo di 6 milioni di anni fa le cose sono andate ben diversamente poiché i fenomeni glaciali, ammesso che ci siano stati, si sono verificati in misura assai più contenuta rispetto all’episodio citato per il Mar Nero. Pertanto l'avvio e la conclusione della crisi di salinità del Mediterraneo ha costituito fin dall’inizio un grosso enigma.
Si è ipotizzato che la soglia di Gibilterra si sia creata solo alla fine del periodo di crisi; prima, gli scambi con l’oceano sarebbero avvenuti tramite una soglia, presente o nel sud della Spagna o nel nord del Marocco, la cui profondità sarebbe diminuita fino ad annullarsi intorno a 6 milioni di anni fa. In sostanza il problema è stato risolto con movimenti della crosta terrestre, che dapprima hanno limitato e poi ripristinato le comunicazioni marine. Si tratta di movimenti assolutamente locali, che casualmente avrebbero prodotto gli effetti descritti: sarebbero potuti intervenire in qualsiasi altro momento o non intervenire mai.
Il quadro della situazione è più complesso poiché la crisi di salinità del Mediterraneo insieme alla questione della soglia tra Atlantico e Mediterraneo nasconde un fenomeno che si manifesta ogni 11 milioni di anni e non ha soltanto un valore locale. Infatti, se andiamo indietro di 11 milioni di anni partendo dal limite tra Miocene e Pliocene, arrivando così a 16 milioni di anni fa, troviamo il limite inferiore di un’altra importante età del Miocene, il Langhiano, che presenta due aspetti di grande rilievo: inizia con una imponente ingressione marina sui continenti, la cosiddetta “trasgressione langhiana”, abbinata a una notevole estinzione di massa, la “estinzione del Miocene medio”. Ci si è infatti accorti che, quando l’ingressione del mare è stata riassorbita, risultava scomparso il 10 % delle specie di mammiferi.
Se andiamo ancora indietro nel tempo incontriamo un’altra importante trasgressione, quella dell’Aquitaniano, la cui età purtroppo è di difficile determinazione, ma ci rivela in compenso un particolare prezioso, poiché è preceduta da una forte regressione del mare, nella parte finale del Cattiano. Retrocedendo ancora, si incontrano altre tre analoghe trasgressioni, che si succedono a distanza di 11 milioni di anni l’una dall’altra: quelle che caratterizzano gli inizi di Priaboniano, Luteziano e Thanetiano.
La trasgressione del Langhiano ha permesso di rilevare una correlazione tra l’invasione dei mari sui continenti e le estinzioni del secondo livello, in quanto avvengono contemporaneamente e si ripetono ogni 11 milioni di anni. Giudicando dalle intensità delle estinzioni, che appaiono molto simili tra di loro, assai probabilmente anche le trasgressioni possono essersi realizzate con stesse modalità e stesso grado di sviluppo. Pertanto, quanto si è verificato tra il Cattiano e l’Aquitaniano dovrebbe essere avvenuto ad ogni limite stratigrafico considerato, e si può dunque concludere che ogni 11 milioni di anni il mare ha subito una regressione di grande rilievo e, subito dopo, una più importante trasgressione. Considerando che durante il Cattiano le temperature globali erano nettamente superiori a quelle dei nostri giorni, non è pensabile che la regressione avvenuta alla chiusura di questa età sia da addebitare a fenomeni glaciali. La situazione ricorda quella incontrata a proposito della crisi di salinità del Messiniano, quando si tentava di spiegare l’isolamento del Mediterraneo dall’Oceano Atlantico senza riuscire a trovare altra spiegazione che movimenti tettonici in grado di chiudere le comunicazioni, poiché non sussistevano elementi per affermare che l’Atlantico si poteva essere abbassato indipendentemente da fenomeni glaciali.
Ciò non significa che non si siano verificati affatto movimenti tettonici, altrimenti non potremmo spiegare come mai negli ultimi 200 milioni di anni la crisi di salinità sia avvenuta soltanto nel Messiniano. Ma sicuramente essi si sono aggiunti a un altro evento, che ora stiamo cercando di precisare.
Se il Langhiano e gli altri piani considerati iniziano con una grande trasgressione del mare, anche il Pliocene dovrebbe avere subito la stessa sorte. È assai riduttivo intendere per “grande trasgressione” un aumento del livello di tutti i mari di 300-400 m, come ad esempio si ritiene comunemente sia avvenuto per l’intera durata del Pliocene. Ci troviamo di fronte a eventi catastrofici che hanno provocato estinzioni di massa, cosicché dobbiamo supporre episodi improvvisi, più imponenti e di durata talmente breve che le tracce rimaste risultano scarse. L’innalzamento del livello dei mari deve essere stato di circa 1000 m. E con buona probabilità la cifra è arrotondata per difetto!
Mille metri non sono suggestivi solo di una realtà catastrofica ma anche di un modo sconvolgente di pensare. Sia Lyell che Hutton sarebbero profondamente adirati. Altro che diluvio biblico! È un’idea non praticabile. Per fare aumentare di 1000 m il livello degli oceani bisogna supporre che la Terra sia diminuita, e non poco, di dimensioni. Tutti sanno come è composta la Terra: è praticamente incompressibile. E anche se immaginassimo un minimo di compressibilità, perché dovrebbe farlo?
La risposta è semplice: perché l’ha già fatto.È molto strano quello che succede o, meglio, non succede quando la natura offre su un piatto d'argento un panorama inequivocabile, e chi rappresenta la scienza si sforza in tutti i modi di equivocarlo. Vediamo di che cosa si tratta.
Durante l'Ordoviciano, 450 milioni di anni fa, da metà a due terzi delle terre oggi emerse, a seconda degli autori, erano sommerse dalle acque del mare. Durante il Cretacico, 90 milioni di anni fa, è accaduto il medesimo fenomeno. Come è stato possibile? Non possiamo invocare scioglimenti e formazioni di calotte glaciali perché qualora tutti i ghiacci fossero sciolti, il livello del mare si porterebbe circa 60 m più in alto della attuale posizione. Qui invece si deve pensare a un livello del mare che stesse almeno 1000 m più in alto di oggi.
Soprattutto sarebbe errato ritenere che fossero le terre 1000 m più in basso. Questo tipo di ragionamento può valere in aree ristrette, dove in effetti è difficile dire a priori se una traccia del mare al disopra del livello marino odierno sia dovuta a uno spostamento verticale della superficie marina o della terra. Quando al contrario sono coinvolti interi continenti, si ha a che fare con equilibri isostatici legati alla densità delle rocce che compongono le croste dei continenti e il loro substrato: i continenti galleggiano su tale substrato, che è crosta di tipo oceanico, come bastimenti a stazza fissa poiché la differenza di densità è netta. Per questa ragione la posizione media del fondo degli oceani sarà sempre e nella stessa misura più in basso rispetto all’altezza media dei continenti. Quindi, se nell’Ordoviciano le acque degli oceani hanno invaso la maggior parte delle aree continentali, significa che gli oceani non hanno ridotto la loro profondità ma si sono ridotti di estensione. La tettonica delle placche ci informa che una riduzione degli oceani è possibile, ma non ammette che possa succedere per tutti gli oceani contemporaneamente: mentre un oceano si apre un altro si deve chiudere, in modo che la superficie complessiva rimanga costante. Non si vuole ammettere, per principio, che la Terra possa variare di dimensioni.
Struttura della Terra
Ammettere questo significherebbe riconoscere altresì che il modello della struttura della Terra va rivisto poiché, così com'è, non consente sensibili variazioni di volume: si ritiene che i materiali costituenti della Terra siano praticamente incompressibili e indilatabili, soprattutto il nucleo, composto completamente di ferro.
L'idea di un nucleo di ferro è cruciale per i nostri ragionamenti. Essa è nata in seguito alla scoperta che a 2883 km di profondità le onde sismiche che attraversano la Terra presentano un brusco cambiamento di velocità: è la discontinuità di Gutenberg. Un primo passo è stato quello di stabilire che l’aumento di velocità può essere attribuito al passaggio da materiali con densità 5,5 a materiali con densità di 9,5 ÷ 10 g/cm3.
Il passo successivo è stato cercare di giustificare questi valori così diversi di densità. Poiché il centro della Terra è insondabile direttamente, è sembrato naturale osservare la diversità di composizione delle meteoriti, che nella massima parte sono costituite da rocce simili a quelle che si trovano sulla superficie della Terra mentre in una parte minore sono costituite da ferro e nichel; le rispettive densità sono di 2,7 e 7,9 g/cm3. A quel tempo evidentemente prevaleva l'idea che le meteoriti derivassero dalla disintegrazione di un pianeta, mentre oggi prevale l'idea di una aggregazione di particelle che fluttuavano nello spazio prima della formazione del sistema solare.
Con il miglioramento delle conoscenze e in particolare delle tecniche sperimentali di laboratorio, ci si è accorti che, alle pressioni esistenti dove si trova la discontinuità di Gutenberg, la densità dei materiali silicatici della base del mantello può effettivamente eguagliare il valore supposto di 5,5 g/cm3, mentre il ferro del nucleo esterno dovrebbe presentare una densità di 11,8 g/cm3, ben maggiore di quella derivata dalla sismologia.
Ci si è sentiti allora in obbligo di giustificare questo difetto di densità supponendo che il ferro del nucleo si debba trovare mescolato con un po’ di zolfo o un po’ di ossigeno o di silicio. Non ci si avvedeva del graduale allontanamento dalla realtà che aveva ispirato all’origine il modello. Sarebbe stato molto più semplice abbandonare l’idea di un nucleo esterno costituito da ferro, e tutto si sarebbe risolto.
Non si è poi considerato che una caratteristica della struttura dei minerali è di subire piccoli collassi in corrispondenza di certi valori di pressione. Se pensiamo a un collasso delle strutture cristalline più consistente, è quanto potrebbe accadere a 2883 km di profondità. Al passaggio dal mantello al nucleo ci sarebbe dunque non un cambio della natura del materiale bensì un cambiamento della sua struttura.
Occorre pensare cioè che la parte esterna del nucleo sia composta dalla stessa materia del mantello che la sovrasta, ma in uno stato superaddensato. Questo assunto è giustificato anche dal fatto paradossale che il materiale che occupa la parte immediatamente sottostante alla discontinuità di Gutenberg si comporta in modo più compressibile di quanto non faccia il materiale della base del mantello, proprio come accade ai materiali che subiscono per la prima volta determinati incrementi di pressione.
Con questo nuovo modello della struttura della Terra, manca ora un ingrediente fondamentale per spiegare le variazioni di volume della Terra: questo ingrediente consiste in un cambiamento della forza di gravità, senza il quale non ha senso coniugare compressibilità e cambiamenti di dimensioni.
Immaginiamo che il coefficiente G che compare nell'equazione di Newton per determinare la forza di attrazione tra due masse in gioco poste a una determinata distanza, comunemente chiamato “costante” di gravitazione universale, diminuisca. Per avere il passaggio da materia addensata del mantello a materia superaddensata del nucleo, troveremo che la pressione necessaria non si trova più a 2883 km di profondità ma poco più in basso, supponiamo 1 km più in basso. In quello spessore di 1 km la materia passerà automaticamente da una densità di circa 10 a una di 5,5 g/cm3, raddoppiando quindi il proprio volume e obbligando il materiale sovrastante a spostarsi verso l'alto. Abbiamo ottenuto così un’espansione del globo terrestre con un conseguente abbassamento del livello degli oceani. Se al contrario il coefficiente G diminuisse, la Terra subirebbe una contrazione e gli oceani innalzerebbero la loro superficie.
Abbiamo dunque trovato il meccanismo che avrebbe dato luogo a una regressione marina di qualche centinaio di metri alla fine del Miocene e subito dopo ad una ingressione di un migliaio di metri all’inizio del Pliocene. È soprattutto nella seconda fase che possiamo tradurre i rapidi e intensi cambiamenti ambientali dovuti all’aumento di livello in condizioni sfavorevoli per la sopravvivenza delle specie viventi.
Il Tirreniano
Il ciclo di 11 milioni di anni non è il solo che si manifesta con il tipo di fenomeni descritto. Abbiamo un altro ciclo, legato a un terzo livello di estinzioni, con un tasso di scomparse di circa 3 % delle specie. Esso si manifesta ogni 700 mila anni e ha inizio con una trasgressione marina di grandi dimensioni. L’ultima volta risale a 270 mila anni fa, quando ha dato origine alla trasgressione del Tirreniano, l’ultima delle tre età del Pleistocene. A differenza delle varie trasgressioni precedenti, le cui tracce sono andate per lo più perdute, la trasgressione del Tirreniano ha lasciato morfologie rimaste intatte e quindi ben manifeste. Un altro regalo che la natura ci ha offerto su un piatto d’argento. Eppure il Tirreniano, che di tutte le età è la più facilmente riconoscibile, è, paradossalmente, la meno riconosciuta. Basta pensare che comunemente lo si fa iniziare 130 mila anni fa, ignorando quanto è accaduto nei 140 mila anni precedenti. Non è difficile ravvisare in questa esclusione l’orrore, instillato dai tempi di Lyell, per ciò che va oltre l’ordinario.
Le tracce del Tirreniano sono osservabili, in gran numero, lungo le coste di tutti i continenti. Sono rappresentate da terrazzi di abrasione intagliati dal mare; l’esistenza di questa particolare morfologia è dovuta al fatto che sia la fase ingressiva che la fase regressiva della trasgressione si sono svolte non gradualmente ma in maniera discontinua, con lunghi stazionamenti alternati a rapidi cambiamenti di livello. Trattandosi di cambiamenti che avvengono contemporaneamente su tutto il globo, è possibile trovare le antiche linee di riva a quote costanti quasi ovunque. Dobbiamo escludere una minoranza di aree che sono instabili o perché, come la Scandinavia, si stanno sollevando avendo perso da poco tempo il peso della calotta di ghiaccio che ricopriva il Nord-Europa oppure perché, come la zona montuosa dell’Iran che si affaccia sul Golfo Persico, sono in sollevamento orogenetico.
Adottando lo stesso criterio di seguire morfologie a quote costanti, si possono correlare anche terrazzi attualmente sommersi in varie parti del mondo poiché anche le espansioni e i ritiri delle calotte di ghiaccio durante le puntate glaciali hanno proceduto in maniera discontinua, episodica.
Numerose descrizioni dei terrazzi sommersi compaiono nella letteratura specifica, e si riscontrano significative coincidenze di valori di profondità in tutti i mari, permettendo di fare correlazioni precise a qualsiasi distanza. Jacques Cousteau aveva individuato in più punti dell’Oceano Indiano un terrazzo ben sviluppato a 56 m di profondità e riteneva possibile ritrovarlo in tutto il globo. Diversi altri ricercatori avevano la stessa convinzione relativamente a un numero maggiore di stazionamenti marini. Questi terrazzi non sono tutti uguali: è possibile riconoscere che alle diverse profondità si alternano forme più e meno sviluppate, ad indicare che si sono succeduti stazionamenti con due durate nettamente diverse, permettendo di distinguere stazionamenti che possiamo chiamare “primari” e “secondari”.
Integrando informazioni provenienti sia dagli ambienti sommersi che da quelli emersi, è stato ricostruito il cambiamento del livello marino negli ultimi 30 mila anni. Esso è rappresentato nella Figura 2 da una linea spezzata, dove rapidi cambiamenti di livello si alternano a lunghi stazionamenti seguendo cicli di poco più di 2500 anni (2528 per la precisione); durante ognuno di tali cicli la superficie del mare ha assunto due posizioni a quote costanti per due distinte durate, di circa 2200 e 150 anni, con due intervalli di raccordo di poco meno di 100 anni ciascuno.
I nomi che figurano in alto sono quelli assegnati alle morene frontali della grande calotta che ha ricoperto durante l’ultimo glaciale la Scandinavia, la Danimarca, la Finlandia, la Siberia e parte di Gran Bretagna e Germania. La correlazione con gli stazionamenti marini è stata facilitata dal fatto che anche per le varie morene frontali si alternano dimensioni maggiori e minori. Infine nella parte bassa sono riportati i periodi climatici dell’Europa centrale che i botanici hanno distinto sulla base dei caratteri manifestati dalla vegetazione.
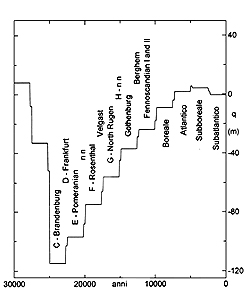
Figura 2 – Cambiamento del livello del mare negli ultimi 30 mila anni. I nomi al disopra del grafico sono stati assegnati a morene frontali della calotta glaciale che ha ricoperto l’Europa. Come per gli stazionamenti del livello marino si sono alternate durate più e meno lunghe, così per le morene si osservano dimensioni alternativamente maggiori e minori. Al disotto del grafico figurano i quattro periodi climatici dell’Europa settentrionale, distinti sulla base dei caratteri della vegetazione, che si sono succeduti ogni 2500 anni circa a partire da 10 mila anni fa. Da Mortari (2010).
Il grafico della figura 2 contraddice chiaramente il principio di Lyell della gradualità, e per questa ragione non è stato accolto favorevolmente. Esso si differenzia molto, come vedremo più avanti, dalle ricostruzioni fatte da vari autori.
Lo studio dei terrazzi nelle aree emerse dovrebbe risultare molto più facile rispetto all’ambiente subacqueo; paradossalmente però ha dato luogo nei suoi sviluppi a una situazione poco felice. Vi è stata una prima fase alquanto fruttuosa nella prima metà del ’900, che ha portato a distinguere alcune linee di costa di valenza globale, come quelle a 55÷60 m, a 33÷36 m e a 18÷22 m, con nomi specifici (Milazziano, Eutirreniano e Neotirreniano). La presenza di coppie di valori era purtroppo fonte di equivoci poiché dava l’idea che le linee di costa si possono manifestare indifferentemente in una qualsiasi posizione contenuta entro quell’intervallo, mentre invece si tratta di due linee di riva ben distinte. L’equivoco purtroppo portava anche a ritenere che fosse sufficiente misurare la quota sul terreno purché si ricadesse nell’intervallo, per cui poteva essere sufficiente adottare una approssimazione delle misure ai 5 m. Le cattive misurazioni hanno impedito una corretta correlazione tra terrazzi ubicati a una stessa quota e hanno sviluppato la convinzione di una generale instabilità delle aree misurate.
Il risultato ottenuto è che oggi vi è una opinione largamente condivisa che ha fatto scomparire quasi del tutto quella che un tempo veniva chiamata “Trasgressione tirreniana”, riducendola a una modestissima presenza del mare alla quota di 6 m, addirittura inferiore alla quota massima raggiunta, come vedremo, dal livello marino nell’ultimo interglaciale di 4800 anni fa. Così, per colpa di alcuni cattivi sperimentali, hanno finito per prevalere teorici ancora peggiori.
Eppure le premesse erano buone poiché nate nel posto giusto: le rive del Mediterraneo. Esse sono delle zone privilegiate per studiare i terrazzi del Tirreniano, grazie alla presenza, seppure molto sporadica, di conchiglie insolite sparse in prossimità della loro superficie. Si tratta di resti fossili di una fauna particolare chiamata “senegalese”, dato che oggi le stesse specie sono comuni lungo le coste di quel paese; quando dunque troviamo “ospiti caldi” (il più noto è lo Strombus bubonius) siamo proprio sicuri di avere sotto i piedi un deposito del Tirreniano.
Il deposito più ricco di questo genere si trova a Ravagnese, assai prossimo a Reggio Calabria. É anche il più alto del Mediterraneo (se escludiamo un altro presso Corinto): è situato a una quota di circa 100 m sul livello del mare. Troppi, si è detto subito confrontandoli coi 33 o 22 m di altre zone. Senza dubbio c’è stato un sollevamento! Ma come si fa a esserne così sicuri? Solo perché quei 100 m sono catastroficamente più alti di 33 m?
Se però ci prendiamo cura di misurare con precisione i terrazzi della regione, ci accorgiamo che da 4 fino a 144 m si succedono quote perfettamente identiche a quelle che si riscontrano nel Lazio, in Somalia e perfino all’isola di Pasqua.
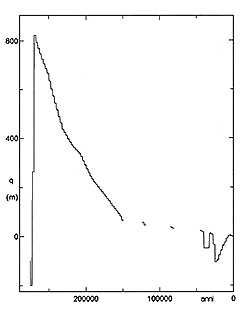
Figura 3 – Cambiamento del livello marino durante la grande trasgressione che ha caratterizzato l’inizio dell’Età Tirreniana. La ricostruzione è stata possibile poiché tale cambiamento ha avuto un carattere discontinuo e le quote degli stazionamenti del mare si ritrovano identiche ovunque non siano intervenuti movimenti verticali della crosta terrestre. Da Mortari (2010).
Nonostante la tentazione di raccontare dettagliatamente come si è sviluppata la ricerca dei terrazzi del Tirreniano, che servirebbe a fugare l’impressione che i catastrofisti non sono ben documentati, mi limito per adesso a riassumerne i risultati illustrandoli con l’aiuto del grafico della Figura 3, ripresa dal mio I ritmi segreti dell’Universo, dove l’argomento occupa 82 pagine molto dense.
Durante la fase ingressiva il livello marino è variato di oltre 1000 m, 822 dei quali sono al disopra dello zero attuale e il resto, al disotto, è da attribuire al recupero del calo di circa 200 m che il mare ha subito nella fase iniziale dell’ultima (e più importante) puntata della glaciazione del Riss, quella che ha preceduto la più recente glaciazione würmiana.
Come già espresso, è su questa ricostruzione di una trasgressione marina che mi sono basato per immaginare quanto può essere accaduto al passaggio tra Miocene e Pliocene, come pure all’inizio del Langhiano e di altre età con una cadenza regolare ogni 11 milioni di anni. La stessa trasgressione tirreniana non può essere un caso isolato ma deve essersi verificata anche all’inizio delle altre età del Pleistocene: il Calabriano e il Siciliano, ogni 700 mila anni circa.
I cambiamenti climatici
I grandi cambiamenti del livello marino sono dunque da addebitare a variazioni delle dimensioni del nostro pianeta in seguito a variazioni subite dal coefficiente gravitazionale G. Tra le tante altre conseguenze di tali variazioni si devono altresì includere i grandi cambiamenti che il clima ha subito a scala globale a causa di una somma di effetti diversi. Uno degli effetti, probabilmente quello principale, è l'aumento o la riduzione della distanza Terra-Sole, che diventa maggiore per un calo di G e minore per una sua crescita. Un altro effetto dovrebbe manifestarsi nella radiazione solare, con un suo aumento o una diminuzione a seconda che G aumenti o diminuisca.
Siamo dunque molto lontani dall'idea, comunemente condivisa, che le grandi variazioni climatiche siano essenzialmente dovute a variazioni dell'inclinazione dell'asse terrestre rispetto al piano dell'eclittica, come suggeriva la teoria astronomica di Milankovic. Poiché queste variazioni avverrebbero gradualmente, la formazione di una calotta di ghiaccio come quelle che hanno interessato Canada, Europa settentrionale e Siberia non può che risultare graduale (è anche questa una eredità scomoda dell'attualismo).
Questa convinzione, errata, ha costituito una zavorra culturale, impedendo per esempio di riconoscere che tra 40 e 35 mila anni fa si è verificata una notevole espansione glaciale, che, in meno di un secolo, ha indotto un abbassamento del livello dei mari di oltre 50 m. All'inizio di questo periodo in Siberia vi erano boschi di betulle, che verso nord sfumavano verso le tundre, dove pascolavano mammuth, cavalli e rinoceronti lanosi. L’arrivo del freddo, intenso, è stato improvviso. Le mandrie di questi animali sono state sommerse dalla neve, che è caduta copiosa. Sono morti assiderati nonostante il folto pelo che avrebbe dovuto permettergli di superare rigidi inverni. Da allora la temperatura si è mantenuta assai bassa fino a poco tempo fa, e il suolo è rimasto permanentemente gelato (permafrost). Nella morsa di ghiaccio sono stati intrappolati decine di migliaia di mammuth fino a quando le migliorate condizioni degli ultimi due secoli hanno cominciato a farli riaffiorare in superficie. Appena emergevano dal ghiaccio che li avvolgeva, le loro carni erano ancora commestibili: nel loro stomaco si trovavano, non ancora digerite, foglie di betulle e di conifere di cui si cibavano. A San Pietroburgo è esposto in un museo uno di questi animali, imbalsamato nella posizione in cui è stato ritrovato, ritto sulle zampe anteriori: era stato sorpreso da una tormenta di neve così intensa e prolungata da seppellirlo vivo.
Analogamente, la successiva, e ultima, puntata glaciale ha avuto un inizio notevolmente rapido, raggiungendo il suo culmine in soli 2500 anni, tra 27500 e 25000 anni fa circa. In questo breve intervallo di tempo essa ha provocato un abbassamento del livello del mare da una quota di 8 m a una di -115. La calotta di ghiaccio che ha coperto l'Europa è arrivata fino ad oltre le posizioni di Bristol e Berlino spazzando via tutto ciò che di vita ha incontrato. Le Alpi erano coperte da una grande isola di ghiaccio che estendeva le sue ramificazioni a sud fin dentro la pianura Padana, dove ha lasciato imponenti morene frontali.
Tutte le morene frontali indicano che il ritiro è avvenuto in modo discontinuo con l'alternanza di accumuli più e meno importanti, che seguono cicli di circa 2500 anni. Mentre la fase di espansione di quest'ultima puntata glaciale ha occupato il periodo di un solo ciclo, ci sono voluti invece 20 mila anni perché si svolgesse la successiva fase di ritiro, e il miglioramento climatico che l'ha accompagnata ha avuto un culmine 4800 anni fa.
Possiamo avere un'idea della confusione che pervade le ricerche sulle variazioni climatiche semplicemente considerando che in letteratura quando si parla di “ultimo interglaciale” ci si riferisce ad un momento che risale a 128 mila anni fa. Mentre invece, come facevo notare, l'apice dell'ultimo interglaciale non ha compiuto ancora 5000 anni; ad esso corrispondono condizioni di optimum climatico, con temperature che probabilmente erano 2 o 3 °C superiori a quelle del 1800.
Una delle aree in cui possiamo meglio seguire le variazioni del clima prima e dopo l'optimum è il Sahara. Fino a 10÷12 mila anni fa esso si presentava così come appare oggi; poi da regione arida ha cominciato a trasformarsi in zona ricca di vegetazione, presentandosi come una savana tropicale. Vi vivevano elefanti, leoni, rinoceronti, giraffe, struzzi. Intorno a 9000 anni fa è ben documentata l’esistenza di laghi popolati da ippopotami e coccodrilli.
Queste notizie ci sono state trasmesse da popolazioni provenienti da zone più meridionali, che hanno lasciato nelle pareti delle zone più rilevate splendidi graffiti con una probabile funzione di preparazione rituale alla caccia. Veniva cacciato soprattutto una specie di bufalo dalle corna lunghissime, in seguito estintosi.
Intorno a 8000 anni fa queste popolazioni cominciarono a dipingere particolari figure d’uomo dalla testa rotonda ma priva dei connotati del viso. Sono scarse le figure di animali, e con dimensioni ridotte; probabilmente si stava passando dalla caccia all’allevamento. Compaiono le prime ceramiche.
Intorno a 6000 anni fa e per un periodo che grosso modo viene valutato ancora, come per gli altri periodi, della durata di 2000 anni, l’allevamento è diventata l’attività principale. Sono ritratti buoi, pecore e capre. Ai graffiti si aggiungono dipinti molto suggestivi, che descrivono scene di vita quotidiana sia di allevamento che di caccia, seppur limitata ad animali di piccola taglia. Possiamo anche osservare una evoluzione nell’ambito di questo periodo: man mano che le mandrie diventano più numerose le scene di caccia si fanno sempre più sporadiche.
Da 4000 a 2000 anni fa alle scene di allevamento o di caccia si sono sostituite immagini di cavalli e carri in corsa, segno che è sopraggiunto il deserto, dove ci si muove ma non ci si ferma.
Infine, l’ultimo periodo è caratterizzato da graffiti rozzi ed essenziali, in cui l’animale dominante è il dromedario.
Tutto ciò sta a significare che 5000 anni fa, quando si era prossimi al culmine dell’interglaciale, il Sahara era verde, e altrettanto verdi dovevano essere l’Egitto e il Medio Oriente. Le maggiori temperature avevano come effetto una maggiore evaporazione degli oceani e di conseguenza una maggiore piovosità globale, di cui il Sahara poteva godere soltanto con una diversa circolazione atmosferica, e ciò era possibile con un opportuno posizionamento delle zone di alta e bassa pressione.
Nella zona di Giza, in Egitto, oggi vediamo una distesa di sabbia, ma al tempo della costruzione delle famose grandi piramidi la piovosità era molto maggiore di oggi. Se non teniamo ben presente che la piovosità nel frattempo è mutata, possiamo incorrere in errori di valutazione come è accaduto ad un geologo statunitense, il quale, osservando i solchi incisi dall’acqua di ruscellamento nella base della sfinge, ha ritenuto che il monumento dovesse essere molto più antico dei 4500 anni che gli archeologi giustamente gli assegnano.
Giza era dunque verde, e verde doveva essere tutto l’Egitto. Improvvisamente si è presentata sul Sahara e sull’Egitto una siccità eccezionale e tanto prolungata da doverla considerare definitiva, come era stata definitiva la condizione glaciale quel giorno in Siberia di 40 mila anni fa. I pastori che popolavano la regione hanno perduto nel giro di una stagione il loro bestiame. Questa condizione deve essere avvenuta verso il 2160 a.C., e un immane flusso migratorio ha avuto luogo verso la ricca valle del Nilo, presa letteralmente d’assalto. In un papiro, noto come “lamentazioni di Ippuwer”, viene descritta la grande tragedia di quel tempo, quando il deserto invase il paese:
“I ricchi sono in lutto, i poveri sono pieni di gioia; ogni città dice: "Scacciamo i potenti che sono fra noi!". Grandi e piccoli dicono: "Vorrei essere morto!" e i piccoli bimbi dicono: "Non mi avessero mai messo al mondo". Davvero il deserto è nel paese, i nomi sono spariti; gli stranieri sono venuti in Egitto da fuori. Si mangia erba e ci si abbevera d'acqua e non si trovano né grano né erbaggi da uccelli: si prendono i rifiuti dalla bocca dei maiali e non si dice: "Questo è meglio per te che per me", a causa della fame. … Ecco, i poveri del paese sono diventati ricchi, chi era ricco ora non ha nulla.” Così è terminato l'Antico Regno, e con esso è finita una conoscenza altamente raffinata, che non si è più potuta rialzare ai livelli precedenti. Molto sapere è andato perso per sempre. Non sapremo mai esattamente come sono riusciti a costruire quelle piramidi. Segreti custoditi gelosamente da sacerdoti che tramandavano le loro conoscenze attraverso un insegnamento orale non si sono salvati.
Il processo di desertificazione non ha portato alla situazione così come la osserviamo oggi. Il deserto era meno spinto verso le coste dell'Africa settentrionale e non interessava come nella misura odierna i paesi del Medio Oriente. Intorno al 600 a.C. forse in Grecia la piovosità era ben maggiore, e all'isola di Lesbo potevano essere tanto comuni le viole che Alceo ha dedicato a Saffo quel delizioso verso: “dolce-ridente Saffo coronata di viole”.
Il calo di precipitazioni non era ancora avvenuto in quest'area del mondo nel II secolo d.C., quando la penisola araba veniva chiamata Arabia felix. Strabone nel 25 a.C. descriveva le coste della penisola araba sul mar Rosso rivestite di boschi. Oggi quei boschi non ci sono più.
Il processo di desertificazione probabilmente è avvenuto in modo improvviso in alcune aree e più graduale in altre. Nel 600 d.C., quando anche Petra, in Giordania, è stata raggiunta, esso era già concluso da tempo. Petra, che aveva impianti di irrigazione per utilizzare l'acqua di cui prima era ricca, ha dovuto adattarsi cercando di raccogliere e sfruttare l'umidità della notte, ma alla fine ha dovuto cedere al deserto che l'aveva assalita da ogni parte.
Che cosa è successo tra il II e il VI secolo d.C.? C’è da chiedersi se anche l'Impero romano, come l'Antico Regno d'Egitto, non abbia risentito di variazioni climatiche verificatesi dentro i suoi confini o anche al di là di essi. Verso la fine del IV secolo in effetti accade qualcosa di sconvolgente che forse ci mette sulla pista giusta.
Nel 376 i Visigoti, o Goti dell'Ovest, oltrepassarono il Danubio e chiesero di essere accolti entro i confini dell'impero. I Romani concessero l'asilo non immaginando che si trattasse di una popolazione assai numerosa; quando se ne accorsero era troppo tardi e iniziarono a compiere un insieme di vessazioni tali da indurre i Goti a ribellarsi. Nel 378 l'esercito romano di Valente venne sconfitto ad Adrianopoli, e questa sconfitta, che precedette di 17 anni la divisione in due dell'impero, può essere considerata l'inizio della fine dell'impero.
Perché i Visigoti si sono spostati in massa? Essi avevano abbandonato le terre che occupavano al di là del Danubio, nell'attuale Romania, per evitare di venire sottomessi dagli Unni, che tra il 374 e il 376 erano emigrati verso occidente, provenendo dall'Asia centrale. A questo punto c'è da chiedersi quale evento può avere indotto gli Unni a migrare.
Nella zona di provenienza degli Unni troviamo due grandi deserti. Il Gobi, che letteralmente in lingua mongola vuol dire proprio “deserto”, è il secondo dopo il Sahara. Più a ovest, nella Cina occidentale, si estende un altro grande deserto, il Taklamakan; esso occupa il bacino endoreico del fiume Tarim, che ha alimentato per 20 mila anni un lago di 10 mila km2, ora quasi completamente essiccato. Intorno all'inizio del XX secolo un avventuriero venuto dalla Svezia scoprì che sulle rive occidentali dell'antico lago, sotto le sabbie del deserto, era sepolta una città, oggi citata come la “Pompei dell'oriente”. Il suo nome era Loula. Alcuni documenti ritrovati rivelano che essa era la capitale di un regno di 36 città stato che si estendeva su un territorio di 360 mila km2. Era una città arricchita sfruttando il commercio che avveniva lungo la via della seta settentrionale, la stessa seguita nel suo viaggio da Marco Polo, quando però l'area era già diventata desertica. I suoi più recenti edifici erano stati eretti nel II secolo a.C.. Un acquedotto in galleria divideva in due l'abitato, alimentato da corsi d'acqua che scorrevano nei pressi; fitti boschi si estendevano fuori delle mura cittadine.
La scoperta di diverse tombe ha permesso di sapere che Loula era un insediamento di popolazioni caucasiche già 4000 anni fa, a cui in seguito si sono aggiunte altre popolazioni con caratteristiche mongole. Il regno di Loula è entrato a far parte dell'impero cinese sotto le dinastie Han e Jin. Nel IV secolo improvvisamente tutte le città di quest'area vennero abbandonate; alcuni testi cinesi si limitano a riferire che questi centri “hanno cessato misteriosamente di essere abitati per delle ragioni oscure”.
Attualmente le ragioni non sono più oscure: capiamo che deve essere sopraggiunta una rapidissima desertificazione, che ha costretto gli abitanti della regione a fuggire senza indugio. Non abbiamo le prove che anche il Gobi si sia trasformato in deserto nello stesso momento, ma è oltremodo probabile che sia accaduto così, considerando che, nella loro disposizione allungata in senso est-ovest, il Gobi e il Taklamekan sono l'uno la continuazione dell'altro e insieme occupano un’unica area isolata, caratterizzata da scarsissime precipitazioni atmosferiche.
Possiamo dunque ritenere che verso il 374 da questa grande area improvvisamente desertificata sia iniziata l'intensa migrazione di Unni che ha sconvolto gli equilibri delle popolazioni di tutta l'Europa sudorientale e segnato il destino dell'impero romano. È davvero singolare che tra il 374 e il 2160 a.C., anno in cui si è concluso precipitosamente l'Antico Regno d'Egitto, la differenza, di 2534 anni, sia molto prossima alla durata del ciclo di 2528 anni che caratterizza il modo discontinuo in cui avvengono non solo le espansioni e i ritiri degli eventi glaciali e le variazioni del livello dei mari, come ho già descritto in precedenza, ma, come vedremo, anche le variazioni di alcune caratteristiche tecniche dei sedimenti recenti.
È possibile che la differenza tra i 2534 e i 2528 anni che separano i due processi di desertificazione del Sahara e del Taklamekan sia ancora minore se conoscessimo il momento della fine dell'Antico Regno con una approssimazione minore di quella ai 10 anni che caratterizza le date degli avvenimenti del più antico Egitto.
L’osservazione è rilevante perché possiamo prestare più attenzione a questo aspetto della Natura. Non mancheranno altre occasioni di incontrare il ciclo in questione; vedremo che sarà utile per orientarci dove si animano accese controversie, come quella che riguarda la causa naturale o antropica del riscaldamento globale degli ultimi due secoli.
In che misura esso rappresenta un problema? Può essere interessante osservare il modo in cui è percepito dalla gente: nel gennaio 2011 un sondaggio effettuato nel Regno Unito indicava che l’83 % delle persone intervistate riteneva il riscaldamento globale una minaccia attuale o imminente.
Probabilmente il rango di problema deriva dal fatto che il cambiamento climatico, oltre ad aspetti positivi (come le minore spese per il riscaldamento invernale, l'apertura di rotte artiche in sostituzione del canale di Panama), presenta senza alcun dubbio aspetti negativi (piovosità eccessiva, cicloni in aumento etc). Il gruppo di lavoro intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) ha preso in esame, tra l'altro, le conseguenze di un prolungato aumento del livello dei mari, prevedendo che nel 2050 l'innalzamento potrebbe aver raggiunto il valore di 1 m, producendo nel solo Bangla Desh da 15 a 20 milioni di profughi.
Sarà una catastrofe? Effettivamente con l'aumento in corso della popolazione mondiale la perdita di territori è preoccupante. Ma le cose stanno realmente così? E ci si sta muovendo nel senso e nel modo giusto? Va esaminata la questione partendo da un caso che ha fatto grande scalpore.
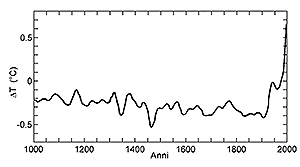
Figura 4 – Variazione della temperatura alla base dell’atmosfera nell’emisfero settentrionale secondo tre esperti dell’IPCC. Il grafico “dimostrerebbe” la causa esclusivamente antropica del recente riscaldamento globale. Da Mann et al. (1999).
Nel 1998 e nel 1999 su due importanti riviste internazionali sono usciti due articoli, il più recente dei quali rimarrà nella storia delle controversie scientifiche. Venivano illustrate le ricostruzioni delle variazioni della temperatura alla superficie dell'emisfero settentrionale a partire rispettivamente dal 1400 e dal 1000. Ovviamente solo dal 1750 circa si dispone di dati strumentali sufficientemente estesi in senso geografico, mentre per il periodo precedente si deve procedere per informazioni indirette, utilizzando la velocità di crescita degli anelli degli alberi, le carote ricavate da sondaggi che hanno attraversato calotte glaciali, testimonianze storiche etc. Nella Figura 4 possiamo vedere questa ricostruzione.
L'autorevolezza delle riviste e il fatto che gli autori hanno elaborato il loro studio per conto dell'IPCC avrebbero dovuto garantire correttezza e obiettività dei dati. Ma il grafico, denominato in seguito da qualcuno in vena di dileggio “mazza da hokey” per la sua forma, ha giustamente sollevato severe critiche per la sua mancanza di obiettività. Cerchiamo di fare luce sulla questione.
Nel primo lavoro i tre autori mostrano che le temperature dell'emisfero settentrionale tra il 1400 e il 1900 sono variate molto poco intorno a un valore che era 0,3 °C minore rispetto alla media del periodo 1902÷1980, assunta come riferimento. Nel lavoro successivo, il periodo tra il 1000 e il 1400 è rappresentato da valori leggermente più alti, ma che rimangono intorno a 0,2 °C al disotto della media del 1902÷1980. Gli autori, in breve, intendevano dimostrare che precedentemente al 1925 la temperatura si era mantenuta su un livello pressoché costante, per poi innalzarsi in modo improvviso ed innaturale in coincidenza con gli aumenti più cospicui del contenuto di CO2 nell'atmosfera. Veniva così costruita la prova che il riscaldamento del pianeta era dovuto esclusivamente all'attività umana.
Purtroppo però la mazza da hokey era stata messa insieme omettendo dati importanti, e non si teneva conto che nel medioevo la temperatura aveva raggiunto valori perfino superiori a quelli attuali. Si tratta del cosiddetto “Optimum climatico medievale” (OCM).
L'evidenza che intorno al 1200 in Europa vi erano state condizioni climatiche particolarmente favorevoli risulta ad esempio da testimonianze che l'ulivo veniva coltivato in Germania nella valle del Reno ancora verso il 1250 e che in Scozia era stata impiantata la vite. Oggi simili condizioni non si riscontrano. Successivamente, la temperatura ha cominciato ad abbassarsi, raggiungendo minimi valori intorno al 1600; questo periodo più freddo ha ricevuto il nome di “Piccola Età Glaciale”, una espressione esagerata, dato che stiamo vivendo in un interglaciale e il suo culmine ottimale è passato da appena 4800 anni; ma esso dà l'idea della paura che infonde una profonda alterazione climatica di questo genere. In effetti, tra il 1550 e il 1850, con due fasi critiche intorno al 1600 e al 1800, l'Europa ha sofferto freddi intensi con danni all'agricoltura e migliaia di morti. In un inverno particolarmente rigido, tra il 1694 e il 1695, il 30 % della popolazione della Finlandia non è sopravvissuto. Sulle Alpi parecchi villaggi sono stati evacuati a causa dell'espansione di ghiacciai che erano stati ritenuti stazionari.
Poi, intorno al 1650, è iniziato un periodo in cui la temperatura ha cominciato leggermente a salire; ma dal 1770 il quadro della situazione ha cominciato a complicarsi, dopo che ha iniziato a manifestarsi un incremento della quantità di CO2 nell'atmosfera, da considerarsi una conseguenza della rivoluzione industriale. Sappiamo che questo gas incrementa l'effetto serra, anche se non è il solo a farlo. Infine, intorno al 1950 la velocità di crescita della temperatura ha evidenziato un ulteriore notevole aumento.
Per poter giudicare la mazza da hokey senza cadere in errori opposti, è bene ricostruire un quadro che sia ben giustificato. Per tale ragione ho ritenuto di non limitarmi a trattare esclusivamente l'ultimo millennio ma di estendere la ricerca fino a poco oltre il culmine dell'interglaciale di 4800 anni fa; l’obiettivo è di includere altri importanti momenti di acme di temperatura, che sono l'Optimum climatico romano (OCR), l'Optimum climatico miceneo o dell'età del bronzo (OCB) e infine l'Optimum climatico relativo allo stesso culmine interglaciale (OCI).
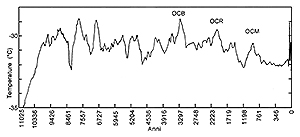
Figura 5 – Variazione della temperatura determinata per mezzo del rapporto isotopico dell’ossigeno da carote di ghiaccio prelevate in un sondaggio meccanico in Groenlandia. Da Alley (2004).
Una dimostrazione efficace della realtà delle tre più recenti condizioni di optimum climatico viene dai risultati di un'analisi isotopica dell'ossigeno che ha riguardato le carote del sondaggio GISP2, eseguito sui ghiacci della calotta della Groenlandia (Figura 5). Le variazioni del rapporto tra i due isotopi dell'ossigeno 18O/16O sono state tradotte in variazioni di temperatura dall’autore che le ha pubblicate. Poiché il rapporto isotopico risente delle variazioni della temperatura e quindi avverte i cambiamenti stagionali, è stato possibile individuare i singoli anni che si sono succeduti e risalire indietro nel tempo dal momento in cui è iniziata la perforazione fino a oltre 14 mila anni fa.
Vediamo così che all'incirca negli anni 1050 d.C., 1 e 1275 a.C. la temperatura è risultata da 1,5 a 2 °C superiore rispetto al fondo da cui i picchi emergono. Potremmo stupirci per la mancanza di un picco corrispondente all'Optimum climatico più importante, l'OCI, di 4800 anni fa. Se però esaminiamo le carote di un altro sondaggio, eseguito nell'isola di Devon, alcune centinaia di kilometri ad ovest della Groenlandia, l'unico picco che risalta è quello dell'OCI. La stranezza si spiega considerando che il rapporto tra i due isotopi dell'ossigeno varia in funzione non solo della temperatura dei luoghi in cui una molecola d'acqua prima si libera nell'atmosfera e poi l'abbandona, ma anche di quanto avviene durante tale intervallo di tempo. Se seguiamo il percorso di una nube che sia stata alimentata dall'evaporazione avvenuta in una zona tropicale, ci accorgiamo che il rapporto isotopico in questione diminuisce ad ogni precipitazione, dato che l'18O, più pesante, tende ogni volta a separarsi più facilmente dell'altro isotopo.
Pertanto il grafico della figura 5 è basato su dati che non sono dotati di una potenziale uniformità di errore; la stessa cosa accade per altre fonti di informazione che antecedano le misure dirette di temperatura, cioè il 1750 circa. Attingerò pertanto a informazioni di un genere diverso, cioè alle testimonianze dirette e indirette di eventi umani. Inoltre, dato che man mano che si va indietro nel tempo i dati scarseggiano sempre di più e diventano incerti, ho dedicato più attenzione nel ricostruire le condizioni presenti nell'emisfero settentrionale durante il più recente ottimo climatico, quello medievale. Per questo periodo saranno utili soprattutto i minuziosi dati di cronaca sulla navigabilità dell'Oceano Atlantico lungo le rotte dall'Europa settentrionale verso Islanda, Groenlandia, Labrador e Terranova, ovvero il famoso “passaggio a nordovest”.
Rintracceremo notizie a partire da quando la condizione di ottimo climatico ha cominciato ad emergere da una condizione di clima nettamente più freddo, che secondo alcuni autori si è esteso tra il 400 e il 700; noi lo faremo terminare un po’ prima poiché uno studio degli anelli di crescita degli alberi degli USA e della Norvegia ci informa che intorno al 600 ha termine un periodo freddo e ha inizio un lungo periodo di riscaldamento. Possiamo assimilare la situazione a quella che nel 1850 ha posto fine alla Piccola Età Glaciale.
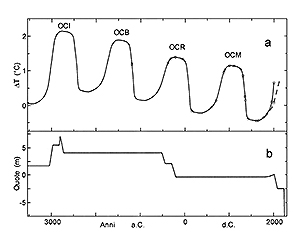
Figura 6 – a) Variazione della temperatura negli ultimi 5300 anni stimata soprattutto in base a documentazioni storiche. I quattro acmi sono condizioni di optimum climatico che si sono realizzate nel medioevo (OCM), nel periodo dell’antica Roma (OCR), nell’età del bronzo (OCB) e in corrispondenza del culmine interglaciale (OCI). L’estensione a tratti della curva indica quale avrebbe potuto essere l’andamento naturale se non fosse intervenuta l’attività antropica. b) Variazione del livello marino nello stesso periodo e proiezione nel prossimo futuro. Si notano stazionamenti “primari” durati 2200 anni circa e altri, “secondari”, di circa 150 anni; tra i due compaiono transizioni della durata di circa 80 anni.
Le notizie che stiamo raccogliendo possono essere controllate nella Figura 6a, dove ogni data utilizzata viene indicata da piccoli cerchi sulla curva che andiamo lentamente delineando e che è praticamente l'estensione indietro nel tempo di quella più precisa ricavabile, successivamente al 1750, attraverso le misurazioni strumentali.
Nel 700 giungono segnali che il periodo freddo compreso fra OCR e OCM è ormai alle spalle e il riscaldamento è già in una fase avviata: alcuni monaci irlandesi hanno occupato le isole fino ad allora deserte dell'arcipelago Föroyar, situato a metà viaggio tra le Shetland e l'Islanda. Infine, la situazione è decisamente migliorata allorché, nell'870, i vichinghi hanno raggiunto il sud della Groenlandia e, avendolo trovato libero dai ghiacci, poco dopo hanno cominciato a installarvi alcuni villaggi. Tra l'890 e il 1100 si ha l'epoca d'oro di questi stanziamenti, che non si limitano alla Groenlandia meridionale ma si estendono anche alle parti orientale e occidentale.
Intorno all'anno 1000 la temperatura dell'acqua nei fiordi era più calda di oggi, come dimostra un episodio occorso al fondatore di una colonia che, per recuperare una pecora rimasta su un'isola distante oltre due miglia, ha percorso a nuoto due volte questa distanza. Un medico ha stimato che la temperatura dell'acqua non potesse essere inferiore a 10 °C, mentre oggi nelle migliori condizioni non supera i 6. Sapendo che alle alte latitudini le differenze si accentuano, possiamo supporre che a quei tempi la temperatura globale fosse all’incirca 0,5 °C maggiore di oggi.
Un altro motivo per arrivare a tale valutazione è dato dal fatto che nel periodo d'oro degli insediamenti vichinghi i morti venivano sepolti scavando fosse profonde fino a due metri, il che oggi non è possibile, essendo il suolo gelato durante tutto l'anno. Assumerò dunque che in prossimità dell'anno 1000 possa essere collocato il culmine dell'OCM, con una temperatura media di 0,5 °C maggiore di oggi e 1,5 °C maggiore rispetto al 1770. In questo periodo i vichinghi approdarono sulle coste boscose del Labrador, incontrando “strani selvaggi”, 500 anni prima che Cristoforo Colombo arrivasse alle Antille.
La fine dell'optimum climatico è iniziato verso il 1250. Fino a questa data, come già detto, vi sono notizie che l'olivo era coltivato nella valle del Reno e la vite lo era fino in Scozia. Proprio a partire dal 1250 il clima ha iniziato a deteriorarsi, e, in seguito a un repentino abbassamento di temperatura, lungo le coste della Groenlandia sono comparsi sempre più frequentemente iceberg alla deriva, mentre i coloni sono stati costretti a ritirarsi più a sud. Nell'ultimo ventennio del 1200 i ghiacci lungo le coste sono andati crescendo sempre di più.
Intorno al 1300 gli esquimesi, che abitavano la parte nordoccidentale, hanno abbandonato l'isola. A metà del 1300 venivano praticate le rotte soltanto verso la Groenlandia meridionale. Nel 1360 i coloni hanno lasciato completamente l'insediamento occidentale; qui il clima era più rigido di quello a oriente poiché le coste vengono lambite da una corrente fredda proveniente dall'artico.
Nel 1368 si è compiuto l'ultimo viaggio della regia nave norvegese che in teoria aveva il monopolio degli scambi commerciali; in realtà nei tempi successivi avvennero altri 4 sbarchi di navi, non autorizzate, l'ultima delle quali raggiunse l'isola nel 1406 e ne ripartì nel 1410. Dopo di allora i coloni furono abbandonati al loro destino.
Nel 1420 il freddo ha raggiunto un valore massimo. È già iniziata la Piccola Età Glaciale, il cui culmine si è toccato tra il 1600 e il 1650.
Passando ora all'Optimum climatico romano, esso viene per lo più collocato tra il 500 a.C. e il 150 d.C., con un notevole miglioramento intorno al 300 a.C.. Tra le scarse notizie di cui disponiamo per questo periodo ci serviremo di due imprese ricordate nei secoli perché ritenute eccezionali.
La prima impresa è opera di uno dei più grandi navigatori di tutti i tempi, grande osservatore della natura ed esperto geografo. Si tratta del greco Pitèa, che partì dalla colonia focese di Massalia, oggi Marsiglia, intorno al 325 a.C. per prendere conoscenza delle rotte che recavano nel Mediterraneo l’oro e lo stagno dalla Cornovaglia. Approdato in questa regione, non si accontentò di avere eseguito la sua missione e proseguì compiendo il periplo della Gran Bretagna. In Scozia venne a conoscenza dell’esistenza di una città di nome Thule, entrata poi nel mito e solitamente identificata con l’Islanda; dopo sei giorni di navigazione raggiunse quest’isola senza però trovare Thule e volle spingersi ancora più a nord, ma dopo un giorno fu bloccato dalla presenza di ghiacci. Del suo viaggio scrisse una dettagliata relazione intitolata “Sull’Oceano”, che andò perduta nell’incendio della biblioteca di Alessandria, dove era conservato un originale, ma di essa hanno parlato diversi storici e geografi come Eratostene, Strabone e Polibio.
La seconda impresa è stata compiuta da Annibale quando, approfittando del generale miglioramento climatico, verso la fine dell’autunno del 218 a. C. riuscì a passare le Alpi con i suoi 50 mila soldati e 37 elefanti. Il fatto che l’episodio sia rimasto leggendario indica che dopo qualche tempo le condizioni dei passi sono ritornate ad essere proibitive per un’operazione del genere. Tuttavia alcuni valichi erano diventati transitabili già qualche tempo prima; nel 390 a.C. ne approfittarono i Galli Senoni guidati da Brenno allorché raggiunsero Roma e la saccheggiarono.
In Groenlandia l’intervallo di miglioramento climatico in questione ha coinciso con l'arrivo della popolazione esquimese Dorset in un momento non precisato, mentre il suo termine può essere desunto dall’epoca in cui hanno abbandonato l'isola, intorno al 50 a.C..
Per seguire l’evolversi del successivo peggioramento climatico, conviene trasferirsi sulle Alpi svizzere; qui è riconosciuta una forte espansione glaciale intorno al 100 d.C.. Pur assumendo come significativa questa fase fredda, chiamata Goschenen II, non sempre una espansione dei ghiacciai indica un periodo più freddo, potendo dipendere da un incremento degli apporti meteorici. Anche la transitabilità di un varco di montagna non sempre sta a dimostrare una temperatura più elevata, potendo essere in relazione con una diminuzione delle precipitazioni nevose nella stagione critica. Così, ad esempio, non si può affermare con certezza che tra il I e il V secolo le temperature fossero elevate come al tempo presente solamente perché i passi liberi del Piccolo e del Gran San Bernardo consentivano i traffici e quindi una vita prosperosa alla città di Aosta.
Una prova che le precipitazioni maggiori non sono in coincidenza rigorosa con avvenimenti o caldi o freddi viene dallo studio dei livelli dei laghi del versante nordoccidentale esterno delle Alpi, da cui risultano alti livelli di tutti i laghi sia intorno al 2850 a.C. che al 1500 d.C., quando le condizioni climatiche erano rispettivamente più calde e più fredde di oggi, corrispondendo all'OCI e alla Piccola Età Glaciale.
Ancora nell'area alpina, è probabile invece che minori precipitazioni siano indicative di climi più freddi. È interessante a tal proposito prendere in esame le conclusioni di una ricerca compiuta sui sedimenti di un lago del Giura francese depositati negli ultimi tre millenni. Tale ricerca mirava a trovare i momenti in cui si sono realizzati minimi livelli del lago; questi momenti sono risultati essere in corrispondenza all'incirca degli anni 1400 e 400 d.C. e 850 a.C.. In tutti e tre i casi si rientra nei periodi che risulteranno freddi nella figura 6a, e il secondo di essi, che corrisponde al massimo dei tre abbassamenti di livello, capita in pieno nel periodo di prosperità di Aosta, confermando i dubbi espressi sulle condizioni di questa prosperità.
Prima di procedere oltre per affrontare l'Ottimo climatico miceneo è opportuno fare il punto sulla situazione che si è andata delineando finora: il deterioramento climatico conclusivo dell'OCR non soltanto presenta caratteristiche simili a quello che ha posto fine all'OCM, nel senso che appare svilupparsi pienamente nel corso di un secolo e mezzo, ma avviene a una distanza temporale forse non del tutto casuale, corrispondente, con uno scarto modesto, a una metà del periodo di 2528 anni, ovvero 1264 anni. Infatti tra il massimo freddo registrato in Groenlandia e quello registrato nelle Alpi svizzere passano 1420 - 100 = 1320 anni, mentre tra l'abbandono della Groenlandia da parte dei Dorset e l'inizio del deterioramento climatico, ancora in Groenlandia, che viene dopo il periodo d'oro degli insediamenti ci sono 1250 - (-50) = 1300 anni.
Per ottenere un inquadramento preciso dell’estensione dei cicli di 2528 anni, nella figura 6b è inserito il grafico rappresentativo di come il ciclo in questione si manifesta tramite le variazioni del livello marino, tenendo presente che la fine di un ciclo corrisponde al momento in cui si conclude uno stazionamento del mare più lungo, protrattosi cioè per circa 2200 anni. Il grafico ci permette di fare alcune considerazioni importanti non solo per comprendere se realmente le variazioni della temperatura del passato hanno una ripetizione ciclica, ma anche per giustificare la scelta delle temperature massime attribuite ad ognuno dei quattro episodi di optimum.
Seguendo il criterio, per ora puramente ipotetico, di un ritorno di analoghe condizioni climatiche ogni 2528 / 2 = 1264 anni, la linea assume forme ripetitive, con differenze che riguardano essenzialmente le temperature dei momenti più caldi e più freddi. Il dato più vincolante riguarda la temperatura presente nel momento del massimo interglaciale di 4800 anni fa, e che varie stime giudicano di 2 o 3 °C maggiore rispetto a un secolo fa. Sulla base di tali stime, la temperatura adottata è di 2,5 °C più elevata di quella in atto all'inizio dell'età industriale.
Ritornando al posizionamento nel tempo degli eventi sulla curva, abbiamo qualche elemento per l’Ottimo climatico miceneo (OCB), che viene generalmente posto tra 3500 e 3200 anni fa. Un orientamento per la fine del periodo è fornito dalla notizia che all’incirca nel 1300 a.C. termina la permanenza nella Groenlandia settentrionale degli eskimesi Saqqaq. Probabilmente la migrazione di questa popolazione avviene in seguito ai primi accenni di deterioramento climatico, anche perché alle latitudini maggiori se ne risentono prima gli effetti. Ma la data, approssimativa, dell’abbandono della Groenlandia da parte dei Saqqaq va sensibilmente spostata in avanti poiché nel 1275 a.C. siamo ancora in un momento di maggiore temperatura, come ci informa la posizione del picco caldo del sondaggio GISP2 in figura 5.
Prendendo lo spunto dal nome assegnato a questo intervallo caldo, se esso è pienamente meritato e corrisponde effettivamente al periodo di sviluppo della civiltà micenea in Grecia, possiamo supporre che l'invasione del Peloponneso da parte dei Dori intorno al 1150 a.C. abbia segnato la fine di quella civiltà. La migrazione di questo popolo proveniente dalle regioni del Danubio potrebbe essere stata quindi, con buona probabilità, una conseguenza di mutate condizioni climatiche. Pertanto ho inserito questa data in una posizione bassa della curva.
La parte più remota del grafico, che descrive le condizioni dell’Optimum climatico interglaciale, mantiene la forma degli ottimi climatici già esaminati con l’accortezza di rispettare gli intervalli temporali, in particolare il semiciclo di durata 2528 / 2 = 1264 anni. Per quanto riguarda l’esatta posizione temporale del momento culminante della temperatura, occorre un momento di riflessione. Se è valido il criterio che il ciclo di 2528 anni ha così grande peso, possiamo sostenere che tra l'Optimum climatico interglaciale (OCI) e l’Optimum medievale deve intercorrere un intervallo di tempo che corrisponde a un ciclo e mezzo. Ciò significa che il picco del primo si è verificato 2528 + 1264 = 3792 anni prima dell'anno 1000, assunto finora come acme dell’OCM, vale a dire intorno all'anno 2792 a.C..
Questo valore è assai prossimo al 2800 a.C., che segna il momento in cui il livello del mare inverte la tendenza della sua variazione: dopo essere sempre salito da quando, 22500 anni fa, è iniziata la deglaciazione e avere raggiunto una quota massima di 7,0 m al culmine interglaciale, il mare ora inizia una serie di abbassamenti. È dunque un momento importante, che per la sua assoluta particolarità dovrebbe coincidere con l’altrettanto particolare momento costituito dal culmine dell'ottimo climatico che stiamo trattando.
Se la coincidenza è reale, come è molto probabile, questo ci consente di ritarare i culmini degli ottimi climatici successivi, che erano stati ottenuti provvisoriamente a partire da quell’anno 1000 che avevamo assunto come riferimento approssimato. Otteniamo pertanto come date degli altri culmini climatici gli anni 1536 a.C., 272 a.C. e 992 d.C..
A questo punto potremmo osare spingere l'ipotesi ancora più avanti: il momento più freddo della Piccola Età Glaciale, che troviamo tra il 1600 e il 1650, potrebbe avvenire a ¼ di ciclo dopo il culmine dell'OCM; se fosse vero che esiste quest'altra coincidenza, esso dovrebbe cadere 2538 / 4 = 632 anni dopo il 992, cioè nel 162, e i precedenti culmini freddi si verificherebbero negli anni 360 d.C., 904 a.C., 2168 a.C. e 3432 a.C..
Completata la curva delle temperature, possiamo rivolgere la nostra attenzione ai tempi più recenti per delineare un panorama della situazione che si potrebbe creare in un prossimo futuro. Dall’inizio della rivoluzione industriale la temperatura è cresciuta in un modo più veloce rispetto a quanto abbiamo visto per l’avvio dell’optimum medievale; la linea a tratti ci consente di fare il confronto tra i due andamenti. Tra il 1770 e il 2012 l’aumento reale è stato leggermente superiore al doppio di quanto sarebbe probabilmente avvenuto per vie naturali.
Una delle conseguenze di tale eccesso è il sensibile aumento, di circa mezzo metro, manifestato dal livello marino. Di un simile movimento non c’è traccia durante i precedenti, analoghi miglioramenti climatici. È come se il recente aumento di livello fosse una reazione alle anomalie subite dall’ambiente rispetto ai normali processi naturali. Le acque degli oceani potrebbero essersi fatte carico dell’eccesso di calore indotto dall’attività antropica, subendo di conseguenza una diminuzione della propria densità ed una espansione del volume.
Il pensiero va alla teoria di Lovelock di una Terra (Gaia) dotata di una intelligenza capace di mettere in atto le più varie soluzioni al fine di fronteggiare condizioni di disturbo all’equilibrio che si è instaurato da tempo in favore della vita sul pianeta.
Non ci si deve meravigliare che durante l’optimum climatico del Medio Evo il livello del mare sia potuto rimanere costante nonostante la inevitabile riduzione di volume subita dai ghiacciai di montagna. In effetti, mentre questi si sono ridotti in misura considerevole, le due calotte antartica e groenlandese hanno continuato ad accrescere il loro spessore, tanto è vero che, grazie a questo fatto, possiamo avere le preziose testimonianze dei recenti ottimi climatici dal ghiaccio accumulato fino ad oggi in quelle due aree.
È arduo prevedere come evolverà in futuro la curva reale della temperatura, nel senso della velocità della crescita. Ma sussistono elementi per affermare che un apice verrà raggiunto prima di quanto suggeriscono gli andamenti relativi ai vari ottimi climatici precedenti, prima cioè del 2256, come risulterebbe aggiungendo metà del ciclo di 2528 anni al culmine medievale del 992. Tali elementi derivano dagli studi effettuati sulle variazioni del livello del mare e permettono di fare previsioni molto precise, come si vedrà più avanti. Nell’ambito del presente argomento mi limito ad alcune considerazioni.
Nel 2012 il livello del mare comincerà ad abbassarsi in modo discontinuo, analogamente a come è avvenuto nel 516 a.C.. A partire dal 2233, la velocità del calo di livello crescerà in misura notevole e improvvisamente, fino a quando la superficie del mare si sarà abbassata di almeno 50 m.
Sarà la fase iniziale di una espansione glaciale, perfettamente analoga a quella che si ebbe 40 mila anni fa e che è testimoniata dalla strage improvvisa di mammuth della Siberia. Allora possiamo immaginare che aree come la Scandinavia, la Siberia e il Canada finiranno un'altra volta nella morsa del gelo e verranno sepolti da enormi spessori di ghiaccio.
L'espansione glaciale costringerà a migrare milioni di persone, e, se l'umanità non saprà prepararsi in tempo per l’emergenza, quel che succederà sarà paragonabile agli effetti della carestia che ha colpito l’Egitto alla fine dell’Antico regno.
Carestie
Negli ultimi tempi i rischi di carestia sono stati tamponati da programmi di assistenza all'agricoltura e da solidarietà tra stati, che però non sempre possono essere messi in attuazione, come mostra la recente situazione nel Corno d’Africa. Qui negli ultimi 50 anni una regione grande come la Francia si è completamente desertificata, estendendo verso l’Etiopia e la Somalia meridionale la condizione tipica del Sahel, che fino a poco tempo fa dalle coste della Mauritania poteva essere seguita fino a quelle del Sudan. Negli ultimi anni settanta e ottanta, ripetuti anni di siccità hanno interessato tutta la parte occidentale del Sahel costringendo alla migrazione milioni di persone e provocando almeno 100 mila morti. Più a est, nel 1984, una carestia ha colpito duramente l’Etiopia causando la morte di un milione di persone. Oggi, nel 2011, è la volta della Somalia.
Anche l’Asia e l’Europa non sono rimaste indenni da questo fenomeno. La grande carestia che ha colpito la Cina tra il 1959 e il 1961 è stata la conseguenza di un insieme di disastri naturali e di errori umani. Nel 1959 il fiume Giallo ha inondato la Cina orientale; nel 1960 e 1961 metà del territorio è stata interessata da ulteriori inondazioni e da piogge insistenti e l'altra metà dalla siccità. Alla fine si sono contati 40 milioni di morti, di cui 15 milioni per fame. Non a caso tra il 1958 e il 1960 era stato programmato il Grande balzo in avanti, che prevedeva tra l'altro la collettivizzazione delle terre, senza disporre di tecnici adeguati.
La carestia del Bengala degli anni 1769÷73 si abbatté sulla parte meridionale della pianura del Gange provocando la morte di circa 10 milioni di persone. La regione era amministrata dalla Compagnia britannica delle Indie Orientali, che ignorò la cattiva resa dei raccolti nel 1768; l'anno dopo una grave siccità faceva prevedere un disastro imminente. I provvedimenti presi furono un inasprimento delle tasse, già esose, e la proibizione di tenere scorte di cereali. Quando nel 1770 i raccolti si ridussero enormemente, i contadini non avevano di che sfamarsi. Alcune pestilenze come il vaiolo aggravarono la situazione. Per giunta, anche i tre anni successivi diedero scarsi raccolti.
La grande carestia irlandese degli anni 1845÷49 produsse oltre un milione di morti. Vi furono essenzialmente poche cause. La prima fu l'eccessivo incremento demografico dovuto a precedenti favorevoli condizioni economiche: dal 1700 al 1841 la popolazione passò da 3 a 8,2 milioni di persone; la proprietà terriera si frazionò eccessivamente. Le piccole fattorie sopravvivevano soltanto per l'autosostentamento e in molti casi si coltivavano quasi esclusivamente patate.
La causa scatenante fu una patologia della patata dovuta a un fungo, la peronospora, che distrusse un terzo del raccolto nel 1845, totalmente quello del 1846 e gran parte di quello del 1848.
Gli effetti delle ostilità della natura, che spesso si accumulano con vari errori umani, sono ancora oggi guardati con rassegnazione, anche se si tende a considerarli sempre meno come flagelli mandati come punizione dell'umanità. Credo che questo cambio di atteggiamento sia iniziato a metà del 1800. Vi è una differenza nel modo in cui, almeno in Europa, si sono fronteggiati certi fenomeni. Vediamo ad esempio ciò che avvenne nel 1816, passato alla storia come l'anno senza estate.
Nell'aprile 1815 ci fu una grande esplosione del Tambora, in Indonesia, la più potente esplosione degli ultimi 10 mila anni. Vennero emessi 150 km3 di materiali solidi, e fu introdotta nell'atmosfera una quantità enorme di SO2, considerata uno dei principali responsabili del calo di temperatura che segue queste eruzioni.
L'anno successivo nell'Europa settentrionale, nel nordest degli Usa e nel Canada orientale il freddo sconvolse le coltivazioni dell'estate e si prolungò nell'inverno seguente provocando diverse vittime a causa delle basse temperature. Tuttavia nessuno collegò allora questa aberrazione climatica con l'eruzione del Tambora. Tanto è vero che in Europa, se si vuole parlare di un'esplosione terrificante ci si riferisce a quella del Krakatoa del 1873, che è stata però inferiore in quanto a potenza. La mancanza, nel 1816, di mezzi di comunicazione aveva impedito l’associazione clima-eruzione. Soltanto dalla metà dell’800 le notizie hanno cominciato a circolare con una certa facilità, grazie all'uso del telegrafo. La possibilità di sapere in breve tempo che certi fenomeni disastrosi della natura hanno una causa ben determinata ha creato una rivoluzione nel modo di considerarli: essi probabilmente non verranno più visti come una maledizione, ma come manifestazioni neutrali della natura stessa, nonostante esista tuttora nel mondo della scienza chi ad esempio considera il terremoto di Messina come un castigo divino.
L'uomo perciò potrà guardare alla natura con occhio diverso e, conoscendo manifestazioni e cause, potrà anche evitare o limitare i danni che ne conseguono. Spesso però devo riscontrare con un certo disappunto che siamo ancora lontani dalla corretta lettura di molti fenomeni naturali.
Terremoti.
I terremoti nascono da un accumulo graduale di energia che poi viene rilasciata improvvisamente. Riuniscono pertanto in sé gradualismo e catastrofismo, con la particolarità che l’aspetto graduale è nascosto, mentre quello catastrofico consiste in eventi normalmente osservati in diverse regioni del mondo. Per la maggior parte i terremoti non hanno una ubicazione casuale ma si distribuiscono in corrispondenza di piani di subduzione, dove cioè le placche oceaniche si immettono in profondità al disotto di altre placche, come avviene ad esempio lungo il bordo occidentale dell’America centro-meridionale o lungo il bordo occidentale e settentrionale dell’Oceano Pacifico. Altre volte sono ripartiti dove placche diverse si spostano orizzontalmente l’una rispetto all’altra, come si verifica ad esempio in California (faglia di Sant’Andrea) o nella Turchia settentrionale (faglia nord-anatolica). In Turchia si è potuto osservare, nei 60 anni che vanno dal 1939 al 1999, un trasferimento della sismicità da est verso ovest, con almeno sei episodi distruttivi, lungo segmenti contigui degli oltre 1200 km di questa faglia “trascorrente” che si estende dal Caucaso al Mar Egeo. Ogni volta la parte a nord del singolo segmento si è spostata di un paio di metri rispetto alla parte a sud. Questo dettaglio è importante per comprendere come si svolge il meccanismo che dà origine a terremoti lungo un altro genere di superfici, dove si sta elevando una catena montuosa come l’Appennino, una situazione che ci interessa da vicino.
Considerando una sezione trasversale rispetto alla catena, il passaggio dai punti in cui è stata raggiunta la massima elevazione a quelli che non si sono innalzati non avviene gradualmente, come si pensava un tempo. È graduale il sollevamento delle aree continentali, chiamate per questo “scudi”, dove durante l’ultima puntata glaciale si sono sovrapposte spesse calotte di ghiaccio, ma nei casi delle catene montuose come l’Appennino vi sono delle faglie, con giacitura inclinata, lungo le quali avviene una diversificazione del sollevamento, che perciò è discontinuo in senso geografico. Le faglie hanno radici profonde varie decine di kilometri, e la differenza di sollevamento che si riscontra tra le due parti adiacenti fa sì che esse siano sismogenetiche, cioè sorgenti di terremoti. Può sembrare strano che non sempre, nelle occasioni in cui si manifesta un terremoto di elevata intensità, il movimento relativo tra le due parti in contatto con la faglia non si manifesti in superficie. La spiegazione è semplice se ritorniamo con la mente alla faglia nord-anatolica: lo spostamento non avviene contemporaneamente lungo tutta la superficie, ma in una successione di tratti contigui che vengono attivati in momenti differenti, ovviamente a partire dalle profondità maggiori nel nuovo caso. Nel tratto in cui si erano accumulate le tensioni, le rocce avevano subito una contrazione, in modo analogo a una molla. Quando avviene il rilascio dell’energia, le rocce contratte si ridistendono parzialmente mentre si contraggono altre poste più in alto.
Non mi soffermerò su altre sorgenti di terremoti, riscontrate nelle aree vulcaniche, dove i movimenti magmatici possono spostare masse crostali ma in misura modesta, e sui tremori prodotti dai laghi artificiali creati con la costruzione di grandi dighe, come si è avvenuto a Kariba, in Zambia.
Riguardo ai terremoti, in Italia si tende al fatalismo. Lo dimostra il fatto che, pur avvenendo, in media, un terremoto con conseguenze gravi ogni quattro anni o con effetti catastrofici ogni otto ed essendoci stati più di 200 eventi disastrosi dall’anno 1000 ad oggi, abbiamo dovuto aspettare i casi del Belice del 1968, del Friuli del 1976 e dell’Irpinia del 1980 perché venisse attuata una realistica classificazione sismica del territorio nazionale. Fino al 1980 un comune era riconosciuto sismico solo se aveva subito un terremoto distruttivo successivamente a quello di Messina e Reggio Calabria del 1908. Eppure, se escludiamo le zone pianeggianti del Piemonte, della Lombardia, l’Alto Adige, il Tavoliere delle Puglie e la Sardegna, abbiamo un territorio ad alta pericolosità sismica. E ancora, mentre la normativa si preoccupa di come dovrebbero essere progettate le nuove costruzioni, le vecchie abitazioni non vengono considerate a rischio.
Se dunque la prevenzione presenta gravi lacune, la previsione ne presenta di ancora più gravi. Per non assumersi responsabilità, coloro che hanno il compito istituzionale di occuparsi di questo secondo aspetto affermano che i terremoti non si possono prevedere. Esaminiamo la questione partendo da un episodio molto recente.
Nel 2010 si era diffusa via internet la notizia che l’11 maggio 2011 ci sarebbe stato un terremoto disastroso a Roma. L’informazione era corretta per quanto riguarda la data ma non lo era per il luogo, in quanto il terremoto è avvenuto nella Spagna sudorientale. La previsione veniva attribuita a Raffaele Bendandi, ma in realtà qualcun altro ne era l’artefice poiché il presunto autore, morto nel 1979, non ha lasciato nulla di scritto circa quella data.
Uomo molto attento ai fenomeni naturali e desideroso di comprenderne meccanismi e cause, Bendandi, quando aveva 15 anni, era rimasto molto impressionato dal sisma che colpì Messina e Reggio Calabria e decise di dedicarsi allo studio e alla comprensione dei terremoti. Qualche anno più tardi, passeggiando sulla riva del mare e osservando l’arrivo della marea, ebbe una felice intuizione: se l’effetto gravitazionale della Luna e del Sole può spostare masse d’acqua, perché non pensare che la stessa causa sia applicabile anche alla crosta terrestre, deformandola, e che queste deformazioni possano essere all’origine dei terremoti? Andando oltre in questo ragionamento, se le maree sono massime quando il Sole e la Luna si trovano dalla stessa parte, gli effetti dovrebbero essere ancora maggiori allorché lungo lo stesso allineamento si vengono a disporre gli altri pianeti. Fece dei calcoli e il 27 ottobre del 1914 annotò che una condizione di questo genere si sarebbe verificata il 13 gennaio del 1915.
Quando Avezzano in quella stessa data si trovò all’epicentro del terribile terremoto della Marsica che fece 30 mila vittime, un quarto delle persone residenti nelle aree disastrate, Bendandi consultò il suo taccuino notando che la data corrispondeva a quella da lui prevista. Non ritenne però trattarsi di una semplice coincidenza, bensì di una conferma che la sua idea iniziale era giusta. Quando i calcoli lo portarono a riscontrare che un altro allineamento si sarebbe verificato il 2 gennaio 1924, due mesi prima dell’evento fece registrare da un notaio la sua previsione di un terremoto indicando come area possibile la penisola balcanica. Un terremoto ci fu ma con epicentro a Senigallia, a qualche centinaio di kilometri appena più ad ovest. L’area non era proprio centrata, ma veniva aperta una strada, tanto che il Corriere della sera gli dedicò un articolo in prima pagina chiamandolo “colui che prevede i terremoti”.
Le reazioni non furono tutte positive. Un eminente sismologo e accademico arrivò a denunciare Bendandi. La sua colpa era di essere un autodidatta, non in possesso di laurea. Questa presa di posizione ebbe degli effetti: nel 1926 il regime fascista vietò a Bendandi, pena l’esilio, di annunciare ulteriori previsioni “per non fare fuggire i turisti dall’Italia”.
Riprese la sua attività nel 1950 e, sfruttando la sua grande abilità manuale, costruì un tipo di sismografo di dimensioni ridotte, che pubblicizzò e gli fu anche acquistato dall’estero. Lo strumento avrebbe dovuto dare alle sue previsioni riconoscimento di obiettività. Così sperava fino alla vigilia del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, allorché, vedendo che il suo apparecchio era “quasi impazzito” e comprendendo che si stava preparando una catastrofe, tentò inutilmente di avvertire le autorità di ciò che stava per avvenire; venne trattato con sufficienza e perfino irritazione. In preda allo sconforto e alla rabbia, quando fu di ritorno a casa distrusse il sismografo. Il giorno dopo, quasi mille persone rimasero sotto le macerie.
Attualmente la possibilità di prevedere terremoti in occasione di allineamenti di corpi del sistema solare non è presa in considerazione dai sismologi, che si giustificano affermando che non vi sono evidenze scientifiche che giustifichino questa ipotesi. In realtà è un circolo vizioso perché, se è vero che Bendandi non ha illustrato in modo esplicito il metodo da lui seguito (che comunque è di una semplicità sconcertante), è anche vero che nessun altro si è preso la briga di verificarne l’attendibilità.
L’efficacia del metodo di previsione di Bendandi si può spiegare ammettendo che le deformazioni di marea crostale favoriscono gli spostamenti lungo una frattura dove si siano accumulate delle tensioni, diminuendo gli attriti; in parole povere, facilitano un sisma. Se non ci fossero queste deformazioni, gli spostamenti sarebbero più difficili, l'accumulo delle sollecitazioni continuerebbe fino a un livello superiore e i terremoti si scatenerebbero in misura più violenta. Una condizione importante per l'efficacia di un tale genere di previsione è che si conosca approssimativamente in quale grado la frattura interessata abbia avuto modo di ricaricare sufficientemente le tensioni lungo la sua superficie. In realtà si arriva solo a stimare la vulnerabilità di un'area, espressa da un certo grado di sismicità, ricavandola da notizie storiche, dirette o indirette, dei maggiori sismi del passato.
Poiché non ci si occupa di verificare il grado di accumulo delle tensioni lungo possibili faglie sismogenetiche, con il metodo di Bendandi non si riesce ad individuare con certezza il luogo preciso degli effetti. Inoltre, nell’intervallo di tempo in cui diventa efficace l’azione gravitazionale dell’allineamento astronomico, la regione sotto osservazione si può estendere per diverse centinaia di kilometri a causa della relativamente elevata velocità del movimento di rotazione della Terra. L'11 maggio 2011 invece di verificarsi nell’Italia centrale è capitato in Spagna, ad appena un fuso orario di distanza, o, in termini di tempo, a un'ora di differenza. Se l'anonimo fosse stato uno spagnolo avrebbe detto che il terremoto era da prevedere nella Murcia. A posteriori si comprende che in quest’ultima regione erano più pronte le condizioni per lo scatenarsi di un sisma.
Se da una parte risulta evidente che il metodo in questione per essere efficace non può prescindere dalla conoscenza geologica dei siti, d’altra parte si rileva la necessità che esso sia affiancato da altri metodi di previsione. Nel caso del terremoto della Mursia emerge una ulteriore esigenza: di uno scambio di informazioni extranazionale. Non dobbiamo comunque arrenderci all’idea, purtroppo molto diffusa, che i terremoti non siano prevedibili. Come ci hanno trasmesso storici romani e greci come Plinio e Diogene Laerzio, già nel VI secolo a.C. Anassimandro, Anassimene e Ferecide, tra i primi filosofi della natura greci, erano in grado di prevedere alcuni terremoti o tramite rilievi astronomici oppure, più semplicemente, osservando l’acqua dei pozzi.
Alla fine degli anni ’60 si cominciarono a fare studi sui precursori sismici; in particolare due ricercatori russi segnalarono che nella imminenza di terremoti avvenuti nel Tagikistan avevano osservato una inconsueta, apprezzabile riduzione della velocità delle onde sismiche di compressione rispetto a quelle di taglio. Il fenomeno venne spiegato supponendo l’intervento di una dilatazione delle rocce nelle zone profonde in cui si stava preparando il rilascio dell’energia accumulata lungo una superficie sismogenetica. È nata così la teoria della “dilatanza”: a causa di una concentrazione degli sforzi le rocce interessate subirebbero una minuta fratturazione, aumentando il loro volume. La teoria della dilatanza, in auge durante gli ultimi anni ’80, sembrava risolvere il problema delle previsioni. Anche in questo caso però ci si è dovuti arrendere all’evidenza che il numero degli insuccessi pareggiava quello dei successi. In effetti, se l’ipocentro si trova a profondità minori di una ventina di kilometri, si osservano sollevamenti del piano campagna per un periodo che si può estendere da alcune ore a diversi giorni, come è successo ad esempio in Calabria nei giorni precedenti il terremoto del 1908. Ma per profondità maggiori le pressioni agenti inibiscono il fenomeno.
Grazie a nuove tecniche di rilevamento, negli Stati Uniti furono previsti due terremoti nella zona della faglia di Sant’Andrea, che si verificarono esattamente con l’intensità e nel luogo e nel giorno indicati. Tuttavia è anche vero che in altri casi non sono stati raggiunti i risultati sperati.
Quando il metodo ha successo si nota che, oltre alla diminuzione relativa della velocità di trasmissione delle onde sismiche di compressione, le rocce emettono onde elettromagnetiche ed acustiche e mostrano cambiamenti della resistività elettrica e della permeabilità. Quest’ultimo effetto è rivelato dal rilascio di quantità di radon notevolmente maggiori del consueto in un intervallo di tempo che dipende dall’intensità del sisma: in genere da poche ore per una magnitudo 3 ad alcune decine di anni per una magnitudo 8. L’aumento si verifica fino al momento in cui avviene il movimento, sorgente del terremoto; dopo quell’istante i valori crollano al livello di fondo.
La prima volta che vennero riscontrate concentrazioni anomale di radon fu nel 1966 in occasione di un disastroso terremoto a Tashkent, in Uzbekistan, di magnitudo 7.8. Analizzando l’acqua di 20 pozzi in un raggio di duecento km da quello che si sarebbe rivelato l’epicentro, si è osservato non solo che la quantità del gas è aumentata contemporaneamente in tutti i pozzi ma anche che un giorno prima del sisma la concentrazione è aumentata di due volte rispetto a una settimana prima, mentre è aumentata di 2,5 volte nelle ultime 12 ore, crollando poi subito dopo la scossa principale. Da allora l’aumento del radon viene considerato un prezioso segno premonitore di eventi sismici, come è stato ripetutamente dimostrato in Giappone e lungo la Rift Valley africana. Variazioni di radon sono state registrate nelle acque di falda a Roma e Rieti nei cinque mesi che hanno preceduto il terremoto dell’Irpinia del 1980.
Il radon è l’elemento chimico con numero atomico 86 (l’uranio, che è l’elemento naturale più pesante ha il numero 92); è un gas nobile, chiamato così perché non reagisce con gli altri elementi, ma agisce negativamente sugli esseri viventi in quanto è fortemente radioattivo ed emette facilmente particelle alfa e beta e fotoni gamma a causa della sua relativamente breve vita media, di meno di 4 giorni. Per questa ragione è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo. La sua origine è il decadimento del radio, che a sua volta è un prodotto del decadimento dell’uranio. Esso tende ad accumularsi nei locali chiusi di costruzioni in cui sono stati impiegati materiali di origine vulcanica, come i blocchetti di tufo, che contengono solitamente uranio in percentuali non trascurabili, oppure edificate in aree dove affiorano rocce vulcaniche. In Italia la radioattività prodotta dal radon costituisce il 64 % delle dosi assorbite dalla popolazione provenienti da sorgenti naturali e il 38 % se ci si riferisce alla radioattività totale (in cui è compresa anche quella “medica”, con un 14 %). La concentrazione del radon nell’aria può essere rilevata tramite rivelatori di raggi gamma, che negli ultimi anni sono stati messi sul mercato di dimensioni ridotte e a prezzi modesti.
Nella fase preparatoria di un sisma l’aumento del radon non si manifesta solo nell’acqua dei pozzi profondi ma anche nei pori del terreno sopra la falda e può essere registrato a distanze crescenti con l’intensità dell’evento, fino a centinaia di kilometri. Quando vi fu il terremoto in Turchia del 17 agosto 1999 fu notata una forte anomalia del radon. L’entità dell’aumento è in relazione con l’intensità del sisma e il suo tempo di preparazione: bassa (intorno a 3÷4 volte il normale) per tempi di mesi o anni, che preludono, come già detto, a eventi più intensi, e alta per tempi di preparazione di giorni o settimane. Nel caso del terremoto di San Giuliano del 2002, a L’Aquila il livello è salito a 100 volte il valore di fondo il giorno precedente il sisma.
Nonostante questi studi, molti sismologi in Italia e nel mondo negano la possibilità di prevedere qualunque terremoto. Gli assertori della imprevedibilità dei terremoti adducono a riprova di quanto sostengono il caso di Haicheng e Yingkou, due popolose città della Cina nordorientale distanti tra di loro 35 km. A metà dicembre del 1974 uno sciame sismico aveva interessato Liaoyang, situata circa 70 km più a nord. Era arrivata in seguito la scossa principale con una magnitudo 4,8, avvertita in una vasta area. Poiché la regione era nota per il suo basso grado di sismicità, la popolazione venne tranquillizzata dagli esperti. Comunque, si cominciò ad esaminare l’inclinazione del terreno, la sua resistività elettrica, la concentrazione di radon, senza però che emergesse niente di allarmante. Il 1° febbraio 1976 è iniziato un violento sciame di scosse sismiche, raggiungendo un picco la sera del 3 febbraio con una magnitudo maggiore di 4. All’inizio della notte del 4 febbraio è arrivata la scossa principale con una magnitudo 7,3. Le città erano state abbandonate in tempo. Le case furono distrutte per il 90 %, ma si ebbero solo 2000 morti.
Quando esperti americani e giapponesi si sono recati nelle aree colpite per apprendere le tecniche adottate per la previsione, sono rimasti piuttosto sorpresi constatando che, oltre a registrare le scosse strumentalmente, ci si era basati sul controllo del livello dell’acqua nei pozzi e sul comportamento degli animali; erano stati tenuti sotto osservazione pesci rossi in vasche costruite appositamente, galline nei cortili, mucche nei pascoli e perfino topi e serpenti che fuggivano dalle loro tane. L'intera popolazione era stata mobilitata per le segnalazioni, merito della rivoluzione culturale, che in quegli anni volgeva al suo termine.
Sulle osservazioni del comportamento degli animali, pochi numeri possono servire a dare un’idea della loro utilità: ci furono 60 segnalazioni complessivamente nei due giorni 1 e 2 febbraio, 125 il 3 e 309 il 4, prima del sisma che si è scatenato alle 19,36 ora locale. È presumibile che nella stessa giornata del 4 febbraio i casi si siano intensificati all’approssimarsi dell’evento. Sappiamo che gli animali hanno una percezione dei suoni più ampia di quella dell’uomo, che si estende o nel campo degli ultrasuoni o in quello degli infrasuoni o in entrambi i campi. I pesci ad esempio sono molto sensibili alle vibrazioni di frequenza molto bassa, che, tra quelle “acustiche”, sono quelle assorbite meno dal terreno e quindi trasmesse più lontano dall’epicentro; sono anche in grado di avvertire minimi campi elettrici.
Sembrava dunque che la soluzione fosse stata trovata. Purtroppo l’anno dopo ci si accorse che la situazione era alquanto diversa: il 28 luglio 1976, un terremoto di magnitudo 7,6 si è abbattuto su gli abitanti di Tangshan, una città industriale non distante da Pechino, mietendo 800 mila vittime, o 255 mila secondo la versione ufficiale, comunque la perdita più pesante nella storia dei terremoti. Qui i segni premonitori si sono manifestati solo con pochi giorni di anticipo, a differenza dell’anno precedente a Haicheng, quando erano iniziati alcuni mesi prima del sisma. Tuttavia le segnalazioni dello strano comportamento degli animali erano aumentate in modo allarmante: 81 casi il 26 luglio, 478 il 27 luglio, vigilia dell’evento. A causa del breve preavviso il successo ottenuto in precedenza non si poté ripetere, e ciò ha indotto qualcuno a concludere che l’evacuazione di Haicheng e Yingkou non sia stata attuata per merito degli esperti che controllavano la situazione con le misure dei loro strumenti; la popolazione avrebbe abbandonato di sua iniziativa le città perché impressionata dal succedersi delle scosse che precedettero quella più violenta. Riflettendoci, mi sembra che con grande probabilità gli avvenimenti devono essere interpretati diversamente. Se tutti i cittadini erano stati coinvolti nelle osservazioni, alla fine è anche possibile che abbiano preso loro la decisone di evacuare le città, non casualmente ma conoscendo bene qual’era la situazione. E il fatto è che l’evacuazione c’è stata e questo non può essere negato. Come pure non può essere negato che i segni premonitori c’erano. Semmai c’è da notare che la gente comune è dotata di maggior buon senso e avrebbe deciso l’evacuazione nonostante le rassicurazioni o le indecisioni degli esperti.
Nel settembre del 1920 un terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la zona della Garfagnana con un bilancio di un centinaio di edifici distrutti ma poche vittime perché gli abitanti, allarmati il giorno prima del disastro da una forte scossa, avevano abbandonato le loro case.
A L’Aquila non sarebbero morte 300 persone se fossero state messe a parte di ciò che le strumentazioni annunciavano. Al contrario le autorità hanno fatto di tutto affinché gli abitanti non fossero informati e non si allontanassero. E questo è moralmente imperdonabile, tanto più in quanto è stata attuata una campagna di misinformazione, conforme a quanto succede in Italia da troppo tempo.
Secondo una documentazione storica che risale al 1300, l’area interessata dal sisma in questione era stata colpita da tre terremoti distruttivi negli anni 1349, 1461 e 1703, con tempi di ritorno di eventi di grande intensità di 300 anni o anche meno. Dopo il sisma che ha colpito il Molise il 31 ottobre 2002 con epicentro San Giuliano di Puglia, la comunità sismologica, che per le aspettative si basa soprattutto su un criterio statistico-temporale, metteva in conto un terremoto catastrofico a distanza di tempo di circa otto anni, e il settore aquilano era il primo candidato delle aree più a rischio dell’Appennino. Ancor prima del terremoto molisano, una nota del 1995 di Boschi ed altri autori considerava, tra le 20 regioni sotto osservazione, l’area dell’Aquilano quella dotata di maggiori probabilità di un sisma importante nel successivo ventennio 1995-2015.
Il terremoto de L’Aquila ha avuto una fase preparatoria a metà dicembre 2008 con una scossa di magnitudo 1,8; dal 16 gennaio al 2 aprile 2009 si è registrata una serie di una ventina di scosse comprese tra magnitudo 2,0 e 2,5, intercalate da scosse via via maggiori: il 23 gennaio con un valore 2,7, il 22 febbraio con 3,5, il 16 marzo con 3,7, il 28 marzo con 3,9, il 30 marzo con 4,0 fino all’evento del 6 aprile, alle ore 3:32, con epicentro a 4 km a sud de L’Aquila e un ipocentro a 9,5 km di profondità.
Diversi testimoni hanno descritto fenomeni che hanno preceduto il momento del sisma e vanno sotto il nome di luci sismiche e sono noti fin dall’antichità: luce diffusa, nuvole arrossate, sfere luminose.
Tra il 30 marzo e il 1° aprile i satelliti meteorologici hanno evidenziato un significativo incremento dell’intensità del segnale infrarosso proveniente da una regione che comprendeva l’epicentro del terremoto.
Dalla fine del 2008 fino al 6 aprile successivo sono stati registrati da più stazioni aumenti delle emissioni acustiche nella banda degli ultrasuoni.
Dalla fine del marzo 2009 è stato notato che l’intensità delle onde radio nella banda LF e VLF, di bassa e molto bassa frequenza, provenienti da emittenti lontane diminuiva attraversando l’area dell’epicentro.
Nei giorni precedenti il terremoto le stazioni di rilevamento di Fermo e Perugia hanno riscontrato un aumento della emissione di onde elettromagnetiche proveniente dalla direzione dell’Aquila.
Con una situazione così allarmante, il giorno successivo al verificarsi della scossa di magnitudo 4, ovvero il 31 marzo, si è indetta d’urgenza una riunione a L’Aquila della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, che è la struttura di collegamento tra il Servizio Nazionale della Protezione Civile e la comunità scientifica; essa svolge attività consultiva, tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio. La commissione ha chiuso i lavori affermando che “oggi non ci sono strumenti per fare previsioni e qualunque previsione non ha fondamento scientifico” e comunicando che la situazione era sotto controllo e non doveva destare preoccupazione. La Protezione civile era tanto profondamente convinta della imprevedibilità dei terremoti che a L’Aquila non è stato predisposto neppure un piano di evacuazione. Mi chiedo, se è vero quanto ha dichiarato la Commissione, per quale ragione si sono riuniti quel giorno a L’Aquila? Che senso ha riunirsi per dichiarare di non poter fare previsioni nel campo dei terremoti? Non lo sapevano già prima?
Ma c’era chi viveva con grande preoccupazione quel periodo di mesi di sciame sismico crescente. A partire dal 1999 Giampaolo Giuliani si è interessato insieme a un gruppo di collaboratori al problema della emissione del radon in coincidenza di eventi sismici. Giuliani, un tecnico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, prima di andare in pensione lavorava nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso, dove aveva installato un rivelatore di raggi gamma provenienti dalla disintegrazione del radon. Lo strumento, da lui progettato, era in grado di registrare e trasmettere i dati a una centralina di controllo. Nei giorni 29 e 30 ottobre 2002 misurò concentrazioni anomale e particolarmente elevate del gas e allertò la Protezione civile dell’Abruzzo senza però poter specificare il luogo dove intervenire poiché, disponendo di un solo rivelatore, ciò non era precisabile. Il 31 ottobre un terremoto di magnitudo 5,4 ebbe il suo epicentro a San Giuliano di Puglia, a più di 200 km da L’Aquila, dove morirono 30 persone, di cui 26 bambini. Questo parziale successo lo convinse a potenziare il suo sistema di allarme, arrivando a installare altri quattro apparecchi, tre a L’Aquila e dintorni e uno in provincia di Teramo, e munendosi anche di un sismografo. Affinché i suoi dati potessero essere utilizzati dagli organi competenti a creare condizioni di allerta, li ha resi disponibili sul web in tempo reale. L’esperienza di Giuliani, sviluppata osservando l’incremento rapido di radon in imminenza di decine di terremoti minori lo ha portato alla conclusione che con tre rivelatori di raggi gamma come quelli da lui ideati si può dare l’allarme da 6 a 24 ore prima che un evento sismico si verifichi in un raggio di 80 km da almeno uno di essi, determinando anche intensità e ubicazione. Dopo essere andato in pensione, Giuliani continuava a dirigere i lavori della squadra di collaboratori che aveva creato. Di questa attività la Protezione civile era stata informata.
I risultati ottenuti da Giuliani nei tre mesi precedenti il sisma del 6 aprile 2009 sono riportati nel grafico della Figura 7. Il 19 febbraio 2009 si verificò un sensibile aumento della concentrazione del radon, di tre volte il valore normale, ma poco superiore ad altri valori raggiunti nel mese precedente. Ciò avveniva tre giorni prima della scossa di magnitudo 3,6. Un aumento nettamente maggiore e improvviso venne registrato il 16 marzo, raggiungendo in poche ore un valore quasi doppio rispetto al massimo del 19 febbraio. Il giorno seguente un terremoto di magnitudo 3,6 investiva il bacino di Sulmona.
Il 28 marzo si è verificato un altro picco, inferiore al precedente, precedendo di meno di un giorno la scossa di magnitudo 3,9.
I dati strumentali hanno iniziato ad essere molto preoccupanti a partire dalle ore 18 del 5 aprile, allorché è iniziata una rapida ascesa dei valori di misura, tanto che a mezzanotte, quando la concentrazione di radon è quasi decuplicata, Giuliani, che dopo aver ricevuto una denuncia per procurato allarme era messo nella condizione di non avere più voce in capitolo, ha avvertito chi poteva e ha allontanato la famiglia dalla propria abitazione. Quella notte sembra che anche il palazzo della Prefettura sia stato evacuato, nel silenzio totale della Protezione civile.
Nello stesso giorno in cui si era riunita la Commissione Grandi Rischi, il capo della Protezione Civile, parlando con i giornalisti, se l’è presa con “quegli imbecilli che si divertono a diffondere notizie false”, affermando che “lo sanno tutti che i terremoti non si possono prevedere” e chiedendo un a punizione esemplare per chi diffondeva falsi allarmi.
Al contrario Giuliani asseriva dopo il 6 aprile “Loro sapevano, si poteva prevedere.” e “Quella notte il mio sismografo denunciava una forte scossa di terremoto e ce l'avevamo online. Tutti potevano osservarlo e tanti l'hanno osservato. Poteva essere visto se ci fosse stato qualcuno a lavorare o si fosse preoccupato.”
Sicuramente Giuliani è stato incauto nell’allarmare l’ufficio regionale della Protezione civile in occasione del picco del radon del 28 marzo, ma altrettanto sicuramente le autorità competenti (l’INGV in primo luogo) non hanno fatto ciò che avrebbero dovuto fare e cioè seguire la situazione con tutti i mezzi possibili, tanto più che i dati di Giuliani erano disponibili sul web. Forse poteva sembrare umiliante andare a consultare un semplice tecnico non laureato, ma se si fosse avuto a cuore il bene della comunità in pericolo questo non doveva costituire un ostacolo. Il paradosso è che Giuliani, da pensionato, dedica volontariamente il suo tempo e denaro a un lavoro che dovrebbero svolgere le istituzioni.
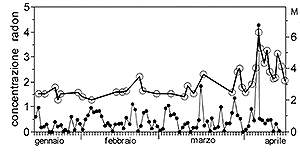
Figura 7 – Il grafico inferiore illustra come è cambiata la concentrazione del radon nell’aria (in Bq/m3) a L’Aquila dal 15 gennaio al 15 aprile 2009. Il grafico superiore riporta la magnitudo locale delle maggiori scosse nello stesso periodo. Da Giuliani (2009), modificato.
Se i tecnici dell’INGV avessero voluto prestare attenzione ai dati immessi da Giuliani in rete (vedi la figura 7), molto probabilmente avrebbero dato l’allarme. Ma un forte pregiudizio lo ha impedito. È stata una grande occasione mancata.
Certamente le istituzioni si sono accorte di avere sbagliato, altrimenti non avrebbero cercato in vari modi di diminuire l’importanza di ciò che era avvenuto. Da molte parti è stato espresso il sospetto che la valutazione dell’energia del terremoto sia stata sottostimata. Sul sito di varie sezioni dell’INGV è apparsa fin dall’inizio una magnitudo 5,8 della scala Richter. Dopo un anno il valore è stato rettificato in 5,9 dopo “calcoli successivi di maggior precisione”, ma sul web si trova ancora il valore 5,8.
Fatto sta che al centro di ricerca GFZ di Potsdam, in Germania, risulta un valore di magnitudo locale di 6,2, ottenuto dalla elaborazione dei dati di 87 stazioni del pianeta, le quali hanno fornito valori della magnitudine locale compresi tra 5,5 e 7,4. Il minimo di 5,5 proviene proprio da L’Aquila, e ciò fa pensare che molto probabilmente il sismografo di questa stazione sia rimasto bloccato prima che venissero raggiunte le accelerazioni maggiori. Considerando il peso che ha la stazione più prossima all’epicentro, si può supporre che senza questo dato si dovrebbe stimare la magnitudo del sisma del 6 aprile 2009 non inferiore a 6,3.
In genere la diversità delle stime della magnitudo tra elaboratori diversi dipende dall’intervallo di tempo che si considera. È ovvio che se si allarga questo intervallo il valore medio diminuisce. Se invece si assume solo il valore massimo di accelerazione registrata, che per il terremoto de L’Aquila è stata di 0,68 g, la magnitudo nella scala Richter diventa 7,4. Può essere utile sapere che l’energia liberata con una magnitudo 7,0 è 31,6 volte maggiore che con una magnitudo 6,0.
Per apprezzare meglio le differenze di significato tra i numeri fin qui presentati, nella scala Richter un terremoto con magnitudo 5,0-5,9 viene classificato “moderato”; esso “può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte e danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici”. Un terremoto di magnitudo 6,0-6,9 è “forte” e “può avere un raggio di azione di 160 kilometri, dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata”; con magnitudo tra 7,0 e 7,9 il terremoto è “molto forte” e “può causare gravi danni su zone estese”.
Il sospetto che la valutazione compiuta dall’INGV sia stata volutamente contenuta entro la classe dei terremoti moderati è quindi molto forte. Se esso fosse confermato, screditerebbe chi lo dirige per un atto di furbizia meschina, che non si addice a chi dovrebbe avere un comportamento più responsabile nei confronti della comunità.
In conclusione, vi sono diversi metodi di previsione dei terremoti, dotati di una certa probabilità di funzionare. Per quale ragione allora non si cerca di utilizzarli tutti, nessuno escluso? Se nessun metodo venisse escluso, non è difficile affermare che con il tempo si potrà arrivare a prevedere una sempre maggiore parte dei terremoti. Dire invece che i terremoti (in assoluto) non sono prevedibili suona come un alibi da parte di chi non vuole assumersi alcuna responsabilità, contando magari sull’ignoranza del grande pubblico e sulla sua accettazione di non venire informato.
L’Appennino
Sono rimasto molto impressionato dall’affermazione di un geologo “di fama mondiale” di una università straniera in visita alla regione terremotata, il quale dichiarava in una intervista che la regione d’Abruzzo “è stata spinta verso l’alto in un’era geologicamente recente e ora sta affondando sotto il suo stesso peso.” Precisava che la compressione derivante dall’avvicinamento dell’Africa all’Europa aveva spinto verso l’alto la catena montuosa dell’Appennino; infine proseguiva così: “Ora, il problema è che questa catena montuosa è diventata instabile dal punto di vista gravitazionale e sta lentamente collassando, allargando la crosta terrestre e causando la formazione di faglie.”
Sono rimasto impressionato perché conosco bene l’Appennino e so che la situazione è esattamente contraria a quanto affermato dal geologo di fama mondiale, che probabilmente conosce l’Appennino solo per essersi affidato malamente alle pagine di qualche rivista. Sarebbe come dire che la torre di Pisa l’hanno costruita inclinata e da allora si sta lentamente raddrizzando. Ritengo che simili dichiarazioni sia indicative di una generale mancanza di chiarezza in questo campo.
Poiché la previsione dei terremoti non può prescindere dal modello che si assume per interpretare il comportamento delle strutture, è importante precisare attraverso quali fasi si è arrivati alla costruzione della catena che costituisce l’ossatura della nostra penisola. Prenderò come campione l’Appennino centrale, di cui ho maggiore esperienza osservativa.
Purtroppo non c’è unanimità di interpretazione su come e quando l’Appennino si è formato. Due tipi di modelli si fronteggiano. Il primo fa derivare la formazione di una catena montuosa dall’azione compressiva derivante dall’avvicinamento di due aree della litosfera, così che lo spessore più superficiale, dove si trovano serie sedimentarie facilmente plasmabili dalle forze in gioco, si deve contrarre in senso orizzontale. La catena montuosa che ha ispirato questa ricostruzione orogenetica è costituita dagli Appalachi, nel nordest degli Stati Uniti. Trasferendo l’idea all’Appennino, questo si dovrebbe sollevare come un grande cuneo con l’apice rivolto verso il basso.
Il secondo tipo di modello fa entrare in gioco in maniera esclusiva uno spostamento orizzontale di un pacco di sedimenti, che scivolano su un piano inclinato. Uno spostamento del genere crea idealmente un accumulo nella parte più avanzata e un diradamento dei sedimenti nelle parti più arretrate. Di tale diradamento, nel Lazio, sono testimoni il Monte Circeo e il Monte Soratte.
Secondo il mio modo di vedere, l'Appennino si è formato, poco più di un milione di anni fa, per uno scivolamento, su un piano inclinato, di sedimenti stratificati al disopra di una superficie di debole attrito, rappresentata da depositi evaporitici del Trias superiore. Questi depositi particolari, creati in condizioni simili a quelli del Messiniano superiore di cui ho parlato in precedenza, hanno costituito un perfetto “lubrificante tettonico”. A facilitare gli spostamenti hanno grandemente influito le immancabili vibrazioni che accompagnano sempre i movimenti di grandi masse. Il piano si era inclinato, verso l'Adriatico, a causa di un movimento convettivo nel mantello analogo a quelli che fanno scendere crosta oceanica di una placca al disotto di un'altra placca, ma probabilmente in misura più rapida, e terminava in una zona di fossa tettonica forse più profonda delle attuali fosse oceaniche e con un fondo piatto.
I sedimenti scivolati erano di due tipi essenzialmente: la parte inferiore, di età tra 7 e 200 milioni di anni e spessa mediamente circa 8 km, era costituita da strati di natura prevalentemente calcarea, mentre la parte superiore, di età tra 1,1 e 7 milioni di anni e dello spessore di 6 km, era costituita da materiali detritici, come le sabbie e le argille, accumulati con una velocità notevolmente superiore, grazie ad un accentuato approfondimento della porzione di litosfera su cui tutta la successione appoggiava.
Dopo lo scivolamento, la fossa si era colmata con serie sedimentarie che si erano venute sovrapponendo a quelle preesistenti, formando così una pila di notevole spessore. Allorché le forze che hanno causato l'approfondimento della fossa tettonica con il suo piano inclinato sono diminuite, si è creata una condizione di disequilibrio isostatico per la relativamente bassa densità dei materiali accumulati, il cui peso non era in grado di compensare adeguatamente la pressione dal basso.
Possiamo riconoscere dove si trovavano le maggiori profondità della fossa perché lì, dove lo squilibrio era massimo, i sedimenti sono poi stati spinti verso l’alto fino a raggiungere le posizioni più elevate.
Man mano che questo innalzamento avveniva, la successione sedimentaria veniva a trovarsi sempre più al di sopra del livello marino e sottoposta quindi ad una erosione veloce. Per inciso, per questa ragione nella zona dei maggiori sollevamenti non troviamo più i sedimenti detritici, facilmente erodibili, degli ultimi 5 milioni di anni; e questo ha fatto a lungo pensare che non vi si siano mai deposti.
A causa dell'erosione più intensa nelle aree di maggior sollevamento, quelle aree si sono fortemente alleggerite, accentuando ancora di più il disequilibrio isostatico.
Il passaggio dalle zone a sollevamento maggiore a quelle a sollevamento minore o nullo non avviene con continuità, come già accennato in precedenza. Possiamo immaginare, per semplicità, che vi sia un cuneo centrale, con l'apice rivolto verso l'alto, delimitato verso il Tirreno e verso l'Adriatico da due piani inclinati di 45° e che, allontanandoci da questo cuneo centrale, vi siano alcuni gradini delimitati anch'essi da faglie parallele alle prime. Mentre il nucleo centrale e i gradini più prossimi ad esso sono ancora in sollevamento, i gradini più distali non si sollevano più. Sulla base di questa differenza di comportamento possiamo distinguere faglie attive e faglie non più attive.
Per sapere se una faglia è attiva, e quindi potenziale sorgente di terremoti, vi sono essenzialmente tre modi: 1) vedere se la sua superficie in affioramento si presenta con aspetti che indicano una recente esposizione, 2) notare se lungo il suo piano si presentano ipocentri di terremoti o 3) eseguire una analisi morfologica basata sui terrazzi di abrasione marina.
Per mezzo delle misure delle quote a cui si trovano questi terrazzi si possono ricostruire anche le varie fasi di sollevamento. Se al limite l’area che stiamo esaminando non ha subito innalzamenti negli ultimi 270 mila anni, le quote misurate si presentano con gli stessi valori di quelli che appaiono graficamente nella figura 3. Se invece si diversificano al disopra di una quota determinata, ciò vuole dire che i sollevamenti sono avvenuti solo fino al momento in cui il mare si era portato a quella quota. Per esempio in Calabria la situazione è la stessa della serie di riferimento soltanto dai 144 m in giù, e da questo particolare deduciamo che la Calabria è diventata stabile a partire da 170 mila anni fa.
Una successione di quote esattamente identiche, estesa tra 0 e 144 m, si riscontra sia nell’isola di Milos, nel Mar Egeo, che all’isola di Pasqua, nell’Oceano Pacifico, a dimostrazione che tali aree sono attualmente stabili da un punto di vista orogenetico, ovvero prive di movimenti di sollevamento.
Ė rilevante ai fini delle nostre previsioni che, inaspettatamente, durante la fase ingressiva della grande trasgressione marina studiata nell’Appennino centrale (v. figura 3), non sono presenti affatto segni di sollevamento, neppure dove il sollevamento è stato maggiore. Lo dimostra l’esame delle quote dei due terrazzi formatisi in questa fase; essi appartengono a uno stazionamento primario, durato 2213 anni (l’unico rappresentato in figura), e a uno stazionamento secondario, rimasto per 148 anni (troppo ridotto per poter apparire). Quest’ultimo è posizionato 285 m al disotto del culmine ingressivo di 822 m, cioè a 537 m, mentre il primario si trova 265 m più in basso, a quota 272. Quasi certamente un altro secondario si è formato all’incirca 245 m più in basso ancora, a metà del tratto che separa il primario suddetto con il precedente primario, che segna il massimo abbassamento del mare nella fase glaciale finale della glaciazione del Riss, intorno a -200 m. Questo secondario doveva dunque trovarsi poche decine di m sopra lo zero attuale, in una fascia di valori di quote dove successivamente il mare si è fermato tante di quelle volte che ha cancellato inesorabilmente le tracce precedenti.
Il periodo di tranquillità orogenica è durato per circa 5000 anni, fino a quando cioè il livello del mare ha cominciato a diminuire dopo aver raggiunto il suo culmine, 822 m sopra la posizione attuale. Possiamo seguire ciò che è avvenuto, esaminando un caso reale, nell’area intorno al Monte Vettore, la cima più alta dei Sibillini (2476 m). Qui il culmine raggiunto dalla trasgressione si trova alla quota di 2386 m, indicando che negli ultimi 270 mila anni i Sibillini si sono alzati di 2386 – 822 = 1564 m. Il primo calo del mare è segnato da uno stazionamento secondario (anche questo, come tutti gli stazionamenti secondari, non compare in figura 3), rintracciabile 14 m più in basso del culmine trasgressivo, conformemente a quanto si riscontra in altre aree che hanno subito sollevamenti di altra entità. Per arrivare al passo seguente e rinvenire uno stazionamento primario, occorrerebbe abbassarsi ulteriormente di 15 m, ma constatiamo che questo livello appare 37 m più in basso del previsto. I 37 m sono scanditi da interruzioni, tutte testimoni che quell’innalzamento dell’area è avvenuto in diverse tappe, forse una decina; e ogni volta il mare, pur continuando a stazionare alla stessa quota globale di 822 – 14 = 808 m, andava incidendo nuovi terrazzi, perlopiù difficilmente identificabili per via della breve durata delle singole erosioni. Se poi cerchiamo la posizione dello stazionamento primario successivo, che dovrebbe essere 24 m più giù, lo troviamo, ma dislocato anch’esso di ulteriori 36 m. E potremmo continuare a controllare che cosa è accaduto ad altri 34 stazionamenti primari successivi.
Se rappresentassimo in un grafico i sollevamenti assegnabili ad ogni stazionamento del mare, potremmo ricostruire, ma fino a un certo momento, con quale velocità quest’area dell’Appennino si è andata innalzando. Il grafico ci suggerirebbe che nell’insieme questa velocità non è diminuita, confermando che l’area è ancora sismicamente attiva. Un particolare che potrebbe essere di rilievo è che, non appena i sollevamenti hanno cominciato a manifestarsi, questi sono stati di intensità doppia rispetto alla media che ha caratterizzato i tempi successivi.
La tranquillità orogenica dell’area del Monte Vettore durante la fase ingressiva del mare non è un caso a sé, ma è stata riscontrata per diverse altre aree dove sono stati riconosciuti i terrazzi della fase ingressiva e che presentano entità di sollevamento ben distinte per ciascuna area. C’è quindi da chiedersi il perché di una tale uniformità di comportamento.
Possiamo cercare di dare una risposta riferendoci al secondo tipo di modello presentato in precedenza. Quando il cuneo con cui ho schematizzato la struttura centrale dell’Appennino si solleva, esso deve farsi largo allontanando da sé le parti adiacenti. Se la Terra si dilata, il meccanismo può operare più facilmente, altrimenti è contrastato. Nella fase ingressiva del mare la Terra è stata soggetta a contrazione, e quindi il sollevamento non era favorito, mentre al contrario, appena la dilatazione si è attuata con la fase regressiva del mare, tutto l’Appennino ha iniziato a sollevarsi.
Vulcani
È opinione diffusa che le espansioni glaciali possano avere come causa concomitante una intensa attività vulcanica. La cenere vulcanica che raggiunge la stratosfera in effetti ha la capacità di respingere parte della radiazione solare e quindi di raffreddare la temperatura globale. Tuttavia non si tiene conto che i vulcani possono sortire anche l'effetto opposto, come dimostrato dal fatto che, dei 17 vulcani entrati in attività con maggiore energia dal 1783 ad oggi, solo 9 hanno raffreddato la base dell'atmosfera. Nei rimanenti 8 casi i prodotti rilasciati non hanno raggiunto la stratosfera, rimanendo più in basso, entro la troposfera, ed hanno agito accrescendo l'effetto serra.
I vulcani rappresentano un argomento importante da comprendere perché ci trasmettono informazioni preziose non soltanto sulla composizione dei materiali profondi della Terra ma anche sulla dinamica del globo. La maggior parte di essi hanno la loro alimentazione lungo i piani di subduzione, dove una placca, o zolla, si immerge al disotto di un'altra, e a partire da un limitato intervallo di profondità, cosicché in superficie ne emerge un allineamento, perlopiù arcuato, che può essere collocato in mare, come accade per le Piccole Antille, le Aleutine, le isole della Sonda, il Giappone, oppure sulla terraferma, come sono i casi del bordo occidentale delle Americhe, della penisola italiana, della Nuova Zelanda. Poiché i piani di subduzione vanno a interessare rocce perlopiù di origine sedimentaria, che pertanto conservano ancora buona parte dell'acqua in cui si sono deposte, i magmi che si formano ne possiedono tali quantità da indurre in tali vulcani un carattere esplosivo; ciò è dovuto al fatto che, allorché il materiale magmatico giunge a modesta profondità, l’acqua si trasforma in vapore con una espansione di 1000 volte il volume originario.
Alcuni vulcani, che in un documentario giornalistico della BBC sono stati battezzati supervulcani, esplodono con particolare violenza emettendo volumi eccezionali di materiali, dell'ordine di 1000 km3. È stato calcolato che Toba, in Indonesia, 74 mila anni fa ha emesso 2000 km3 di ignimbrite, 800 di ceneri e oltre 6 miliardi di tonnellate di anidride solforosa. L'gnimbrite, una massa ricchissima di gas che la rende estremamente fluida, e per questo detta anche “nube ardente”, ha coperto una superficie di circa 25 mila km2 con uno spessore variabile da 400 a 50 m. Sul fondo di tutti i mari si è deposto uno strato di cenere di grande spessore, che presso l'India ha raggiunto i 4 m.
L’enorme quantità di cenere immessa nell’atmosfera da questa eruzione deve avere avuto grandi ripercussioni sia sulla fauna che sulla flora di tutto il mondo, portando all’estinzione un grande numero di individui, con rischi di sopravvivenza per tutte le specie. Alcuni ricercatori, partendo dall’osservazione della scarsa diversità genetica dell’uomo moderno, attribuiscono all’eruzione di Toba un effetto di “collo di bottiglia” per la popolazione umana, che avrebbe visto ridursi il numero degli individui a poche migliaia. È come dire che la nostra specie si sarebbe trovata ad un passo dall’estinzione. Per fortuna la frequenza con cui questo tipo di esplosione si manifesta è dell'ordine delle centinaia di migliaia di anni o più.
Anche Yellowstone appartiene alla categoria dei supervulcani, come pure i Campi Flegrei, Taupo in Nuova Zelanda, Rabaul in Nuova Guinea e pochi altri.
Un secondo particolare, oltre alla enorme quantità di materiale emesso, che caratterizza questi mostri naturali è la grande depressione che rimane dopo l'esplosione e che comunemente viene chiamata “caldera”. Il termine caldera, anziché cratere, implica un meccanismo abbastanza particolare di formazione della cavità superficiale residua. Per inciso, su Wikipedia, che ha una pagina sull’argomento, leggiamo che spesso “le caldere sono la sede di laghi formatisi dall'accumulo dell'acqua piovana che rimane intrappolata all'interno della caldera.”
Evidentemente chi l'ha scritto non sa nulla di idrogeologia perché in realtà quell'acqua non è intrappolata ma è la parte libera di una falda che permea tutti i terreni circostanti. Questo sfogo vuole denunciare da un lato la facilità con cui si incorre in interpretazioni sbagliate della realtà perché ci si ferma alla prima impressione, e dall'altro l'omertà che circonda queste interpretazioni. Ma l’aspetto più interessante si riscontra leggendo sul web, oltre che nella letteratura specifica, come si forma una caldera. La spiegazione più recente può essere trovata ancora su Wikipedia.
Innanzi tutto occorre immaginare che sotto un edificio vulcanico, a una certa profondità, ci sia un volume occupato da magma, chiamato “camera magmatica”. In essa si viene a sviluppare una pressione che fa rigonfiare la crosta sovrastante, dando origine a fratture verticali che partono dalla periferia della camera; quando le fratture sono tutte formate, si isola un volume cilindrico di roccia, e, “ovviamente, il cilindro non riesce a rimanere al suo posto e quindi collassa. Il collasso provoca lo svuotamento istantaneo della camera magmatica, con l'emissione della tipica enorme quantità di tufi, ignimbriti e quant'altro”.
Se non capite che cosa significa quell'ovviamente, è colpa vostra. Anche un bambino capirebbe che quel cilindro, sotto la spinta del magma che preme verso l'alto, deve sprofondare verso il basso. Una spiegazione così grossolana di come si forma una caldera si può fornire solo ammettendo che, qualunque cosa venga detta, c’è un auditorio che accetterà comunque la conclusione. A questa ricostruzione si potrebbe obiettare in primo luogo che, se vogliamo rispettare le regole della meccanica, un inarcamento della superficie crea fratture, di trazione, che non potranno essere verticali, ma saranno disposte a raggiera con una inclinazione di poco più di 60° rispetto a un piano orizzontale. In secondo luogo, le fratture e le dislocazioni conseguenti si riscontrano soltanto in una parte delle grandi depressioni, come avviene ad esempio nel caso del vulcano Toba (dimensioni 96 x 29 km), in Indonesia, in cui la morfologia residua può essere facilmente interpretata mediante un forte sollevamento della superficie, conseguente al rigonfiamento della camera magmatica, e un successivo collasso quando i materiali contenuti nella camera magmatica trovano una via di sfogo ed emergono da qualche punto. Ancora le stesse condizioni si riconoscono per la Valles Caldera, in New Mexico (19 km), la Creede Caldera, nel Colorado (22 km), la Timber Mountain Caldera, nel Nevada (30 ÷ 35 km).
Ma nei casi di Santorini, Krakatoa, Bolsena, Bracciano, Vulcano Laziale, le caratteristiche che fanno pensare ad uno sprofondamento sono assenti. In questi vulcani si parla di caldere perché per convenzione è stato stabilito che i crateri devono avere al massimo dimensioni di 1-1,5 km. Essendo un cratere il prodotto di un’esplosione, si dichiara implicitamente che la formazione della cavità di un vulcano di grandi dimensioni, maggiori di 1,5 km, non può essere l’effetto diretto e semplice di una grande esplosione. Non è difficile notare come in questo modo di interpretare la realtà si manifesta l’influenza di Lyell nell’arginare la ricostruzione di fenomeni troppo violenti. Si può riconoscere inoltre l’influenza di Hutton, con l’avversione per una flessibilità delle interpretazioni, giacché l’uniformità dei fenomeni vuole che sopra 1,5 km tutte le depressioni vengano uniformate come caldere.
C'è sbigottimento non perché circolano tali idee, ma per il fatto che idee simili non vengono contrastate. Se io volessi pubblicare un mio studio di vulcanologia in cui faccio presente questi difetti euristici, non troverei nessuna rivista disposta ad accettare il mio lavoro: esso romperebbe l'uniformità che si vuole conservare, in ottemperanza ai suggerimenti di Hutton. L'uniformità dei fenomeni invocata alla fine del '700 si mantiene se diventa l'uniformità della visione dei fenomeni.
Vi sono vari punti, chiamati “punti caldi”, in cui arrivano in superficie magmi da zone più profonde e attingono ai materiali del mantello, di natura basaltica. Il loro contenuto in gas è decisamente minore e perciò danno luogo a tranquille colate di lava o a fenomeni scarsamente esplosivi. I punti caldi possono anch'essi trovarsi in mare, come le Hawaii, oppure nelle zone continentali, come l'Etna. Le ragioni dell’esistenza dei punti caldi sono ancora misteriose.
Anche lungo le dorsali medioceaniche, che sono fratture tra placca e placca in allontanamento tra di loro, troviamo vulcani di questo tipo. Islanda, Galapagos e Azzorre si trovano in una situazione del genere.
Da alcune di queste fratture sono fuoriuscite le lave degli enormi espandimenti basaltici che hanno avvelenato il ciclo alimentare e causato le maggiori estinzioni di massa della fauna marina e continentale molti milioni di anni orsono. A causa della deriva dei continenti oggi le linee specifiche da cui quelle singole masse sono venute a giorno non si trovano più in corrispondenza di dorsali medioceaniche o più in generale di discontinuità tra placche, bensì all’interno di aree continentali stabili. Se gli espandimenti basaltici sono relativamente recenti, questa deriva non si è ancora manifestata, come è il caso dell’Africa nordorientale, in prossimità della Rift Valley.
Il pericolo dei grandi espandimenti responsabili di estinzioni di massa si può presentare ogni 180 milioni di anni circa; considerando che l'ultima volta risale a 65 milioni di anni fa, ne siamo ben lontani.
Tra i fenomeni che non riusciamo a spiegare c’è il risveglio di più vulcani a brevissima distanza di tempo. Si potrebbe dire che si tratta di un caso, ma potrebbe non esserlo. Ad esempio l'eruzione del Tambora, in Indonesia, del 1815 è stato un evento eccezionale, il maggior evento esplosivo degli ultimi 10 mila anni. È avvenuto soltanto 32 anni dopo un evento, non esplosivo ma effusivo, del Monte Laki in Islanda, caratterizzato da un’energia emessa di valore triplo. Il Laki a sua volta è entrato in attività ad appena un mese di distanza dalla eruzione più violenta a memoria d'uomo dell'Asama, in Giappone. Cito inoltre il Pinatubo, nelle Filippine, che nel 1991 ha preceduto di solo un mese il Cerro Hudson, in Cile, con altre importanti esplosioni. Aggiungo il Monte Pelée e il Soufrière, situati l'uno a 160 km dall'altro nelle Antille, che hanno eruttato disastrosamente nel 1902 a distanza di un giorno, seguiti, dopo 5 mesi, dal Santa Maria, in Guatemala, con un'altra eruzione epocale. Come interpretare dunque tali fenomeni?
Tra i fenomeni che non riusciamo a spiegare c’è il risveglio di più vulcani a brevissima distanza di tempo. Si potrebbe dire che si tratta di un caso, ma potrebbe non esserlo. Ad esempio l'eruzione del Tambora, in Indonesia, del 1815 è stato un evento eccezionale, il maggior evento esplosivo degli ultimi 10 mila anni. È avvenuto soltanto 32 anni dopo un evento, non esplosivo ma effusivo, del Monte Laki in Islanda, caratterizzato da un’energia emessa di valore triplo. Il Laki a sua volta è entrato in attività ad appena un mese di distanza dalla eruzione più violenta a memoria d'uomo dell'Asama, in Giappone. Cito inoltre il Pinatubo, nelle Filippine, che nel 1991 ha preceduto di solo un mese il Cerro Hudson, in Cile, con altre importanti esplosioni. Aggiungo il Monte Pelée e il Soufrière, situati l'uno a 160 km dall'altro nelle Antille, che hanno eruttato disastrosamente nel 1902 a distanza di un giorno, seguiti, dopo 5 mesi, dal Santa Maria, in Guatemala, con un'altra eruzione epocale. Come interpretare dunque tali fenomeni?
L'eruzione del Monte Pelée, nella Martinica, merita di essere ricordata come un caso tipico di catastrofe annunciata e di estrema sottovalutazione del pericolo. Nell'aprile 1902 ci furono ripetute emissioni di cenere sempre più importanti, accompagnate da tremori. Nel 1792 e nel 1851 si erano verificate due modeste eruzioni, ma era noto che il vulcano aveva vissuto episodi assai violenti che avevano lasciato come traccia ampi crateri. Poiché il 10 maggio si sarebbero dovute tenere le elezioni politiche, il governo rassicurò la popolazione facendo scrivere su un giornale locale che il Monte Pelée non rappresentava un pericolo. In effetti però la situazione diventava sempre più grave, e il 5 maggio una massa incandescente si riversò in una forra che sfociava nella piana dove sorgeva la città di Saint-Pierre raggiungendo il mare e provocando 30 morti. Per fornire un'ulteriore rassicurazione, la sera del 7 maggio lo stesso governatore giunse sul luogo accompagnato dalla moglie.
Ma il mattino seguente, alle 7,50, vi fu una tremenda esplosione e una grande nube ardente in soli due minuti percorse la stessa forra di tre giorni prima e si espanse sulla pianura di Saint-Pierre, seppellendo l’intera area con 30 mila abitanti. Si salvarono due persone e una parte degli equipaggi di due navi ormeggiate davanti alla città.
Dopo la concentrazione di eventi catastrofici nel tempo, è altrettanto interessante la loro concentrazione nello spazio. L'esplosione del Tambora, che, come già detto, è stata di enorme potenza, è avvenuta nello stesso arcipelago in cui 74 mila anni or sono il vulcano Toba provocò una delle più grandi esplosioni nella storia della Terra.
Tsunami
Anche il Krakatoa è ubicato nella stessa area, tra Sumatra e Giava; nel 1883 ha dato luogo a un'esplosione che, in tempi recenti, è stata seconda unicamente a quella del Tambora. Trattandosi di un'isola di modeste dimensioni, l'onda d'urto si è trasmessa immediatamente al mare circostante provocando un maremoto, o tsunami, con un'onda alta inizialmente 40 m, onda che ha viaggiato ad una velocità maggiore di 1100 km/h e ha spazzato via quasi 300 città e villaggi intorno allo Stretto della Sonda facendo annegare oltre 36 mila persone.
Un'esplosione analoga è accaduta a Santorini, nell'Egeo, nel 1630 a.C.. Quando nel 1967 sono iniziati gli scavi archeologici e al disotto di uno spesso strato di ceneri e lapilli è comparsa l'antica città di Thira, ben conservata come Pompei, ci si è potuti accorgere che la città era stata evacuata. È segno che i vulcani lanciano chiari segnali delle loro intenzioni.
Si è stimato che l'onda anomala prodotta da questa esplosione avesse all'inizio un'altezza di 60 m e dovesse essere alta almeno 20 m quando ha investito la costa settentrionale dell'isola di Creta, dove erano ubicate le principali città, mettendo fine alla splendida civiltà minoica.
Allo stesso tsunami è attribuibile un deposito di pomici dello spessore di 5 m rinvenuto alla sommità di una baia dell’isola di Anaphi, 24 km ad est di Santorini, ad una quota di 250 m sul livello del mare. Il deposito a così grande altezza si spiega con la morfologia del luogo e per il fatto che l'onda anomala, quando raggiunge fondali meno profondi, diminuisce di velocità e di lunghezza d'onda, aumentando in compenso la propria altezza.
Un maremoto rimasto nella memoria dei paesi europei che si affacciano sull’Oceano Atlantico e di alcuni dell’Africa nordoccidentale è quello che colpì in particolare Lisbona nel 1755. La causa era un sisma tremendo, di magnitudo stimata tra 8,7 e 9,0 della scala Richter, emesso qualche decina di kilometri più a sud della capitale portoghese lungo la frattura che separa le placche eurasiatica e africana passando per lo Stretto di Gibilterra. L’onda anomala era alta 15 m a Lisbona e 18 m a Cadice.
Lo tsunami del dicembre 2004 che ha investito il sud est asiatico ha portato nuovamente alla ribalta mondiale questo genere di fenomeno naturale, che non era sconosciuto ma evidentemente è stato presto dimenticato, come dimostra il fatto che regioni pur interessate in un passato non troppo remoto sono state colte impreparate. Una serie di onde anomale alte fino a 15 m ha colpito tutte le coste bagnate dall'oceano Indiano, arrivando in 10 ore a creare danni anche in Sudafrica. Vi sono state almeno 230 mila vittime. Sorprende che 55 mila di esse sono state contate in India e Sri Lanka, dove lo tsunami è giunto tre ore più tardi, senza che vi sia stato alcun allarme efficace. È sorprendente perché i crolli di borsa si trasmettono dal Giappone a New York in pochi minuti.
Purtroppo, a disastro avvenuto, ci si accorge che, qualora ci fosse stato un sistema di allarme globale, il costo sarebbe stato molto minore rispetto a quello degli interventi messi in atto dopo il disastro.
Come l’esplosione del Krakatoa del 1873 è entrata nella sfera di una consapevolezza globale grazie alla possibilità di comunicazione offerta dal telegrafo, così lo tsunami del sudest asiatico del 2004 vi è entrato per merito del mezzo televisivo. Fino al 2004 la prevenzione contro i maremoti era praticata negli USA occidentali, Hawaii in testa, e in Giappone. Oggigiorno si pensa ovunque agli tsunami con più realismo: si vanno a riesumare i vari eventi del passato con i loro effetti. E naturalmente ci si guarda attorno per prevedere da dove possa venire la prossima minaccia.
Il maremoto del 2004 è stato originato da un sisma prodotto a 30 km di profondità e a 160 km ad ovest di Sumatra, in un’area dove la placca indiana si infila al disotto della placca birmana ed è all’origine della formazione della fossa delle isole della Sonda. Il terremoto ha sprigionato un’energia un milione e mezzo di volte maggiore di quella liberata dall'insieme delle due bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki; con una magnitudo 9,3, esso è stato per intensità, nella storia delle registrazioni sismologiche, il secondo dopo quello del Cile del 1960, di magnitudo 9,5 (nella scala del momento sismico più recentemente adottata rispetto alla scala Richter). Non è casuale che ambedue gli eventi siano occorsi lungo un piano di subduzione. Lungo discontinuità di questo genere, tra placche o microplacche, si concentrano gli spostamenti della litosfera. Come già detto, le zone di subduzione distribuite intorno all’Oceano Pacifico sono tra le più attive e rappresentano il maggiore pericolo sia per i terremoti che per i maremoti. Di conseguenza non è neppure casuale che le massime altezze raggiunte dalle onde anomale derivate da terremoti si siano verificate alle Hawaii (300 m) e in Giappone (200 m).
Esiste infine un terzo genere di sorgenti di maremoti di grande potenza, che ha cominciato a essere preso in seria considerazione quando, una decina di anni fa, è stato pubblicato su una importante rivista di geofisica un articolo secondo il quale uno tsunami di proporzioni mai immaginate potrebbe essere scatenato nell’Oceano Atlantico da una immensa frana che minaccia di riattivarsi dopo essersi già messa in moto in un recente passato. Il luogo è il fianco occidentale di un vulcano del parco naturale di Cumbre Vieja, sull’isola di La Palma, la più attiva delle Canarie da un punto di vista vulcanico; il suo nome è Caldera de Taburiente. Qui un lastrone di materiale vulcanico ampio oltre 1000 km2 e con uno spessore medio di circa 500 m si è già staccato in seguito ad una recente esplosione e, dopo essersi spostato di un paio di kilometri, si è fermato in una nuova posizione di equilibrio. Ciò che potrebbe riattivare il movimento e fare cadere l’intera massa in mare è una delle prossime eruzioni, la cui cadenza varia tra le decine e le centinaia di anni. Considerando che non tutte le esplosioni, di tipo stromboliano, sono accompagnate da terremoti e che in genere sono di modesta potenza, si ritiene che l’evento disastroso potrebbe verificarsi con maggiori probabilità tra un migliaio di anni.
È stato stimato che la frana, scivolando in mare, formerebbe una cupola d’acqua alta 900 m e larga alcune decine di kilometri, la quale, collassando immediatamente, darebbe origine a una prima onda. La sua altezza sarebbe di 100 m sulle coste dell’Africa nordoccidentale, mentre raggiungerebbe un valore massimo di 50 m sul continente americano. In Europa l’effetto sarebbe minore, ma sempre abbastanza grave, creando notevoli danni in Portogallo, Spagna, Francia ed Inghilterra.
In passato si sono verificati casi analoghi di tsunami provocati da frane finite in mare: il più rilevante è quello accaduto nel 1958 nella baya di Letuya, in Alaska, allorché il crollo del fianco di una montagna produsse un’onda alta fino a 515 m.
Ricordo che in Italia, nel 1963, abbiamo sperimentato purtroppo un’onda alta 200 quando il Monte Toc è crollato nel bacino del Vaiont, evento che tuttavia la natura non avrebbe mai scatenato con quelle modalità.
Tra gli tsunami provocati da frane avvenute sui fianchi di un vulcano possiamo citare quello, seppur modesto, del dicembre 2002 alla Sciara del Fuoco di Stromboli, le cui onde, alte alcuni metri, hanno danneggiato due centri abitati. Il volume di materiale scivolato in mare è stato di 5 milioni di metri cubi, centomila volte minore di quello che potrebbe mobilitarsi a La Palma.
Più recentemente è stata portata all'attenzione del pubblico la possibilità che nella stessa area del Tirreno meridionale avvenga un maremoto prodotto da una enorme frana che si originerebbe completamente sotto il livello del mare, sui fianchi di un vulcano sommerso, il Monte Marsili, il quale, dopo essere stato scoperto quasi un secolo fa, è stato messo sotto inchiesta. Cresciuto su una crosta di tipo oceanico spessa soltanto 10 km, un centinaio di km a nord delle Eolie occidentali, si contende con l'Etna il primato di vulcano più grande d'Europa con un'altezza di circa 3000 m e una larghezza media di 50 km. Si tratta di un vulcano attivo formatosi intorno a 200 mila anni fa, più giovane ancora dell’Etna, che ha solo 270 mila anni. L’esame della sua morfologia condotto molto recentemente da una nave oceanografica ha rivelato zone potenzialmente prossime alla instabilità; vi sarebbe pertanto la possibilità di crolli pericolosi in quanto sorgenti di tsunami anche di grande potenza, capaci di interessare in modo disastroso le coste di Sicilia, Calabria e Campania. È auspicabile che il seguito di questa campagna di rilevamento porti a una valutazione più precisa e meno allarmante.
Ultimamente si è scoperto che anche il maremoto che nel 1908 ha colpito Messina e Reggio Calabria raggiungendo un’altezza massima di 13 m è stato originato da una frana sottomarina. Non si può tuttavia escludere una sovrapposizione di un’onda generata dalla frana e di un’altra, minore, prodotta direttamente dal sisma, anch’esso originatosi in mare. Tra le due città vi è una frattura profonda lungo la quale è stato osservato, grazie ai rilevamenti satellitari, che la Sicilia e la Calabria si stanno allontanando l’una dall’altra ad una velocità di 2÷3 mm all’anno seguendo una direzione NW-SE.
In Italia si verifica in media un maremoto ogni 5 anni. Le regioni più colpite sono la zone dello stretto di Messina e delle Eolie, la Liguria e l'Adriatico.
Le più massive frane sottomarine documentate hanno avuto luogo tra 500 e 200 mila anni fa al largo delle coste del Cile meridionale, dove la placca di Nazca si immerge per subduzione al disotto della placca del Sud America, coinvolgendo tra 250 e 500 kilometri cubi di sedimenti. Se la datazione degli eventi è corretta, ne deriva che l’intervallo medio di tempo fra una frana e l’altra è di circa 150-200 mila anni.
Il tipico ambiente in cui si sviluppano frane sottomarine è quello della scarpata continentale. Una frana avviene quando si supera il limite di stabilità, che corrisponde alla condizione di equilibrio tra forze attive, dovute al peso dei sedimenti, e forze resistenti, perlopiù dovute ad attrito.
Ciò avviene più di frequente là dove vi è intenso apporto detritico, tipicamente dove vi è la foce di un fiume; il grande potere abrasivo sul fondo di queste masse, che si muovono sempre sullo stesso allineamento, a lungo andare fa sì che queste scavino un solco profondo. È in tal modo che si sviluppano i cañon sottomarini, i quali sembrano rappresentare la continuazione delle valli dei fiumi fino alle piane abissali.
Si stima che il 95 % dei maremoti più violenti sia provocato da eventi sismici sottomarini. Le frane sottomarine sono responsabili del 15 per cento degli tsunami di tutto il mondo, mentre per gli eventi meno importanti sono comunemente sottostimate come causa. Perlopiù le loro dimensioni sono ridotte rispetto ai due casi citati del Marsili e del Taburiente. Ma non sempre vi è proporzione tra volume che viene mobilitato e importanza del maremoto: nel 1998 al largo di Papua Nuova Guinea una massa relativamente piccola, fra i 5 e i 10 chilometri cubi di materiali, ha provocato un'onda che localmente ha raggiunto i 15 metri di altezza e ucciso circa 2200 persone.
Se ci limitiamo a tenere sotto osservazione le frane sottomarine che hanno interessato materiali di natura argillosa accumulati su una zona di scarpata in tempi molto recenti, possiamo notare un particolare curioso. La probabilità che siano coinvolti in un movimento franoso è relativamente alta nei momenti in cui arriva a termine un ciclo di 2528 anni. Una spiegazione al fenomeno può essere data considerando che quanto descritto avviene contemporaneamente ai casi di subsidenza discontinua, come quelli che hanno riguardato le città di Sibari e Tartesso.
Ambedue i fenomeni sono attribuibili a modificazioni del campo elettrico della terra solida, il cui effetto è di aumentare improvvisamente le forze attrattive tra le particelle del terreno e di creare di conseguenza un eccesso di pressione all’interno del materiale. All'inizio è la fase liquida che sopporta tutta la sovrapressione, e, dato che la bassa permeabilità impedisce all'acqua in eccesso di uscire prontamente, le singole particelle subiscono un forte rallentamento nel portarsi maggiormente a contatto. Mentre il peso del terreno rimane invariato, la resistenza di attrito è diminuita poiché la sovrapressione dell'acqua annulla un equivalente valore di pressione dovuta al peso. Se il terreno si trovava sulla scarpata continentale in una condizione prossima al limite di stabilità, facilmente esso franerà, e in molti casi si trascinerà dietro materiale che era alle sue spalle. Questo fenomeno è accaduto almeno due volte, intorno a 2500 e 5000 anni fa, sulla scarpata continentale antistante Oristano, e il movimento ha coinvolto i sedimenti del golfo più recenti fino alla sua propaggine sudorientale.
È ovvio che le condizioni di instabilità di una scarpata subacquea, come di tutte le scarpate, peggiorano se interviene una scossa di terremoto seppure di modesta entità. E qui entriamo in un altro campo.
Bradisismi
I bradisismi, letteralmente “terremoti lenti”, non sono catastrofici per le vite umane, ma perché possono produrre perdite materiali. Il termine va applicato a tutti quei movimenti verticali del suolo, con esclusione di quelli di subsidenza (che vengono trattati nel capitolo seguente). Per la maggiore facilità con cui vengono registrati, gli spostamenti vengono di solito riferiti alla posizione della superficie del mare in un determinato momento, che tende a rimanere costante a meno che non intervengano variazioni globali, chiamate “eustatiche”. A rigore perciò vanno compresi nei bradisismi quei movimenti di riassestamento isostatico della litosfera, che si svolgono su periodi di decine di migliaia di anni, dovuti alla formazione e al dissolvimento delle calotte glaciali. Un altro tipo di bradisismo è legato a movimenti tra le placche della crosta terrestre; Bari ha conosciuto intorno all’anno 1000 un movimento di questo genere, che ha costretto a costruire la cattedrale più in alto delle case circostanti.
Ma i bradisismi più comuni si trovano in ambiente vulcanico. Una delle aree più note è quella dei Campi Flegrei con il cosiddetto “Serapeo” di Pozzuoli (in realtà un luogo di mercato) e con la città romana di Baia, ora sommersa dal mare. Questi movimenti verticali della superficie terrestre vengono attribuiti generalmente all’intrusione di materiale magmatico in zone poco profonde e allo svuotamento totale o parziale della camera magmatica. In effetti il succedersi di un bradisismo positivo e di uno negativo, ovvero l’innalzamento e l’abbassamento del suolo, svoltosi tra il X secolo e il 1970 ha avuto il suo culmine quando, nel 1538, si è verificata l’eruzione del Monte Nuovo, che ha formato un cono vulcanico alto appena 133 m sul livello del mare e con un cratere largo 420 m.
Spesso un bradisismo positivo non è seguito, o non viene seguito nella stessa misura, dal suo antagonista. Lo possiamo dedurre ad esempio osservando dal centro del cratere di Santorini le pareti interne del cratere, lasciate esposte dall’esplosione. Si sovrappongono per quasi 300 m vari strati, ben distinguibili per il diverso colore; le loro superfici di separazione non rivelano tracce di un ruscellamento delle acque e suggeriscono pertanto che essi si sono deposti sottacqua. In origine Santorini era dunque un vulcano sommerso, e la sua emersione può essere spiegata con l’intrusione di materiale magmatico che solo parzialmente è poi venuto all’esterno.
Vi è un caso in cui è stato verificato che un bradisismo positivo e il seguente bradisismo negativo sono avvenuti nella stessa misura. Milos, con le prossime Kimolos e Poliegos, ha subito in età medioevale un innalzamento di almeno 6 m, e diverse costruzioni sono state erette sulle terre appena emerse; poi il mare ha recuperato ciò che aveva abbandonato, ed ora quelle costruzioni si trovano sul fondo marino.
L'isola di Milos è ricca di tracce di livelli del mare degli ultimi 4800 anni grazie al fatto che vi affiorano rocce vulcaniche a grana molto fina facilmente modellabili dal mare. Si sono così formate numerose piattaforme orizzontali, le quali testimoniano il carattere discontinuo delle variazioni del livello del mare e consentono di eseguire misure di estrema precisione di queste tracce di stazionamenti marini. È per merito di queste piattaforme che è stato possibile tracciare il grafico di figura 6b in cui si può osservare che nel momento dell’optimum climatico interglaciale il mare è arrivato alla quota di 7,0 m (questa misura è riferita al livello medio del mare locale del 1995).
Quando i dati di Milo sono stati confrontati con le misure di nove cosiddetti “solchi di battente” presenti a Rodi tra le quote di 2,1 e 3,7 m, si è riscontrata una perfetta identità di successione. Escludendo che le coincidenze possano essere frutto del caso, se ne può inferire che dopo il bradisismo l'isola è tornata esattamente alla quota a cui si trovava prima; quindi il fenomeno non ha alterato la sua posizione verticale se non per un periodo limitato, confermando l’idea che la crosta terrestre tende a mantenere una costante condizione di equilibrio isostatico.
È probabile che il bradisismo di Milo sia stato causato dalla creazione di una bolla di fluido (acqua), accumulata lungo una discontinuità stratigrafica al cui tetto fosse presente uno strato impermeabile. Quando in seguito il fluido è riuscito a trovare una via di fuga, la bolla d’acqua si è esaurita, e tutto è ritornato allo stato precedente.
Una situazione analoga potrebbe essersi verificata a Baia; una parte rilevante della città è stata edificata su un ripiano situato ora a una quota di circa -4 m. Alla stessa quota, in quasi tutte le regioni costiere marine (escludendo quelle instabili per isostasia glaciale o perché in sollevamento orogenetico), è probabile riscontrare la presenza di un terrazzo di abrasione marina formatosi all'incirca tra 10 mila e 7500 anni or sono. La quota di -4 m rappresenta una delle quote tipiche a cui il mare ha stazionato tanto a lungo da ricavare un ripiano caratterizzato da una debolissima pendenza. In seguito, intorno a 7200 anni fa, il mare si è portato a una quota poco superiore a 1,5 m (vedi figura 2).
Quando Baia fu edificata, nel II secolo a.C., era un luogo ambito per la sua bellezza naturale; se non era stato sfruttato in precedenza per la sua posizione può significare che fosse emerso dal mare poco tempo prima della conquista romana. A questo bradisismo positivo non documentato successe un bradisismo opposto in due fasi distinte intorno al IV e al VII secolo d.C., il quale sommerse definitivamente gran parte dell’abitato. È possibile che l’abbassamento dell’area sia stato della stessa misura del precedente innalzamento, così che il ripiano dell’attuale quota -4 m sia ritornato nella situazione in cui si era formato originariamente ad opera dell’erosione marina, quando il mare stazionava 4 m sotto il livello odierno.
Città scomparse per subsidenza
Vi sono diversi altri casi di città, ubicate in prossimità delle coste, che sono state abbandonate dopo aver subito un abbassamento ed essere finite al disotto del livello del mare. Esse non sono però rimaste vittime di un bradisismo, trovandosi lontane da centri vulcanici; sono accomunate dal fatto di essere state costruite in zone soggette a una rapida sedimentazione, come avviene tipicamente nelle aree delle foci dei fiumi, specialmente le foci a delta.
Le informazioni più utili alla presente ricerca provengono da Sibari, una delle prime città greche in Italia, fondata sulle coste ioniche da coloni achei forse nel 720 a.C., in un luogo ideale sia per i commerci che per la fertilità dell’entroterra. E infatti Sibari era conosciuta per la sua ricchezza e per il lusso e la vita agiata dei suoi abitanti. Sappiamo che fu abbandonata nel 510 a.C.. Secondo quanto narra Erodoto, i Crotoniati, entrati in guerra con i Sibariti, distrussero gli argini del fiume Crati, rendendo inabitabile la zona. In effetti il Crati è un fiume pensile, e la rottura dei suoi argini può avere portato all’allagamento della pianura; ma la causa della fine di Sibari fu un’altra: un fenomeno di subsidenza, che ha abbassato il piano archeologico fino ad arrivare a una quota di oltre 4 m sotto l'odierno livello del mare. L'abbassamento della città fu però più rilevante, di una decina di metri, se si tiene conto che al tempo della fondazione il livello del mare era 4 m più alto dell’attuale e che Sibari era stata costruita sulle sabbie di una duna costiera, probabilmente 1÷2 m sopra il livello marino dell'epoca. Bisogna tuttavia rilevare che il movimento non è avvenuto in una sola volta, bensì in due riprese, come possiamo appurare seguendo le vicende successive. Nel 445 a.C. i coloni greci ritornarono sul sito della città, che intanto era stato colmato da depositi alluvionali, e nel 443 fondarono una nuova città, alla quale dettero il nome di Thurii. Visitando l’area possiamo osservare il secondo piano archeologico, che attualmente si trova poco più di 1 m sotto il livello del mare. Considerando che nel 443 a.C. il mare era poco più in alto di 2 m rispetto all’attuale livello (vedi figura 6b), possiamo concludere che la città si è abbassata di circa 3,5 m. Anche Thurii perciò è sprofondata, ma ha cominciato a farlo dopo un secolo e mezzo di esistenza: a posteriori possiamo asserire che questa seconda fase della subsidenza è iniziata nel 295 a.C.. Dopo un altro secolo, nel 193 a. C., le condizioni dovevano essere ritornate adatte a un insediamento, e i Romani vi fondarono una terza città, che prese il nome di Copia.
Si ritiene comunemente che la sorte toccata a Sibari e a Thurii sia derivata dalla natura del luogo, soggetto a una subsidenza capricciosa, ma la realtà è diversa. Infatti Copia si trova oggi alla stessa quota di quando fu fondata, 0,5 m sopra il livello del mare. Inoltre, Sibari visse per più di due secoli prima di essere abbandonata. Quindi la subsidenza ha riguardato due intervalli di tempo limitati, il primo dei quali va da un po' prima del 510 a.C. a un po' prima del 443 mentre il secondo va dal 295 a poco prima del 193 a.C..
Come mai la subsidenza colpì Sibari e poi Thurii ma non interessò il lungo periodo, di 2200 anni, della città di Copia? E come mai la subsidenza che ha interessato Sibari ha agito per meno di un secolo soltanto e quella di Thurii probabilmente altrettanto? Prima di dare una risposta voglio illustrare i casi di Velia e di Roma per dimostrare che i due episodi che interessarono Sibari e Thurii non sono accaduti in una successione casuale ma hanno fatto parte di un processo globale.
Elea, chiamata poi Velia dai Romani, è un’altra colonia fondata da Greci; si trova in Campania, 20 km a NO di Palinuro, ed è nota perché vi ha fondato la sua scuola Parmenide. Alcuni dei suoi manufatti sono stati sepolti sotto 4 m di alluvioni alla fine del VI secolo a.C.. A distanza di circa 130 anni la parte bassa di Elea è stata ricostruita nella stessa area. Nel IV secolo a.C. i nuovi insediamenti sono stati sepolti sotto altri 5 m di sedimenti. Pur essendo le date meno precise riguardo al caso precedente, possiamo tuttavia riconoscere una forte analogia tra i due eventi di Elea e gli eventi di Sibari-Thurii. Inoltre qui abbiamo una chiara testimonianza di un abbassamento occorso al livello del mare, dato che i due porti di cui era dotata Elea sono situati ora a centinaia di metri dalla riva.
A Roma la piana formata dalle alluvioni recenti del Tevere non era abitata fino al IV secolo a.C.; vi si svolgevano esclusivamente le esercitazioni militari, come ci racconta Tito Livio. Per questa ragione manca la possibilità di trovare raffronti con il primo episodio di subsidenza rilevato a Sibari ed Elea. Tuttavia vi troviamo resti archeologici che possono essere messi in relazione con il secondo episodio.
Vi sono due aree adatte allo scopo. Nella prima, ubicata presso Piazza del Popolo, è stata ritrovata l’Ara Pacis, fatta erigere da Augusto nel 10 a. C.. La base del monumento era 2,7 m al disotto della superficie libera dell’acqua e 2,3 m al disopra della falda del tempo della costruzione, a dimostrazione di un abbassamento del piano campagna di 5 m intervenuto in venti secoli. Il piano di calpestio è stato elevato di 1,3 m nel 150 d.C., quando una buona parte del cedimento era già avvenuta. I tempi sono stati molto più lunghi rispetto ai tempi di Sibari a causa della natura meno permeabile del complesso delle alluvioni di questo nuovo sito; il forte rallentamento della fuoriuscita dell'acqua in eccesso ha fatto protrarre la compattazione dei terreni fino a quasi i nostri giorni.
Il secondo luogo preso in esame è l’area sacra di Largo di Torre Argentina, dove gli scavi eseguiti nel 1927 hanno messo in luce tre piani archeologici a quote diverse. Il primo di essi, databile tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C., si trova ad appena 0,2 m sopra l’attuale superficie di falda; al disopra è stato esteso uno strato di macerie dello spessore di 1,4 m probabilmente in seguito al devastante incendio del 111 a.C.. Nell’80 d.C. un altro furioso incendio colpì gran parte del Campo Marzio; le macerie furono di nuovo spianate e si creò un ulteriore rinterro di 0,6 m. La necessità delle opere di elevazione del piano di calpestio dell’area sacra di Largo Argentina si accordano con la situazione che si era venuta instaurando dopo le guerre puniche, cioè dalla metà del II secolo a.C. e per un periodo di tempo durato qualche secolo, allorché Roma fu afflitta da ripetute piene del Tevere. Comunemente le numerose alluvioni di questo periodo si spiegano con un aumento della piovosità; ora sappiamo che esse sono state la conseguenza di un fenomeno di subsidenza.
All’incirca nel 540 a.C. gli Etruschi fondarono Spina nella parte meridionale del delta del Po. La città era fiorente, come dimostra lo stupendo vasellame rinvenuto nelle necropoli che gli abitanti avevano scavato nella sabbia delle dune prossime alla città e oggi conservato nel museo archeologico di Ferrara. L'età delle tombe ci informa che questa Spina fiorente è stata abitata fino alla metà del III secolo a.C.. Quando nel 1922 venne scavato un canale di bonifica per prosciugare parzialmente le valli di Comacchio, rividero la luce, a piccola profondità, case molto modeste, costruite con l’impiego di canne, paglia e argilla. Dove era finita la Spina dei ricchi commerci? Sicuramente la città del 540 è sprofondata nei terreni melmosi contemporaneamente a Sibari. Poiché sappiamo che il sito ha continuato ad essere abitato, vuol dire che fu fondata una seconda Spina. La nuova città doveva essere fiorente come la prima, e con la prima ha condiviso la sorte sprofondando anch’essa allo stesso tempo di Thurii. Quindi al disotto della città ritrovata recentemente ce ne dovrebbero essere ancora non una ma due.
Le necropoli non hanno subìto la subsidenza perché costruite su terreni sabbiosi che, allorché si depongono, non assumono una struttura molto aperta come accade alle argille. Perciò le sabbie si riducono poco di spessore e non fanno sprofondare ciò che vi è stato costruito sopra. In tal modo spieghiamo perché ad Alessandria d'Egitto e a Crotone le parti della città costruite sulla sabbia sono rimaste al disopra del livello del mare, mentre quelle costruite su sedimenti lagunari a grana molto fina hanno subito grandi abbassamenti, tanto da trovarsi attualmente sommerse anche sotto diversi metri di acqua, come ad Alessandria.
La città di Tartesso è stata fondata dai Fenici alla fine del secondo millennio a.C. presso la foce del Guadalquivir. Citata più volte dalla Bibbia, da Erodoto e molti altri storici successivi, era un importante porto di imbarco dello stagno e dell’argento proveniente dalle miniere dell’interno. Si sostiene che sia stata distrutta dai Cartaginesi, con cui entrò in conflitto, intorno al 500 a.C.. In effetti di Tartesso si perdono quasi improvvisamente le tracce: essa è scomparsa nel nulla.
Sappiamo dalla Geografia di Strabone, scritta all’inizio dell’era volgare, che era situata su un’isola distante almeno 25 km dalla foce del Guadalquivir. Probabilmente egli ha ripreso l’informazione da vari altri autori, tra cui il geografo greco Posidonio, il quale essendo vissuto a Cadice nel I secolo a.C. e avendo quindi avuto occasioni di raccogliere notizie da gente del luogo, affermava che la città era situata tra due bracci del fiume Tartesso.In realtà il Guadalquivir, prima delle recenti opere idrauliche che hanno rettificato il fiume, aveva due rami che lambivano un’isola nella parte più interna dell’ampia pianura, di quasi 300 km2, interposta tra Siviglia e l’Oceano Atlantico (vedi Figura 8a). La pianura, estremamente piatta, presenta per quasi tutta la sua estensione quote comprese tra 2 e 3 m sul livello del mare; è un luogo ideale per la coltivazione del riso.
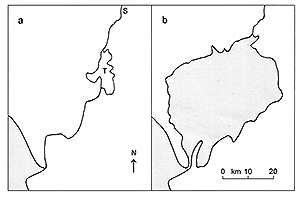
Figura 8 – a) Stato recente della pianura compresa tra Siviglia (S) e la foce del Guadalquivir. Qui si ritiene che fosse ubicata la città di Tartesso (T). b) La stessa area al tempo della conquista romana era occupata da una grande laguna, chiamata da Avieno “Lacus Ligustinus”.
Ma al tempo della dominazione romana la situazione dell’area doveva essere molto diversa. Secondo Avieno, vissuto nel IV secolo d.C. e autore di “Ora maritima”, un poema in cui sono descritte le coste dell’impero, alle spalle della duna costiera che separava dall’oceano la pianura di Tartesso si estendeva una grande laguna, da lui denominata Lacus Ligustinus (Figura 8b). Quindi, la geografia del luogo era completamente mutata, e la pianura era stata sostituita da una distesa di acqua. Il luogo dove sorgeva Tartesso era dunque sprofondato. Al contrario il cordone dunare si era conservato indenne per tutto il periodo in esame; le sabbie che lo compongono si sono deposte sempre nella stessa posizione durante la risalita postglaciale del mare e non sono state coinvolte dalla subsidenza delle argille che si sono accumulate nell’area protetta più all’interno.
Schulten, intuendo che Tartesso era sprofondata sotto il livello del mare, nel 1933 aveva intrapreso degli scavi, difficili perché condotti sotto falda, trovando comunque delle mura; tra i reperti vi era un anello con incisi alcuni caratteri simili all'etrusco.
Probabilmente al tempo di Tartesso la situazione dell’area era simile a quella dei tempi moderni. A causa della natura molto fina dei sedimenti su cui era stata fondata, ha avuto lo stesso destino di Sibari, impiegando però un maggior numero di anni per portarsi sotto il livello del mare.
Consolidazione discontinua delle argille
Nel 2012 le aree dove sorgevano Sibari, Spina e Tartesso, insieme ad altre che esamineremo più avanti, saranno di nuovo soggette a subsidenza e nel loro insieme costituiranno probabilmente l'evento più catastrofico che incombe a breve termine. L'argomento è perciò di grande importanza sul piano pratico e darò qui una sommaria spiegazione delle ragioni di questi strani fenomeni di subsidenza che avvengono a partire da momenti particolari. Se vogliamo conoscere la storia di un'argilla e più in generale come questi materiali evolvono nel tempo, bisogna ricorrere a un parametro geotecnico, la pressione di preconsolidazione, che viene determinata in laboratorio e comunemente viene intesa come la massima pressione che l'argilla ha subito nel suo passato. Studiando le successioni di sedimenti degli ultimi 5 milioni di anni del versante tirrenico, si è notato che la preconsolidazione non cresce in maniera continua procedendo dai terreni più recenti a quelli più antichi, ma si mantiene con lo stesso valore per ampi intervalli di tempo per poi cambiare improvvisamente. Queste discontinuità si verificano ciclicamente ogni 700 mila anni circa. Il fenomeno è spiegabile solo ammettendo che la pressione rivelata dalla preconsolidazione è governata, non dalle forze peso dei sedimenti sovrastanti ma da forze di natura elettrica, le uniche forze che, oltre alla gravità, possono produrre tale effetto. Questo fenomeno è sfruttato nel trattamento “geoelettrico” di versanti argillosi in frana, che consiste nell’estrarre acqua dai terreni interessati dal movimento mediante la creazione di campi elettrici continui.
Esaminando i sedimenti argillosi degli ultimi 15 mila anni si riscontra ancora, anche se a una scala più piccola, un analogo aumento discontinuo dei valori di preconsolidazione in profondità. Qui la durata dei cicli è di circa 2500 anni, la stessa che finora abbiamo visto controllare il livello del mare e i cambiamenti climatici; più precisamente, vedremo che il periodo è di 2528 anni.
Quando nel 2012 inizierà un ciclo nuovo, i sedimenti depositati nell'ultimo ciclo, ovvero l’attuale, verranno improvvisamente ad appartenere al penultimo, e si può prevedere che assumeranno i valori di preconsolidazione, di densità e di contenuto in acqua caratteristici dei sedimenti che ancora oggi fanno parte del penultimo ciclo. L'attuale penultimo ciclo diverrà il terzultimo e così via. Vi sarà insomma una compattazione improvvisa che riguarderà tutti i sedimenti degli ultimi cinque cicli, con effetti massimi nei sedimenti più giovani poiché sono più ricchi di acqua e ne potranno perdere una percentuale maggiore.
Nell'ambito di un ciclo di 2528 anni si può riconoscere un secondo momento particolare, oltre quello in cui termina il ciclo stesso; ciò risulta più chiaro se si osserva come è formato il grafico della variazione del livello marino nella figura 6b. In ogni ciclo compaiono due stazionamenti principali del mare, che sono di due durate diverse: uno primario di circa 2200 anni e un altro secondario di circa 150 anni, separati da due periodi di transizione della durata media una ottantina di anni.
Come ci suggeriscono le storie delle città sprofondate, la fine dello stazionamento secondario, avvenuto nel 295 a.C., viene ad assumere un significato analogo a quello della fine dello stazionamento primario del 516 a.C.. Infatti Sibari e Thurii hanno cominciato a sprofondare al termine di uno stazionamento del mare primario e secondario rispettivamente.
Vorrei aprire una parentesi su subsidenza e su alti livelli del mare, due argomenti che si intrecciano.
I cambiamenti recenti del livello del mare
È evidente che l’improvviso abbassamento di un terreno, senza alcun passaggio graduale, contraddice il principio dell'attualismo di Lyell. Ma c'è di più. Lo stesso principio è alla base dell'attuale discrepanza esistente tra le ricostruzioni compiute dalla comunità scientifica internazionale dei cambiamenti del livello del mare e la ricostruzione descritta in queste pagine. Coloro che desiderano verificare in quale maniera nascono situazioni del genere, possono provare a cercare sul web come viene descritta la variazione del livello marino dall'inizio della deglaciazione ad oggi, cioè negli ultimi 25 mila anni. A partire da allora, il mare viene fatto salire con gradualità fino ad oggi, senza che ci sia un solo istante in cui esso abbia oltrepassato la posizione attuale. Questo modo di vedere le cose è in stretta relazione con il modo di considerare il fenomeno descritto di subsidenza. Infatti, se noi oggi ci soffermiamo ad osservare come si comporta un terreno depostosi recentemente (nelle ultime migliaia di anni) in aree prossime alle rive del mare, ci accorgiamo che esso non è soggetto a subsidenza. Di conseguenza, per il principio dell'attualismo, i terreni recenti non subsiedono, normalmente. Immaginiamo ora di effettuare un sondaggio su una piana alluvionale dei Paesi Bassi o della costa orientale degli USA e di attraversare terreni degli ultimi 10 mila anni, che sono frequenti in queste due regioni. Troveremo facilmente degli strati di torba, deposti in condizioni di laguna. Le torbe si prestano bene al riconoscimento della loro età poiché sono estremamente ricche di composti organici su cui potremo eseguire datazioni con il metodo del radiocarbonio; inoltre, considerando che generalmente nelle lagune esse si accumulano poco sotto il livello del mare, di riflesso potremo osservare come si sposta questo livello nel tempo. Se la fortuna ci assiste, potremo trovare anche torbe deposte in un momento molto recente, come 1000 anni fa; il ritrovamento ci persuaderà che la nostra scelta del luogo del sondaggio, ovvero una pianura posta qualche decimetro sopra l'attuale livello del mare (come d’altronde è prassi comune tra gli studiosi del livello del mare) è stata opportuna, visto che stiamo tenendo sotto controllo quasi tutto l'arco di tempo che volevamo studiare.
Di certo, operando in questo modo, abbiamo escluso la possibilità di trovare tracce del livello marino al disopra della quota a cui abbiamo fatto iniziare il sondaggio. Infatti non ci è venuto in mente che quelle torbe e i terreni che le contengono siano soggetti a subsidenza, dato che attualmente non lo fanno, e che quindi alcuni di essi possano essersi abbassati da una posizione occupata in precedenza più in alto. Dunque abbiamo seguito il principio di Lyell, come fanno tutti o quasi.
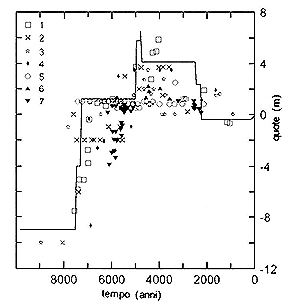
Figura 9 – Ricostruzione della variazione del livello del mare negli ultimi 10 mila anni, confrontata con datazioni con il metodo del radiocarbonio di indicatori di livello marino raccolti in aree stabili. Da Mortari (2005).
Se però andiamo con pazienza a cercare nella letteratura geologica, troviamo che vi sono dei siti, ubicati in aree sicuramente stabili da un punto di vista orogenico e quindi esenti dall’aver subito capricciosi sollevamenti, dove pazienti studiosi hanno raccolto, ben al disopra del livello del mare attuale, resti di organismi che vivevano in prossimità della superficie del mare. Questi organismi prendono il nome di “indicatori di livello”, e un esempio tipico è dato dalle ostree. In qualche caso sono state raccolte radici di mangrovie, ma il più delle volte i resti sono conchiglie di molluschi, anch'essi ideali per le datazioni perché costituiti da carbonato di calcio, quindi databili facilmente con il metodo del radiocarbonio. Nella Figura 9 si possono constatare i risultati di questa ricerca, che conferma quanto già visto nella figura 6b: un livello marino che intorno a 5 mila anni orsono era alcuni metri sopra la posizione attuale. I vari simboli indicano le diverse aree di provenienza: Australia, Sudafrica, Sri Lanka, Georgia e Florida. Non tutte le età indicate sono età-calendario, nel senso che non sono state corrette per tenere conto del fatto che la quantità di carbonio radioattivo che si forma nell’alta atmosfera (dal rapporto tra carbonio radioattivo e carbonio normale si calcola l’età) non è costante nel tempo.
Se cerchiamo nella letteratura, troviamo anche testimonianze storiche del fatto che nel recente passato il mare si trovava più in alto di oggi. Per esempio Plinio il vecchio, vissuto nel I secolo d.C., nel VI libro della sua “Storia naturale” racconta di una grande impresa, che può essere chiamata a buon diritto “faraonica”, promossa intorno al 1850 a.C. da Sesostris III per collegare via fiume il Mare Mediterraneo con il Mar Rosso. Venne scavato un canale a partire dal ramo più orientale del Nilo, all’altezza della cittadina di Bubastis, che si trova a una quota di 13 m s.l.m.; il canale seguiva l’avvallamento, che in un lontano passato era molto probabilmente percorso da un ramo del Nilo che si gettava nel Mar Rosso, dello Wadi Tumilat e terminava in prossimità dell’attuale Ismailia, situata a una quota di 6 m s.l.m.. La lunghezza complessiva dell’opera era di 62 miglia romane, corrispondenti a 92 km. Plinio aggiunge più esplicitamente che il canale terminava nei cosiddetti “Laghi amari”, che al suo tempo erano isolati dal Mar Rosso, come lo sono tuttora, distandone 16 km. L’apparente incongruenza si dissolve solo ammettendo che nel 1850 a.C. il Mar Rosso, come tutti i mari, fosse 4 m più alto di oggi e arrivasse fino a Ismailia.
Abbandono di due città megalitiche
Il grafico della figura 9 ci permetterà, con una digressione apparentemente fuori tema, di compiere alcune interessanti osservazioni di carattere archeologico, utili a valutare l’età di due città megalitiche sorte in riva al mare, Pyrgi ed Orbetello, ambedue abbandonate a causa di uno stesso innalzamento del mare.




Figure 10-13 – Mura megalitiche di Santa Severa, sulle quali al tempo della conquista romana è stato edificato un castro, nel Medioevo è sorta una torre saracena a difesa del porto locale e successivamente è stato costruito un castello con il suo borgo. Sui blocchi di pietra utilizzati si trovano in abbondanza fori lasciati da litodomi, molluschi che vivono nel mare a qualche decimetro di profondità.
La prima città è ubicata presso Santa Severa, 50 km a nord di Roma. Qui, nei pressi di una roccaforte a mura poligonali è sorto nel VI secolo a. C. un centro portuale etrusco, che, dopo l’occupazione romana dell’inizio del III secolo a.C., ha assunto il nome latino di Pyrgi; il porto era annoverato tra i più importanti del Mediterraneo. Infine, nel medioevo, sopra una porzione della cittadella più antica è stato eretto il castello che ancora oggi si può ammirare nella sua maestosità (Figura 10).
L’età di queste città è avvolta dal mistero; sicuramente supera quella solitamente assegnata, di poco precedente la conquista romana. Nel caso di Cosa, a pochi kilometri da Orbetello, si ritiene addirittura che le mura poligonali siano state erette tra il 273 e il 264 a.C., al tempo in cui i Romani fondarono questa colonia. Eppure è evidente che, dove ci sono le più antiche mura romane, come quelle di Servio Tullio del VI secolo a.C. conservate ad esempio fuori e dentro la stazione Termini di Roma, il taglio delle pietre era già squadrato. Nelle mura poligonali questo taglio era adottato solo in corrispondenza delle porte e dove le mura cambiano direzione. L’impiego di massi con angoli diversi da quello retto è più primitivo: esso consentiva di sfruttare le diverse forme naturali con cui i materiali si presentavano dove venivano cavati e di risparmiare quindi sul lavoro di sagomatura, che veniva compiuto a colpi di scalpello, come è ancora visibile ad esempio ad Alatri e a Cori.
Romani ed Etruschi usavano talvolta assemblare pietre poligonali nella costruzione di muri di modeste dimensioni al fine di utilizzare materiale di scarto, ma anche le singole pietre erano di dimensioni ridotte e potevano essere spostate da una o due persone al massimo. A rigore perciò le mura che stiamo considerando dovrebbero essere denominate “megalitiche poligonali”, ma, dopo questa precisazione necessaria, continueremo ad usare il termine contratto, per semplicità.
A Pyrgi si osservano dei particolari interessanti. Il primo è costituito dalla scelta del luogo. L’area di edificazione si trova per quasi tutta la sua estensione su un breve tratto di costa particolarmente stabile (come si evincerà meglio dalle successive osservazioni), in quanto è costituito da rocce molto meno erodibili rispetto a quanto si incontra nelle porzioni di costa adiacenti. Un secondo particolare emerge seguendo il perimetro, che è a pianta rettangolare con l’asse maggiore disposto perpendicolarmente alla linea di riva: la metà del muro più lontano dal mare presenta un’altezza uniforme intorno a un metro a partire da una quota di circa 1,8 m sul livello attuale del mare, mentre nella metà restante si raggiunge un’altezza di circa 4 m (vedi figura 10). Si ha l’impressione che il muro sia stato iniziato per poi essere abbandonato.
Il terzo particolare è molto più intrigante. Sulla superficie di diverse pietre del muro più basso si notano fori di litòdomi, molluschi volgarmente detti “datteri di mare”, che vivono in un intervallo di profondità di pochi decimetri sotto la superficie marina; essi si scavano una sede nella roccia attaccandola chimicamente. I fori sono visibili sia sulla faccia esterna (Figura 11) sia sulla parte superiore dei resti del muro più basso (Figura 12). Una analoga situazione si presenta sulle pietre del muro più alto, interessando non soltanto le facce esterne dei blocchi (Figura 13) ma anche facce laterali dove, verso mare, il muro ritorna ad essere basso. In questa seconda porzione del muro si può inoltre osservare che, dove la pietra si è sfaldata, la superficie sforacchiata è più arretrata di diversi centimetri rispetto a quella originale.
In considerazione dell’elevato numero di blocchi che portano i segni delle perforazioni dei litodomi e della posizione delle superfici interessate, si può escludere che i fori si trovassero già dove il materiale è stato cavato. Da quanto esposto si può desumere che la costruzione del muro fu interrotta in seguito alla sommersione dell’area da parte del mare.
Si possono fare due ipotesi. La più semplice è di attribuire il fenomeno ad un evento locale, ovvero a un bradisismo, contando sulla vicinanza all’area vulcanica della Tolfa, che tra 4 e 2 milioni di anni addietro ha dato origine alla messa in posto di masse trachitiche e a mineralizzazioni. Oggi di quel vulcanismo, non più attivo, sono rimaste come uniche tracce le venute a giorno di acque calde. Tuttavia non sono stati mai segnalati movimenti verticali della linea di costa, neppure nella stazione mareografica di Civitavecchia, che avrebbe potuto registrare anche minimi movimenti. La mancanza di notizie storiche di fenomeni del genere conferma l’idea che a distanza di tanto tempo dalle manifestazioni di movimenti magmatici locali non ci si debba aspettare più l’intervento di un bradisismo.
La seconda ipotesi si rifà a quanto ricostruito per la variazione del livello marino della figura 8 e considera un innalzamento generale del mare. A suo favore si presentano diversi elementi. Uno di essi è la posizione a cui troviamo le fondazioni del muro, poco sopra la quota di 1,7 m stabilita per lo stazionamento mantenuto dal livello del mare nell’intervallo tra il 5257 e il 3044 a.C. circa, prima che il mare iniziasse la risalita culminata, alla quota di 7 m, intorno al 2800 a.C..
Dal 3044 al 295 a.C. il livello marino risulta essere stato sempre al disopra del piano di fondazione della città megalitica. In tale intervallo di tempo è compreso un lungo periodo, fino al 516 a.C., in cui il mare era al disopra della quota dei 4 m s.l.m., e infatti per quasi tutto questo periodo l’area non è stata utilizzata. Quando in seguito, in epoca etrusca, venne aperto qui un porto e furono erette diverse costruzioni, e tra esse alcuni templi a partire dal 510 a.C. circa, potrebbe non sembrare logico che sia stata scelta per questo nuovo insediamento un’area situata a 200 m di distanza dalle mura megalitiche. Le stesse mura potevano essere utilizzate per la difesa dell’aggregato urbano; ma la ricostruzione del livello del mare della figura 8 ci suggerisce che intorno al 510 a.C. le mura megalitiche erano per lo più sommerse. Un ulteriore motivo per preferire la più antica cittadella sarebbe derivato dalla subsidenza che l’insediamento etrusco ha cominciato a subire a partire già dal 516 a.C.. Infatti le abitazioni situate tra i templi e la linea di costa di allora, verosimilmente costruite in un periodo anteriore al 516, ora si trovano su una superficie che si è inclinata abbassandosi fino a 2,7 m al disotto della superficie attuale del mare.
Le costruzioni di quest’area sono state fondate su sabbie, terreni affidabili perché hanno buona capacità portante e sono esenti da cedimenti di rilievo, ma le sabbie nascondevano un substrato infido, costituito da argille e torbe, tipici depositi di un ambiente lagunare, di spessore crescente procedendo dall’interno verso il cordone litorale che delimitava la laguna, posizionato forse 200 m più al largo. Gli ambienti di questo tipo, frequenti lungo il Mare Tirreno, si formano dove le correnti marine, che ripartiscono il materiale detritico portato al mare dai corsi d’acqua, vengono tenute lontane dai tratti costieri più rientranti a causa della presenza di un promontorio o, come è il caso della laguna di Orbetello, di un’isola poco distante dalla costa, come era l’Argentario nel recente passato.
Un altro elemento a favore della seconda ipotesi è l’osservazione che in diversi blocchi appartenenti alla parte bassa del muro, come si vede nella figura 11, i fori di litodomi si concentrano in una fascia alta una trentina di centimetri appena sopra la quota di fondazione, cioè tra 1,8 e 2,1 m. La situazione si accorda con il fatto che, dal 443 al 295 a.C., cioè poco prima che l’area di Pyrgi si rendesse nuovamente abitabile, il livello marino si è mantenuto alla quota di 2,1 m, che è il limite superiore della fascia in questione.
Il pericolo paventato dagli esperti dell’IPCC di una risalita del mare nei prossimi decenni, capace di rendere inabitabili estese aree del mondo, si è dunque già realizzato più di 5000 anni fa ma con una intensità e una rapidità notevolmente maggiore: in soli sei mesi è possibile che la superficie marina si sia spostata più in alto di 40÷70 cm e nel giro di 73 anni sia salita complessivamente di 4 m. L’insediamento di Pyrgi è rimasto abbandonato per millenni, fino a quando, nel III secolo a.C., il mare si è ritirato abbastanza da renderlo di nuovo praticabile, e a quel punto i Romani hanno potuto edificare una città sulle antiche mura rimaste fino ad allora incompiute.
Diversa è la storia ricostruibile per Orbetello. A differenza di Pyrgi, qui le mura poligonali sono state completate; esse mostrano uno spessore di 2 m e dovevano avere un perimetro di 2,5 km, in massima parte conservato; manca il lato che tagliava la penisola, dove probabilmente era stato scavato un fossato. Il fossato doveva essere situato nella stessa posizione dove troviamo attualmente un canale che rendeva il centro storico di Orbetello un’isola prima della costruzione della via di comunicazione che lo ha collegato al Monte Argentario.
L’altezza del muro presenta un particolare sconcertante: ne vediamo soltanto tre metri affioranti dalle acque della laguna; il resto è sommerso; uno scavo eseguito nel 1988 ha potuto appurare che la loro base si trova circa 4 m sotto il livello del mare (Pincherle, 1990).
Il terreno di fondazione è costituito da sabbie da medie a fine, leggermente cementate; esse continuano per almeno altri 15 m al disotto del muro. Sono le stesse sabbie che vediamo affiorare in superficie lungo il resto del tombolo rimasto incompleto al centro della laguna, e che si sono deposte prima dell’ultima puntata glaciale. Trattandosi di sedimenti non compressibili in misura apprezzabile, non possiamo attribuire la situazione attuale ad un fenomeno di subsidenza; ci troviamo così ancora una volta a dover tenere conto di una variazione del livello marino. Più propriamente, si dovrebbero prendere in considerazione due distinte variazioni di livello: una per spiegare la posizione sott’acqua delle fondazioni, l’altra per giustificare la presenza, anche sulle pietre del muro di Orbetello, di fori prodotti da litodomi.
L’ipotesi di un doppio bradisismo, che avrebbe dovuto manifestarsi dapprima con una emersione dell’area e poi con una sommersione, è difficilmente sostenibile sia per le ragioni addotte nel caso di Pyrgi sia per la grande lontananza del settore vulcanico di Tolfa, a circa 60 km dall’area in esame.
Per riscontrare un livello marino compatibile con la quota della base del muro, occorre andare indietro nel tempo fino a quando la superficie del mare non era a quote superiori a -4 m. Nella risalita postglaciale vi è stato un intervallo di 148 anni, tra il 5499 e il 5351 a. C., in cui il mare era stabilmente proprio a quella quota, (vedi figura 2). Ne inferiamo che il muro deve essere stato eretto prima del 5350 a.C.. Tenendo presente che a Santa Severa la base del muro si trova a una quota pressoché coincidente con quella del livello del mare di allora, è ragionevole supporre che anche nel caso di Orbetello sia stato adottato lo stesso criterio e che di conseguenza la fondazione non sia anteriore al 5499 a.C..
La città ha potuto sopravvivere all’innalzamento del mare avvenuto tra il 5351 e il 5257 a.C., allorché il livello si è portato da -4 m a 1,7 m, poiché all’interno delle mura il piano della città era circa 6 m più alto del piano di fondazione del muro. Quando però le acque hanno cominciato a salire di nuovo nel 3044, anche qui, come a Pyrgi, la fine dell’abitato era segnata, costringendo gli occupanti ad abbandonarlo.
Il risultato raggiunto è senza dubbio sorprendente e sposta la nascita di questa città verso un periodo molto più remoto del V secolo a.C. delle attuali valutazioni, avvicinando sensibilmente la sua storia a quella delle prime città fortificate. Le mura di Gerico, le più antiche, furono erette nel IX millennio a.C., prima che si fabbricassero oggetti di terracotta, utilizzando mattoni crudi composti da paglia e fango e tenuti insieme da un legante di cenere e fango. Ma indubbiamente, per il momento, Orbetello rappresenta la più antica città fortificata con mura di pietra di cui si conosca, con una buona approssimazione, l’età. Per rintracciare città megalitiche sicuramente anteriori dovremo affidarci all’archeologia marina, cercando fortificazioni erette al livello del mare quando tale livello si trovava 9 m più in basso di oggi. La ricerca non è facile, dato che nella stragrande maggioranza dei casi le città megalitiche venivano ubicate in località elevate rispetto a una pianura sottostante; ne sono esempi, nel Lazio, Alatri, Arpino, Artena, Anagni, Ferentino, Norba, Cori, Segni.
Si va così delineando una civiltà delle città megalitiche, sviluppatasi nel Mediterraneo tra un momento che per ora possiamo ipotizzare intorno al 5400 a.C. circa e un momento non ancora precisabile, ma che possiamo porre provvisoriamente intorno al 3000 a.C.. Troppo poco si conosce di questa cultura; il mistero si infittisce ancor più considerando che nel Sudamerica la stessa tecnica di costruzione era adottata dagli Inca, che ne hanno lasciato mirabili esempi a Cuzco e Machu Pichu.
Possiamo forse scorgere qualche leggera diversità tra la tecnica costruttiva messa in atto ad Orbetello e quella relativa a Santa Severa, tuttavia negli oltre 2300 anni che separano i due insediamenti gli aspetti comuni sono preponderanti.
Ci si è chiesto come si riuscisse a fare combaciare perfettamente le facce dei vari blocchi. Ritengo che il risultato venisse ottenuto definendo con precisione la geometria degli spazi che sarebbero stati occupati dai singoli elementi. Spesso era sufficiente preparare due superfici piane, di cui una prossima all’orizzontale, e determinare con precisione l’apertura dell’angolo formato dalle due superfici. Veniva quindi scelta una pietra, che veniva preparata spianando due facce secondo quell’apertura; dopo la posa in opera, altre facce erano ottenute tenendo conto della nuova situazione e creando le condizioni per ospitare un elemento successivo.
A volte lo spazio da occupare era quello a forma obbligata di un cuneo, e anche in tal caso occorreva la conoscenza dell’angolo compreso tra i due lati. Se i due lati, sempre fortemente inclinati, erano separati da un tratto spianato in modo da formare un trapezio rovesciato, con la base minore in basso per maggiore chiarezza, occorreva misurare sia la lunghezza della base sia i due angoli formati da questa con i due lati adiacenti. La pietra che doveva venire collocata in questo spazio avrebbe combaciato perfettamente se fosse stata preventivamente sagomata in cava rispettando le misure precise dei tre elementi geometrici. Questa è la situazione ideale per poter verificare l’ipotesi fatta fin qui.
Diverse misure di lunghezza sono state determinate a Cosa ed Alatri e sono risultate tutte multiple di un valore compreso tra 1,540 e 1,534 cm; a Cori le misure erano multiple di 1,536÷1,537 cm; a Segni un’unica misura, di 93,7 cm, è multipla di 1,536 cm. L’unità di misura adottata per le mura poligonali del Lazio è perciò nettamente distinta rispetto al dactylos greco di 1,93 cm, al digitus romano di 1,85 cm, al dito egiziano di 1,75 cm, al dito sumero di 1,73 cm e al dito etrusco di 1,675 cm (come risulta da misure da me effettuate sulle pietre squadrate della necropoli di Cerveteri).
Per quanto riguarda le misure angolari, a Orbetello, Amelia, Cosa, Ferentino, Alatri, Norba e Cori si è osservato che i valori degli angoli tra due facce contigue sono perlopiù multipli di 3 ° ma talvolta di 1,5 °; il rapporto tra i due gruppi di valori, che a Norba è di 9 : 1, indica una forte predilezione per i multipli di 3 °. È da notare che, mentre il sistema oggi adottato suddivide l’angolo retto in 90 °, e poi ogni grado e ogni minuto è diviso in 60 parti, nelle città megalitiche del Lazio era stato adottato un sistema che, suddividendo l’angolo retto in 60 parti, rappresenterebbe un sistema sessagesimale perfetto.
Sarà interessante sapere se in tutte le città analoghe del Mediterraneo veniva usata la stessa tecnica costruttiva con le stesse unità di misura, in particolare nell’Argolide, quella parte nordorientale del Peloponneso dove sorgevano numerose, come nel Lazio, città con mura poligonali: Micene, Argo, Tirinto, Nauplia, Midea.
A Micene troviamo un altro tassello per il puzzle che stiamo cercando di completare. In alcuni punti le mura sono effettivamente poligonali, ma in altri, come l’accesso alla famosa porta dei leoni, vediamo che il muro è costruito in una maniera diversa, con le pietre tagliate in modo squadrato; lo vediamo anche nel corridoio che conduce al cosiddetto “tesoro di Atreo”, edificato intorno al 1250 a.C., e ancor meglio all’interno della cupola di questa tomba, dove le pietre sono perfettamente squadrate e di altezza tendenzialmente uniforme per ogni giro.
Perciò a Micene nel II millennio a.C. gli Achei hanno riutilizzato una roccaforte preesistente, rifacendo alcuni tratti delle difese con una tecnica diversa da quella usata in precedenza. Anche la civiltà minoica, sviluppatasi soprattutto a Creta prima di quella micenea, usava per i suoi primi palazzi, fin dal 1900 a. C., pietre squadrate. Lo stesso si può dire per le grandi piramidi di Giza del XXV secolo a.C. e per quelle più modeste di Saqqara, che risalgono a due secoli prima. Quindi la modalità costruttiva delle mura poligonali è ben distinta rispetto a quella delle grandi strutture dell’Antico Egitto ed è pienamente verosimile che sia nettamente precedente.
Considerando le grandi somiglianze che si possono cogliere tra le città con mura poligonali dell’Italia centro-meridionale e la parte più antica della roccaforte di Micene, sorge l’idea che le prime siano di almeno un migliaio di anni più antiche di quanto comunemente si stima. I Greci ritenevano che le città circondate da mura “ciclopiche” fossero state fondate dai Pelasgi, una popolazione indigena che, secondo la tradizione omerica, aveva preceduto gli immigrati di lingua greca: Ioni, Elleni, Achei e Dori provenienti dal settentrione.
I Pelasgi erano così chiamati perché vivevano strettamente a contatto con il mare. Con il nome di “popoli del mare” sono ricordati in un obelisco presente a Biblo, in Libano, datato tra il 2000 e il 1700 a.C. e, tra il XIV e il XII secolo a.C. in lettere o iscrizioni egizie e ittite. Omero li chiama ancora Pelasgi e nell’Iliade ne cita i nomi dei re e l’abilità nei combattimenti navali; ci fa sapere inoltre che essi parteciparono alla guerra di Troia contro gli Achei. Ritengo che ancora molto ci sia da scoprire su questo popolo, che un tempo dominava tutto il Mare Egeo. Resti delle loro mura “ciclopiche” si trovano nella maggior parte delle isole del mare greco.
L’idea che siano stati i Pelasgi a erigere le mura poligonali così frequenti sul versante tirrenico dell’Italia centrale riceve conferme non solo dalle somiglianze con le tecniche costruttive in uso nel Mare Egeo, ma anche dal fatto che gli Etruschi scelsero di insediarsi proprio in quest’area. Secondo Erodoto gli Etruschi provenivano dalla Lidia, nella parte occidentale dell’odierna Turchia, e si chiamarono Tirreni dal nome del loro re Tirreno che li guidò nella migrazione. Analisi del DNA eseguite su scheletri di ossa umane e bovine hanno recentemente confermato questa provenienza.
Il viaggio compiuto dai Tirreni, salpati da Smirne, non era significativamente diverso da quello di Enea di qualche secolo prima. L’attrazione in ambedue i casi verso l’Italia centrale suggerisce che probabilmente le popolazioni che abitavano quest’ultima regione avevano mantenuto nel tempo legami culturali e commerciali con la terra da cui provenivano, cioè l’Asia minore. Considerando che, dopo l’arrivo dei popoli di lingua greca, i Pelasgi si erano ritirati nel settore nord-orientale dell’Egeo, risulta credibile quanto ci ha lasciato scritto Dionigi di Alicarnasso, vissuto nel I secolo a. C., secondo il quale “i Tirreni prima si chiamavano Pelasgi e presero il loro attuale nome dopo che si furono stabiliti in Italia.”
Era solo il Mare Mediterraneo ad essere dominato dai Pelasgi? La domanda merita una profonda riflessione poiché, se finora era arduo spiegare come può essere accaduto che a Micene, o Alatri, sia stata applicata una tecnica costruttiva che ritroviamo anche in Perù, ora ci sono nuovi elementi utili per riaprire la questione.
La scoperta che la città megalitica di Orbetello ha più di 7360 anni sposta indietro nel tempo la possibilità di contatti con le Americhe. Perciò potrebbe non essere un caso che intorno al 5000 a.C. si trovino le prime tracce di agricoltura in Messico. E possiamo trovare nuovi riscontri alla veridicità della leggenda di Atlantide, su cui purtroppo vengono avvalorate informazioni di seconda mano che non rispecchiano il racconto originale e lo discreditano; Wikipedia, per esempio, riferisce di un dominio esercitato da Atlantide su molte parti dell’Europa occidentale e dell’Africa 9600 anni fa. Il testo originale del Timeo dice in realtà altro.
Il sacerdote egizio di Sais (luogo sacro fin dalla I dinastia) che ha fornito le informazioni a Solone, come sappiamo da due dialoghi di Platone, ma soprattutto dal Timeo, ha detto che Atene si è data una buona legislazione 1000 anni prima di Sais ed era nota come insediamento urbano già ottomila anni prima della visita di Solone (avvenuta intorno al 600 a.C.) e quindi oltre 10000 anni fa.
Considerando che la I dinastia egizia fa parte del periodo arcaico dell’antico Egitto e inizia verso il 3150 a.C., secondo questo racconto Atene era quindi una città ben organizzata fin dal 4000 a. C. circa, dal tempo cioè in cui sorgevano le prime città-stato della Mesopotamia. In effetti, come scriveva Tucidide nel V secolo a.C., le prime mura dell’Acropoli di Atene, di cui rimaneva al suo tempo un tratto molto modesto, erano state fondate dai Pelasgi, e abbiamo visto che città come quella di Orbetello potevano risalire ancora più indietro del 4000 a.C..
Nel seguito del racconto del sacerdote, Solone è venuto a sapere che oltre le Colonne d’Ercole esiste un continente più grande dell’insieme di “Libia e Asia” e si incontrano isole minori non lontane dalla terraferma. Sembra una descrizione delle Americhe e delle Antille. Su una di queste isole sorgeva la città di Atlantide, capitale di un regno potente che dominava anche al di qua delle colonne d’Ercole: da una parte fino all’Egitto e dall’altra fino alla terra dei Tirreni. L’egemonia di questo regno durò finché i Greci non si ribellarono costringendo quelle forze di occupazione a ritirarsi dal Mediterraneo. Poi, improvvisamente, in un tempo tanto breve che il sacerdote lo ridusse a un giorno e una notte, avvenne un cataclisma, in seguito al quale i guerrieri greci furono inghiottiti in massa dal terreno e Atlantide fu sommersa dal mare.
In questa descrizione estremamente sintetica di una catastrofe in cui vennero a coesistere due fenomeni molto diversi tra loro, possiamo riconoscere la sopravvenienza di una serie di terremoti disastrosi insieme a una variazione rapida del livello marino. Il fatto, veramente inusuale, che due avvenimenti così differenti siano stati accomunati in un tempo assai ristretto induce a pensare che sia stata colta fin dall’inizio una loro contemporaneità. Solo chi si spostava di continuo dal Mediterraneo alle Americhe poteva cogliere questo dettaglio.
Tentando di mettere insieme questi scarni elementi, è possibile che ci troviamo di fronte a una catastrofe collocabile nel tempo nel 3044 a.C.. In quell’anno, in cui volgeva alla fine un ciclo naturale di 2528 anni, i Balcani, e la Grecia in particolare, potrebbero essere stati interessati da una frequenza inusuale dell’attività sismica, e il luogo dove si trovava il porto di Atlantide potrebbe essere stato sommerso dal mare nello stesso modo capitato alle roccaforti di Pyrgi e Orbetello. Il dominio di Atlantide sulle popolazioni del Mediterraneo era cessato, e i Pelasgi erano liberi di commerciare tra questo mare e le Americhe. Faccio presente che, quando il sacerdote di Sais parlava a Solone di “vostri guerrieri”, probabilmente non era in grado di distinguere fra Greci, o Elleni, e Pelasgi, cosicché poco sopra ho volutamente confuso per due volte i due termini.
È possibile che la fine di Atlantide si sia protratta per alcuni anni, durante i quali le città mediterranee avrebbero approfittato del conseguente declino della sua forza navale per infrangerne la supremazia. L’intervallo di tempo trascorso tra la sconfitta della flotta che aveva dominato i mari e l’abbandono della città ormai sommersa potrebbe essere stato ampliato dai vincitori per rendere più prestigiosa la vittoria conseguita.
Con il tramonto di Atlantide il traffico commerciale attraverso l’Atlantico non venne necessariamente a cessare e potrebbe essere durato molto a lungo. Lo testimonierebbe una notizia che ha sollevato fin dall’inizio una grande incredulità: esaminando nove mummie egiziane datate nell’intervallo tra il 1070 a.C. e il 395 d.C., è stata riscontrata la presenza di cocaina e hashish nei loro capelli e in altri resti organici, mentre su otto di esse sono state trovate tracce di nicotina (Balabanova et al., 1992). La scoperta di cocaina e nicotina è stata bollata come “evidentemente impossibile”, essendo risaputo che prima del 1492 non potevano esserci tracce di tabacco e coca al di qua dell’Oceano Atlantico. Ma, alla luce dei nuovi dati che riguardano Orbetello, l’argomento meriterebbe di venire approfondito; esso può indicare che un commercio tra le Americhe e il Mare Mediterraneo poteva essersi protratto fino agli ultimi secoli del dominio di Roma utilizzando basi marittime poste non solo in alcune località al di là dell’Oceano Atlantico, ma anche poco oltre i confini occidentali dell’Impero Romano, come, ad esempio, nell’arcipelago delle Canarie.
Cicli cosmici
Quando si parla di cicli naturali dobbiamo distinguere fra cicli che hanno un valore locale, relativo alle condizioni astronomiche in cui si trova la Terra, come il ciclo diurno e il ciclo annuale, e cicli che possiamo riconoscere anche al di fuori del sistema-Terra e del sistema solare e che meritano perciò il titolo di cicli cosmici. Appartiene a questo secondo gruppo il ciclo di 2528 anni che, come già detto, con ampia probabilità era noto presso le popolazioni del Centroamerica attraverso l’osservazione ripetuta di un fenomeno particolare o una serie di fenomeni. La conoscenza che se ne aveva doveva essere maturata in tempi molto lunghi, di diversi millenni; purtroppo essa si è persa con il rapido disintegrarsi di gran parte della cultura a cui era legata. Da parte nostra ripartire da zero per riscoprire nuovamente questo ciclo in un tempo di gran lunga più breve comporta ovviamente la necessità di adottare un modo diverso di procedere. Per non dare l’impressione che la determinazione della lunghezza del ciclo di 2528 anni sia sprovvista di sufficienti basi di conferma intendo chiarire i passi compiuti.
Il percorso richiesto per arrivare alla esatta determinazione della durata del ciclo in questione è leggermente complesso. Invito perciò chiunque voglia seguire fino in fondo il suo sviluppo ad armarsi di una giusta dose di pazienza; altrimenti si può saltare il presente capitolo. Per cominciare, riandiamo indietro sull’argomento dell’ultimo interglaciale. In realtà abbiamo visto che il suo culmine ha un’età di circa 5000 anni, mentre invece la maggior parte degli autori intende come ultimo culmine interglaciale un analogo episodio risalente a 128 mila anni fa poiché viene per lo più negato che il mare abbia concluso da tempo la sua risalita dopo il massimo glaciale di 25 mila anni fa.
Le due età di 5000 e 128 mila anni sono state stabilite con sufficiente precisione, e la loro differenza, di 123 mila anni, non ha un valore casuale: è tre volte la durata di uno dei tre cicli utilizzati da Milankovic per la sua elaborazione della teoria astronomica: il ciclo della variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre, che ha appunto un quasi-periodo di 41 mila anni.
In effetti tra i due culmini interglaciali sono interposte tre espansioni glaciali principali, appartenenti alla glaciazione würmiana e chiamate in letteratura Würm I, II e III; tali espansioni quindi sembrano avere la stessa durata del ciclo astronomico in questione.
Potrei dimostrare anche qui che le singole puntate glaciali sono articolate, nel complesso delle due fasi successive di espansione e di ritiro, tramite episodi minori, in numero di 16 o 17; le durate di tali episodi, da considerare costanti, dovrebbero pertanto essere comprese tra il valore di 2562 e quello di 2442 anni. Ritroviamo così un periodo, di circa 2500 anni, che nella letteratura geologica si è presentato in diversi casi: nello studio dell’espansione e del ritiro dei ghiacciai montani degli ultimi 6000 anni, nelle analisi isotopiche dell’ossigeno delle carote di ghiaccio della Groenlandia, nello studio pollinico dei recenti periodi climatici postglaciali dell’Europa settentrionale, nelle variazioni ritmiche della composizione faunistica dei foraminiferi bentonici dei mari profondi o dei foraminiferi planctonici usati come indicatori paleoclimatici.
Dagli studi isotopici dell’ossigeno eseguiti sui foraminiferi delle carote prelevate dai fondi oceanici si è osservato che a manifestarsi non è il ciclo di 41 mila anni ma il suo multiplo di 123 mila, che possiamo quindi considerare un superciclo, le cui caratteristiche, e in particolare il suo periodo, risultano costanti.
DPertanto ho assunto fin dall’inizio che il superciclo sia costituito da tre cicli di 40, 40 e 42,5 mila anni circa, i quali a loro volta sono formati rispettivamente da 16, 16 e 17 cicli minori, della durata mediamente di 41000 / 16,33 = 2510 anni ciascuno.
In seguito, nell’edizione 2010 de I ritmi segreti dell’Universo, questa durata è stata portata a 2524 anni, e in queste pagine vedremo che essa sarà aumentata a 2528 anni; le due modifiche derivano da una ricerca condotta su altri cicli, caratterizzati da periodi via via minori.
Del ciclo di 2528 anni ancora non sappiamo di preciso neppure quali siano i termini della sua durata. Per il momento, possiamo limitarci a supporre che il ciclo attuale sia iniziato poco prima del 500 a.C., anno della scomparsa di Tartesso, e del 510 a.C, anno in cui è stata abbandonata la città di Sibari, e che quindi siamo molto prossimi alla sua conclusione.
Per arrivare allo scopo sfrutteremo il fatto (giustificato più avanti) che, nel momento in cui un ciclo termina, terminano anche tutti i cicli di ordine minore. Nel nostro caso, utilizzeremo cicli le cui durate sono di circa 160, 10 e 0,5 anni. Il vantaggio di operare con essi consiste nel più facile controllo che possiamo avere dei dati.
Rispetto al ciclo di 2528 anni, quello immediatamente minore, di circa 160 anni, si rivela con un semiperiodo (non uniforme come durata) di circa 80 anni, riconosciuto in passato nelle variazioni del diametro solare. Esso influenza anche la temperatura media globale e la posizione del livello dei mari. Accomunare momenti di elevati livelli del mare con momenti di elevate temperature può essere giustificato dall’ipotesi che i due fenomeni dipendano da una variazione nello stesso senso del coefficiente di gravitazione. Un aumento di G infatti dovrebbe produrre sia una contrazione del globo terrestre, con conseguente innalzamento del livello degli oceani, sia una diminuzione della distanza Terra-Sole, con una maggiorazione della radiazione solare ricevuta al limite della nostra atmosfera.
La più evidente manifestazione del semiciclo di circa 80 anni compare nelle registrazioni mareografiche di Amsterdam, disponibili dal 1700, nelle quali si notano livelli marini più alti, rispetto alla media, di 4÷5 cm negli anni 1770 e 1844 (da notare la differenza di 74 anni). Dopo il 1844, sfortunatamente non viene più in aiuto questa stazione in quanto dal 1932 Amsterdam è rimasta isolata dal mare dopo la costruzione di una grande diga, ed è un vero peccato poiché le altre stazioni non forniscono dati altrettanto evidenti. Per indagare su ciò che è avvenuto prima del 1770 e dopo il 1844 cercheremo pertanto di avere informazioni per l’altra via: quella delle variazioni di temperatura.
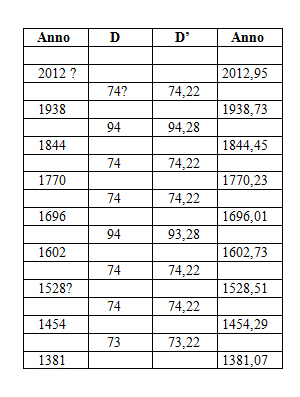
Tabella 1 – Anni (e loro differenze) in cui si sono manifestati livelli marini particolarmente elevati oppure condizioni climatiche improvvisamente più calde. I dati più precisi delle ultime due colonne derivano dalle elaborazioni che verranno presentate nella tabella 3.
Nell’intera Europa si hanno notizie di temperature medie particolarmente elevate negli anni 1381, 1454, 1602 e 1696. Questi ultimi quattro anni risaltano per essere stati preceduti da un anno eccezionalmente freddo; gli intervalli tra i loro valori sono di 73, 148 e 94 anni, e possiamo meglio cominciare a ragionarci sopra disponendo il tutto nella Tabella 1.
Purtroppo non abbiamo un riscontro obiettivo che gli anni di più alto livello del mare siano stati anche anni di temperature medie particolarmente elevate, per la ragione che prima del 1700 non disponiamo di registrazioni mareografiche, mentre a partire dal 1770 intervengono eccessivi turbamenti climatici, derivati dall’influenza dell’età industriale. Se osserviamo infatti le variazioni di temperatura dell’emisfero settentrionale nel periodo dal 1400 al 1995, come sono state ricavate indirettamente dallo studio della densità degli anelli di crescita degli alberi, riconosciamo minimi molto netti negli anni 1453, 1601 e 1695, ma in seguito non ne troviamo altri. Lo stesso studio comunque ci indica che tra il 1925 e il 1955 esiste un intervallo di tempo in cui la temperatura rimane singolarmente al disopra della media. Vedremo tra poco che all’incirca a metà di questo intervallo potremo trovare il momento di inizio di un altro semiciclo di 80 anni.
Nelle prime due colonne della tabella 1 gli anni 2012 e 1528 compaiono seguiti da un punto interrogativo: il primo perché per il momento è solo una ipotesi e il secondo perché non ne abbiamo una sicura documentazione. Il suo valore è stato scelto semplicemente dividendo a metà l’intervallo tra il 1454 e il 1602, operazione apparsa opportuna per la ragione che finora non sono mai comparse differenze D inferiori a 74 o 73 anni. Per sapere infine da dove deriva la scelta dell’anno 1938 dovremo attendere il prossimo passaggio; per il momento ci dobbiamo accontentare di osservare che esso ricade nell’intervallo 1925÷1955 di maggiori temperature sopra menzionato.

Tabella 2 – Anni di più elevato livello del mare; in grassetto quando il livello è particolarmente elevato. d: differenza di tempo, in anni. N: cicli interi o semicicli. I triangoli indicano momenti di maggiore e minore attività solare.
Per uscire da questa impasse occorre procedere per gradi cercando di ripercorrere il cammino seguito per primo: quello dei dati mareografici. Per la difficoltà di riconoscere momenti di mare particolarmente alto distanziati di 80 anni, dovremo cercare di individuare episodi minori che si siano succeduti secondo ritmi di 10,5 anni. Operando in tal senso è stata costruita la Tabella 2, dove figurano tra l’altro, nell’ultima colonna, picchi positivi e negativi dell’attività solare, indicati da triangoli con un vertice rivolto verso l’alto o verso il basso rispettivamente. I cicli trovati hanno una durata d variabile tra 8 e 12 anni, ma compaiono anche semicicli (N = ½) della durata di 4÷6 anni. Ė a causa della presenza dei semicicli che il ciclo delle macchie solari appare di lunghezza media leggermente maggiore di 10,5 anni.
Come già osservato nella tabella 1, i semicicli di circa 80 anni in realtà risultano avere valori di 74 (o 73) e 94 anni; nella nuova tabella gli anni di separazione di quest’ordine sono evidenziati in neretto. L’anno 1938, lasciato in sospeso nella discussione della tabella 1, risulta in neretto in quanto non solo si trova a metà dell’intervallo di tempo 1925÷1955 di temperature maggiori ma corrisponde anche, in diverse registrazioni mareografiche, a un livello marino leggermente più alto.
Per quanto riguarda il 2012, che compare ancora con un punto interrogativo, la sua scelta è dipesa essenzialmente dalla previsione che proprio in quell’anno si preannuncia un’attività solare eccezionalmente pronunciata.
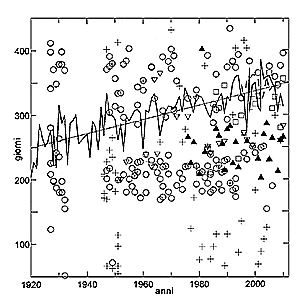
Figura 14 – Massimi annuali del livello del mare registrati a Stoccolma (linea continua), in Italia (linea a tratti), a Wake, USA (triangoli vuoti), Chichijima, Giappone (triangoli pieni), Hilo, Hawaii (cerchi), Kwajalein, isole Marshall (croci) e Cocos, isola australiana al largo di Giava (quadrati). Nelle ordinate la numerazione dei giorni continua oltre il 31 dicembre per comodità di rappresentazione.
Il passo successivo che compieremo sarà di prendere in esame un ciclo di durata ancora minore. Livelli del mare più elevati sono stati messi in evidenza su scala globale da telerilevazioni da satellite; essi ricorrono ogni sei mesi, ma più intensamente ogni 12 mesi, e i loro picchi cadono in prossimità della fine dell’anno solare, tanto da fare pensare in un primo momento di essere in qualche modo in relazione con le condizioni di afelio e perielio; ma si tratta solo di un’impressione errata. Lo possiamo arguire osservando la Figura 14, in cui sono riportati i momenti dell’anno, nei vari anni, in cui in diverse stazioni mareografiche si sono raggiunti livelli marini particolarmente elevati. La linea spezzata congiunge dati relativi alla stazione di Stoccolma, mentre la retta che media i dati mostra come i giorni in cui si realizza il massimo livello si spostano in 92 anni di 100 giorni, dai primi di settembre a metà dicembre, con un incremento medio di 1,087 giorni all’anno, ovvero del 3 per mille. Il ciclo in esame, che si manifesta in realtà con alti livelli del mare ogni sei mesi, presenta un’alternanza di un picco maggiore, che è stato utilizzato nella figura, e uno minore. Il quasi-periodo che ne deriva, di 1,003 anni, corrisponde dunque a quello di un doppio ciclo. La situazione in Italia, determinata nell’intervallo 1995÷2007, indicata dalla linea a tratti, ricalca quella svedese.
Una domanda che viene da porsi è la seguente: le oscillazioni della linea spezzata rappresentano variazioni reali di G? Una prima risposta viene dall’osservazione che in Italia non sempre il massimo livello registrato nelle varie stazioni si verifica nello stesso giorno. Ciò si può interpretare come una reazione differenziata a una sollecitazione comune, dipendente dalle diverse condizioni geologiche dei siti. Analogamente, la risposta vale considerando le diversità, ancora maggiori, tra i giorni in cui lo stesso fenomeno si manifesta in Svezia e in Italia.
A complicare il quadro c’è il diverso comportamento delle stazioni ubicate in contesti geologici completamente diversi. Se ci spostiamo in pieno Oceano Pacifico, otteniamo risultati coerenti tra di loro ma diversi dai precedenti. A questo scopo sono state selezionate alcune stazioni mareografiche caratterizzate da dati il più possibile regolari. Con la sola eccezione dell’isola di Cocos, ubicata nell’Oceano Indiano, le rimanenti stazioni sono distribuite nell’Oceano Pacifico tra il Giappone, le Hawaii e le isole Marshall. Si può notare che i simboli di Wake (triangoli vuoti) sono addensati in una fascia piuttosto ristretta, spostata circa due mesi più in basso rispetto ai punti di Stoccolma: mediamente, in questi ultimi anni, il momento di massimo livello cadrebbe nei primi giorni di ottobre. Anche i dati relativi a Chichijima (triangoli pieni) sono per la maggior parte distribuiti allo stesso modo, ma in una fascia leggermente più larga. Ancora più interessante è la distribuzione dei cerchi, che rappresentano la stazione di Hilo. In questo caso c’è sicuramente da rilevare che essi occupano una zona ancora più bassa; si rileva anche che i dati sono più numerosi poiché spesso si è utilizzato, oltre al massimo valore di quota raggiunto dal livello del mare nel singolo anno, anche il secondo valore e talvolta pure il terzo e il quarto. Lo stesso criterio è stato applicato ai dati di Kwajalein (croci), ma con un risultato meno eloquente.
Appare con evidenza la rarefazione dei punti al disotto della distribuzione dei cerchi di Hilo, e ciò fa pensare che questa stazione si trovi nella posizione più pronta a rispondere alle sollecitazioni indotte dai cambiamenti semestrali (o, meglio, annuali) della gravitazione.
Di conseguenza c’è da aspettarsi che le manifestazioni legate al nuovo ciclo di 2528 anni prenderanno l’avvio con grande probabilità nel mese di luglio del 2012 e proseguiranno con effetti differiti nello spazio e nel tempo fino all’inizio del 2013.
È difficile interpretare la diversità dei due gruppi di dati, che per comodità potremo chiamare “continentali” e “oceanici”. Trattandosi di variazioni locali del livello marino e mancando una contemporaneità del fenomeno, gli effetti sono attribuibili ad abbassamenti differenziati della litosfera. Quando a metà dicembre le aree continentali come la Svezia e l’Italia si abbassano, per ultime, i satelliti rilevano un picco del livello marino, e questo suggerisce che si è completato un “turno”. Il turno successivo, a cui aderiscono probabilmente solo alcune aree oceaniche del pianeta, non si completa, e per questa ragione forse osserviamo nella figura 14 la fascia vuota al disotto della distribuzione più fitta dei cerchi.
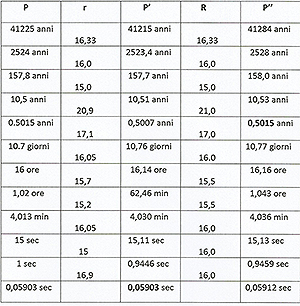
Tabella 3 – Periodi e quasi-periodi (P) di cicli naturali con cui si manifestano variazioni del coefficiente di gravitazione universale. Gli effetti rilevati sono soprattutto variazioni del livello marino. Il valore minimo di P si riferisce a una pulsar estremamente regolare. Nella seconda colonna sono i rapporti r tra le durate medie dei cicli. Per le altre colonne si veda il testo.
La durata del ciclo esaminato, di 0,5015 anni, è quella finora determinata con la maggiore precisione, la quale può essere stimata di 0,001 anni, dato che in un calcolo precedente figurava essere 0,5016 e non dovrebbe risultare inferiore a 0,5014 anni. Questa condizione ci può aiutare a definire meglio le durate degli altri cicli naturali. Utilizzeremo a tale scopo la Tabella 3, in cui, nella prima colonna, sono riportati i valori dell’insieme delle durate P, così come erano conosciute nel 2010, con esclusione dei valori maggiori di 41 mila anni, che sono di circa 0,67, 11, 179 e 2900 milioni di anni. Il dato meno preciso è quello di 1 secondo, che infatti compare con una sola cifra significativa. Occorre inoltre precisare che il quasi-periodo di 4,013, pur essendo espresso con quattro cifre significative, ha almeno una cifra di troppo a causa della insufficiente accuratezza impiegata nella sua determinazione.
Nella seconda colonna figurano i rapporti r esistenti tra le varie durate. Possiamo notare che essi sono racchiusi entro un ristretto intervallo di valori, fra 15 e 20,9 e che, se non sono numeri interi, sono però abbastanza prossimi ad essi; in alcuni casi la media non è un numero intero ma tende a essere sempre un numero razionale semplice, come 16 ⅓ o 15,5.
Ciò si spiega col fatto che la fine di un ciclo coincide con la fine del ciclo immediatamente più breve; ogni ciclo perciò deve contenere un numero intero di volte quelli minori, anche se tale numero, tra due ordini contigui, in genere non è fisso.
Portando come esempio il caso già visto del rapporto esistente tra i cicli che nominalmente sono di 41 mila e “2500 anni” circa, il primo di essi può presentarsi con una durata di 42500 o 40000 anni circa, a seconda che sia composto da 17 o 16 cicli di 2500 anni. Perciò molti dei valori della seconda colonna sono delle medie riguardanti un insieme esiguo di numeri interi.
Come già detto, il nome di cicli cosmici usato nel presente capitolo deriva dal fatto che alcuni di questi cicli sono stati riconosciuti, oltre che nel Sole, anche in altre stelle e in un quasar. Il caso più interessante riguarda però una pulsar, la PSR 1913+16. Le pulsar sono considerate stelle di neutroni in rapida rotazione; sono state chiamate così poiché emettono impulsi radio regolari, con periodi compresi in una gamma tra un massimo di 4 secondi e un minimo di 1,6 millisecondi, tendendo a rallentare con grande lentezza. La pulsar PSR 1913+16 si distingue dalle compagne per la sua estrema regolarità, dovuta al fatto che, con un periodo di 59 millisecondi, rallenta appena di 0,253 nanosecondi all’anno; il suo comportamento ne fa l’orologio più preciso che si conosca, più preciso perfino di quelli atomici. Si ignora il motivo per cui la pulsar è così regolare, ma, se osserviamo come il suo periodo si inserisce tra i dati della tabella 1, non possiamo fare a meno di notare che tale periodo è un diciassettesimo di 1 secondo e che, se lo moltiplichiamo tre volte per 16 otteniamo 4,028 sec, valore molto prossimo ai 4,013 sec che figurano nel quartultimo posto della tabella. Possiamo pertanto azzardare l’ipotesi che nella sua evoluzione la pulsar in esame abbia raggiunto una condizione in cui si trova ad avere un proprio periodo molto vicino a un periodo tipico dei cambiamenti del coefficiente di gravitazione G e, entrando in risonanza con esso, gli rimane per così dire agganciato.
Se moltiplichiamo il periodo della pulsar, che è di 0,05903 sec, per 16, 16, 16, 15,5, 15,5, 16 e 17 (rapporti R della terza colonna della tabella), otteniamo i dati parziali che appaiono nella quarta colonna ed anche il valore di 0,5007 anni, che è prossimo al dato sperimentale di 0,5015 anni della prima colonna, ma non abbastanza da renderlo accettabile. Per quanto sopra detto sull’entità dell’errore di cui può essere affetto il periodo di sei mesi, questo dato sembra essere più prossimo al valore del suo ciclo naturale di quanto lo sia il periodo della pulsar. Una spiegazione possibile è che nella evoluzione della pulsar non sia stata ancora raggiunta la coincidenza tra il suo periodo e il periodo della variazione di G; tale coincidenza dovrebbe verificarsi allorché la pulsar avrà aumentato il periodo di pulsazione fino al valore di 0,05912 sec. Allora l’aggancio con il periodo gravitazionale dovrebbe essere perfetto e la precisione del periodo della stella dovrebbe essere ancora maggiore.
Perciò nella quinta colonna della tabella sono partito dal valore di 0,5015 anni per ricalcolare tutti gli altri periodi o quasi-periodi, ottenendo in particolare il dato che più interessa, cioè la durata più possibile esatta del ciclo di 2528 anni, che ora è precisata con un errore non superiore ad un anno.
Lo stesso valore di 0,5015 anni ci consente di ricalcolare i momenti di alto livello del mare o di temperature particolarmente elevate che caratterizzano i termini dei semicicli di circa 80 anni elencati nella tabella 1. I valori di 74 e 94 anni possono ora essere precisati in 74,22 e 94,28 anni: essi sono multipli della durata di 1,003 anni propria del ciclo doppio, che ipoteticamente dovrebbe governare le date della tabella poiché è quello che si manifesta con maggiore effetto. Devo riconoscere però che si tratta di un’ipotesi molto debole. Inoltre, si assume che le trasformazioni a venire nel 2012 avranno un culmine, come suggeriscono i dati della figura 14 relativi all’Italia e alla Svezia, intorno a metà di dicembre.
Se, prima di questa operazione di puntualizzazione, la somma delle durate della seconda colonna della tabella 1 forniva il risultato di 631 anni, ora la somma analoga operata sui dati della terza colonna dà come risultato 632 anni circa, che poi è la differenza tra 2012,95 e 1381,07.
Poiché tutto lascia pensare che l’intervallo di 632 anni si ripeta altre tre volte a costituire un ciclo di 2528, ne derivano due conseguenze importanti. La prima è che il ciclo di 2528 anni assume una durata costante, una eccezione condivisa forse soltanto con il ciclo più breve finora visto, di 0,059 sec. La seconda è che l’intervallo di 632 anni diventa un superciclo eccezionalmente lungo. In realtà il vero superciclo misura 1264 anni, ma questa precisazione serve solo a confermare la costanza del periodo di 2528 anni.
Previsioni
I risultati raggiunti sono la conseguenza di alcune premesse imposte nella quarta colonna della tabella 2, dove in particolare si è assunto come valore di riferimento per i calcoli quel 2012,95. Questo però non significa che il ciclo in atto terminerà esattamente a metà dicembre: esso si concluderà, con le modalità analizzate, in Europa intorno a quel momento, ma occorre ricordare che in altre regioni del pianeta la sua manifestazione avverrà prima. La figura 14 suggerisce che i sintomi del cambiamento inizieranno a mostrarsi nel mese di luglio, per poi protrarsi fino a gennaio del 2013.
È probabile che una durata di sei mesi affinché si evidenzi in modo pieno il nuovo ciclo non corrisponda in modo casuale al periodo di un ciclo di 0,5 anni. Lo si può considerare una fase preparatoria, che potrebbe svolgersi in maniera analoga al modo in cui è stata ricostruita la variazione del livello del mare nella figura 6b: lì l’inizio di un ciclo di 2528 anni, come si ha nel 516 a.C., non vede subito l’instaurarsi di un livello del mare di durata millenaria alla quota di -0,4 m ma si interpone uno stazionamento a 2 m di quota della durata di 148 anni. Anche questo inoltre compare con un certo ritardo, preceduto da un intervallo di un semiciclo di 73 anni. Durante tale intervallo, analogamente, si può presumere che in ogni singolo ciclo di 10,5 anni vi sia una fase preparatoria di sei mesi prima che il mare abbia uno stazionamento di 10 anni netti. Sembra un gioco di scatole cinesi, che potrebbe continuare ulteriormente: in quei sei mesi infatti, ammesso che non intervengano questioni di diverse sensibilità locali della litosfera, si possono ipotizzare cali rapidi di livello di un paio di cm all’inizio di intervalli di 10 giorni, in modo da accumulare alla fine dei sei mesi un abbassamento di una trentina di centimetri.
La successione dei cambiamenti, che può essere seguita nella figura 6b, è fatta terminare dopo 73 anni, nel 2085, quando la superficie del mare si verrà a trovare circa 2,5 m sotto l'attuale livello, posizione che manterrà per 148 anni, fino al 2233. Da questo momento, o più probabilmente dopo un paio di decenni, il mare calerà molto più velocemente fino a quando, nel 2327, si può prevedere che si sarà portato oltre 50 m più in basso di oggi, e a quel punto il livello marino si assesterà per rimanere costante per 2213 anni. Nei successivi 2500 anni circa non ci dovrebbero essere grandi variazioni di rilievo, completandosi così un episodio glaciale della durata complessiva di circa 5000 anni, del tutto analogo a quello, iniziato 40 mila anni fa, che vide la strage dei mammuth siberiani e a un altro, di equivalente importanza, di 80 mila anni fa.
Come già sostenuto in precedenza, tali variazioni del livello marino sono attribuibili a episodi di espansione del globo terrestre, a loro volta indotti da diminuzioni del coefficiente di gravitazione G. Potremo accorgercene, ma solo strumentalmente, poiché la Terra rallenterà leggermente la velocità di rotazione, con un conseguente aumento della durata del giorno, e si muoverà su una più larga orbita di rivoluzione intorno al Sole, per cui anche la lunghezza dell'anno risulterà accresciuta. I due fenomeni ovviamente procederanno di pari passo con le diminuzioni di G, quindi potranno essere osservati in modo discontinuo nell'arco dei primi 73 anni per poi scomparire quasi nei 148 anni successivi, quando G subirà soltanto oscillazioni minori.
In modo diverso si manifesterà invece la subsidenza delle aree di recente sedimentazione. Lo si può prevedere riflettendo su quanto è successo alla città di Sibari, evacuata nel 510 a.C. appena 6 anni dopo l'inizio dell'attuale ciclo, nel 516, quando l'abbassamento del piano campagna doveva avere raggiunto un valore stimabile intorno a un paio di metri. Se l'intensità della sollecitazione che ha interessato l'area fosse aumentata per gradi in tutto l'intervallo di 73 anni seguendo i decrementi di G, lo sprofondamento sarebbe stato decisamente più lento e non sarebbe terminato prima del 443, quando è stata fondata Thurii. Si deve ritenere dunque che le condizioni necessarie per un avvio così veloce della subsidenza si siano prodotte in una misura completa fin dall'inizio del ciclo di 2528 anni.
Le conclusioni raggiunte sui tempi dello svolgimento della subsidenza in aree dove si è avuta una recente sedimentazione possono essere trasferite alla possibilità dell’insorgere di frane sottomarine, poiché i due fenomeni sono influenzati dalla stessa causa, vale a dire cambiamenti del campo elettrico della Terra solida. Di conseguenza c'è da aspettarsi che nella seconda metà del 2012 franamenti potranno interessare le zone di scarpata degli ambienti sommersi.
Sapendo che le frane sottomarine inducono maremoti di entità proporzionali alle masse che si muovono e alla loro velocità, e che gli eventi futuri si verificheranno in condizioni eccezionali, appare probabile un intensificarsi di maremoti.
Dopo il calo del livello marino, il fenomeno che sarà forse più evidente nella sua connessione con il calo del coefficiente di gravitazione G e la dilatazione del pianeta sarà quello della subsidenza delle aree di recente sedimentazione, dove si siano deposti sedimenti a grana fina o finissima (limi e soprattutto argille) o, peggio ancora, torbe.
Mentre l’intensità del fenomeno si mostrerà diversa da luogo a luogo in funzione della natura, dell’età e dello spessore dei terreni, il tempo necessario per rendere inabitabile l’area dipenderà anche dalla quota a cui si trova attualmente il piano di campagna. La velocità sarà massima all’inizio per poi diminuire secondo una precisa relazione matematica. In genere, il concomitante calo del mare risulterà insufficiente a compensare gli abbassamenti.
Si può prevedere che su tutto il pianeta la perdita potrebbe avvicinarsi a 200 mila km2. Le stime sono probabilmente compiute per eccesso, dato che il criterio adottato è stato principalmente di giudicare in base all’estensione delle aree comprese entro l’intervallo di quote tra 0 e 2 o talvolta anche 3 m sul livello del mare. Il rischio reale di un abbassamento che porti il piano di campagna al disotto del livello del mare dipenderà dalla natura e dallo spessore dei terreni recenti presenti nel sottosuolo. Dove lo spessore è irrilevante o i terreni sono costituiti esclusivamente da sabbie, il pericolo di una sommersione non sussiste.
Le maggiori regioni interessate dal fenomeno si trovano alle foci del Mississippi e del Gange, dove ognuna di esse perderà circa 30 mila km2. Ma mentre New Orleans si troverà al centro dell'area sommersa, quindi difendibile con una certa difficoltà, Dhaka se ne troverà al margine e verrà colpita solamente in una sua parte minore.
Il bacino del Niger, con la città di Yenagoa, perderà 20 mila km2, quello dello Yangtzé con Shanghai 15 mila, il Nilo, con una parte marginale di Alessandria, 10 mila, l'Indo 5 mila, il Fiume Giallo almeno 2500, la zona di Bangkok altrettanto, la foce del Paranà-Uruguay circa 800, quella delle Amazzoni con Belem appena 200 km2.
In diverse aree la conservazione degli abitati richiederà la costruzione di dighe. Dove queste sono già presenti, come in Olanda, sarà in gran parte necessario sopraelevarle. Diversi aeroporti, come quelli di San Francisco e di Roma Fiumicino, sono stati costruiti in aree di recente deposizione; pertanto rischiano frequenti chiusure per mantenere le piste alle quote originarie.
In Italia, alla foce del Po saranno interessati quasi 2000 km2 tra Chioggia, Copparo e Ravenna. Lungo l'Arno la subsidenza arriverà a toccare anche Pisa, dove alcuni punti che si trovano ad appena 1 m sul livello del mare indicano una sedimentazione recente. L'elenco potrebbe essere molto più lungo, ma esulerebbe dallo scopo di questo libro. Spetterà a chi conosce le condizioni geologiche locali valutare se si può verificare un fenomeno di subsidenza ed in tal caso quali sono gli interventi necessari per scongiurare eventuali situazioni dannose. Occorre in particolare rispolverare la storia dei singoli luoghi per sapere se in passato si erano verificate condizioni sospette. Cito come esempio il caso della pianura che si estende ad ovest di Grosseto: al tempo della conquista romana vi era un esteso lago, denominato “Lacus Prilis”, che lentamente si è colmato di sedimenti dovuti al trasporto solido del Fiume Bruna. Successivamente si è trasformato in palude, ed è stato infine bonificato nel XVIII secolo. Non è difficile prevedere che ritornerà alla condizione di laguna o di lago costiero qualche anno dopo il 2012, analogamente a quanto accadrà alla piana dove sorgeva Tartesso.
Anche se non in modo continuo, nel 2012 inizierà un periodo di espansione del globo terrestre; il fenomeno turberà l'equilibrio dinamico che si è instaurato all'interno del pianeta. L'espansione non avverrà ovunque, e dove avverrà non lo sarà in un’unica misura. La dilatazione massima potrebbe verificarsi là dove attualmente questo movimento già è in atto, ovvero lungo le dorsali medioceaniche.
In misura minore potremmo avere una accentuazione dei movimenti in qualunque altra situazione dove la litosfera si apre. Tra la Calabria e la Sicilia esiste una condizione di questo genere: basta guardare una carta geografica abbastanza dettagliata per osservare che le due regioni si fronteggiano con un medesimo profilo, segno che un tempo esse erano a contatto e successivamente hanno cominciato ad allontanarsi. L’uso delle tecniche GPS ha consentito di determinare velocità e verso del movimento: sono 2÷3 mm all’anno nella direzione NW-SE. Difficile prevedere che effetto avrà questa eventuale accentuazione dello spostamento relativo. È difficile anche perché le attuali conoscenze dell’area risentono di gravi pregiudizi, come quello secondo il quale sia la Calabria che la Sicilia si starebbero sollevando, e in misura diversa.
Nelle aree in cui la litosfera tende a ridursi, come avviene dove una placca si porta al disotto di un’altra secondo un piano di Wadati-Benioff, la dilatazione prevista del globo terrestre dovrebbe portare a un rallentamento del movimento e di conseguenza ad una attenuazione dell’attività sismica.
Se consideriamo quanto accaduto negli ultimi 25 mila anni circa, possiamo distinguere due periodi: il primo, compreso tra il culmine glaciale di 25 mila anni fa e il culmine interglaciale di 4800 anni fa, in cui si è verificata una serie di contrazioni della Terra; il secondo, da 4800 anni fa fino ad oggi, caratterizzato da una serie di dilatazioni. È lecito pensare che, nel primo di questi due periodi, ad ogni inizio di un ciclo di 2528 anni i terremoti lungo le coste del Sudamerica e Centroamerica (che si trovano al disopra di un piano di subduzione) debbano essersi manifestati con una potenza nettamente maggiore del solito; al contrario, nel secondo periodo è collocato un solo inizio di un nuovo ciclo, nel 516 a.C., durante il quale, a causa della espansione del globo terrestre, gli eventi sismici dovrebbero essere stati caratterizzati da una minore potenza liberata.
Se i Maya, come ho supposto, hanno preso consapevolezza del ciclo naturale di 2528 anni a cominciare da almeno 10 mila anni fa, potrebbero avere osservato un intensificarsi degli eventi sismici negli anni 8100 e 5572 a.C.; in base a ciò avrebbero deciso di fare partire il nuovo computo nel 3113 a.C. per farlo terminare nel 2012, anno in cui presumibilmente si aspettavano il ripetersi di un fenomeno simile ai precedenti.
È dunque questo messaggio che ci voleva comunicare l’iscrizione parzialmente cancellata della stele appartenuta al tempio di Tortuguero? Forse non è un caso che le popolazioni del Centroamerica abbiano scelto, come dio dominatore della loro quinta era, Toniatuh, il dio del movimento: egli le avrebbe protette per tutti gli anni del lungo computo dai movimenti che la Terra ogni tanto scatena. Solo al termine dell’era si aspettavano la catastrofe.
Per ironia della sorte, dopo avere vissuto in attesa di un momento sapientemente previsto, l’attesa forse non sarà fedele alle aspettative giacché la dilatazione del pianeta potrà avere come effetto di attenuare la frequenza e l’energia dei terremoti in quest’area se, come si ritiene, l’attività sismica è determinata essenzialmente dai processi di subduzione di crosta oceanica al disotto delle catene montuose di questa regione.
Al contrario, nell'Appennino e in altre strutture montuose con un’origine simile, la tendenza della Terra ad espandersi creerà condizioni favorevoli ai sollevamenti orogenetici. Perciò è da mettere in conto una possibile intensificazione dell’attività sismica lungo la nostra penisola.
Nell’area dello Stretto di Messina la situazione è più complessa. Purtroppo la tettonica delle placche ci potrebbe fornire informazioni previsionali più idonee se non avesse escluso l’eventualità che la Terra ogni tanto cambi le proprie dimensioni. Con una certa difficoltà si può pertanto predire che cosa potrebbe accadere in questa zona del Mediterraneo. A rigore di logica, ma anche in maniera un po’ troppo semplicistica, si può avanzare l’ipotesi che un allargamento generale della superficie terrestre debba avere ripercussioni in tutte le aree dove un’espansione è già in atto, fra cui appunto il Canale di Sicilia. Pertanto sarà opportuno tenere questa zona sotto attenta osservazione.
Nonostante l’impegno di contenere il più possibile gli argomenti di questo libro entro l’ambito della Natura nei suoi aspetti legati alla geologia, farò seguire alcune osservazioni di altro genere, come per chiudere un cerchio, iniziato a tracciare nelle prime pagine, quando mi sono addentrato nella cultura maya.
Durante una visita al Museo storico di Nanchino, sono stato colpito da un particolare a cui dapprima non avevo dato peso. Poi però una tabella esplicativa affissa a un muro che divideva la prima e la seconda stanza mi ha fatto riflettere su un salto considerevole di fattura tra i dischi bi della prima stanza e quelli della seconda. I dischi bi sono dischi cerimoniali di giada con un foro circolare al centro, utilizzati fin dall’inizio del neolitico; simboleggiano il cielo. Il salto di fattura riguardava sia la dimensione, che prima era di circa 10 cm e poi di circa 20, sia, soprattutto, le decorazioni. Decorazioni più raffinate si trovavano poi anche sul vasellame. Ciò che mi ha colpito non era tanto la differenza quanto il momento in cui essa emergeva: 5000 anni fa circa.
Vi è un altro momento in cui la lavorazione dei dischi bi ha avuto un salto di qualità: nel periodo chiamato “degli stati combattenti”, che va dal 482 al 221 a.C. la decorazione raggiunse una raffinatezza mai superata per gusto artistico e tecnica di preparazione.
Sono stato sempre attratto dalle coincidenze perché fanno riflettere per sapere se si tratta di fatti casuali o significativi. La coincidenza è con il termine di un ciclo naturale di circa 2500 anni. Mi è capitato di osservare un’analoga coincidenza nel nuovo museo dell’acropoli di Atene. Al secondo piano sono esposte diverse statue di kuroi e korai, giovani che adornavano le tombe più ricche del Keramikòs, l’antico cimitero. Ciò che mi ha attratto è stata la diversità dei volti femminili a cavallo di 2500 anni fa: prima sono poco espressivi, a volte quasi trasmettono imbarazzo, ma in seguito sono disinvolti, sorridenti, di persona matura. Ho pensato che probabilmente non era frutto del caso, se si considera che allora il processo di individuazione dell’uomo aveva raggiunto una vetta sorprendente e che da quel momento si è avuta una fioritura culturale e artistica senza precedenti. Basta pensare a Fidia, Socrate e Platone. Anche in Asia, 2500 anni fa, si è verificato un rinnovamento culturale, allorché vennero concepite le dottrine del Buddha, di Lao Tse e Confucio. Karl Jaspers ha inserito questi avvenimenti in un periodo, che egli ha denominato “assiale”, di particolare sviluppo del pensiero dell’uomo e che si esteso secondo lui dall’800 al 200 a.C..
Io mi spingo a supporre che il periodo assiale di Jaspers abbia avuto al suo interno un momento molto più ristretto, più incisivo, che abbia seguito immediatamente il 516 a.C.. Il precedente momento assiale, che avrebbe come anno di riferimento il 3044 a.C., potrebbe essere caratterizzato dall’abbandono della lavorazione poligonale in favore di quella dei blocchi squadrati, molto più facile da mettere in pratica, una volta che si sia seguito il criterio di segare le pietre anziché scalpellarle. Sviluppando l’idea che i momenti assiali siano in stretta relazione con il passaggio tra due cicli di 2528 anni, possiamo supporre l’esistenza di un ulteriore momento di questo genere nel 5572 a.C., e il segno sarebbe una evoluzione rilevante nella tecnica costruttiva. Ad Alatri, Pyrgi, Cosa ed Orbetello le mura mostrano una fattura più raffinata rispetto ad altre mura “ciclopiche” che dal Lugli sono state definite di prima e seconda maniera e che si trovano ad esempio ad Artena e Roselle. Queste maniere più grezze sono chiaramente distinte dalla terza, l’unica che si può definire “poligonale”; nella prima le pietre non sono sgrossate e sembrano essere state messe in posto così come provenivano dalla cava; nella seconda la faccia a vista è ritoccata fino a renderla quasi piana, ma tra un elemento e l’altro è ancora necessario inserire elementi più piccoli a riempire spazi lasciati aperti. Più volte accade di riscontrare che in una stessa città sono rappresentate almeno due delle tre maniere. L’ipotesi è dunque che il passaggio dalla prima (o, meglio, dalla seconda) alla terza maniera avvenga in un determinato tempo e abbia perciò un valore cronologico; il salto qualitativo potrebbe avvenire in prossimità del 5572 a.C..
Volendo mettere a confronto e distinguere i tre momenti assiali individuati, troveremo una uniformità di criterio solo se ci riferiamo al modo in cui veniva lavorata la pietra. Assumendo come simboli delle tre fasi il Partenone di Atene, la piramide di Cheope e la cinta muraria di Cosa, i tre momenti assiali potrebbero essere denominati rispettivamente “greco”, “egizio” e “pelasgico”, senza la pretesa però di assegnare con questi termini delle limitazioni geografiche precise.
È da prevedere un nuovo momento assiale con l’inizio del prossimo ciclo, nel 2012? Ne sono fermamente convinto. Poiché non si tratterebbe di un avvenimento casuale, la causa va cercata tra i fenomeni fisici che potranno subire dei mutamenti. Essendo noto che la radiazione ultravioletta stimola l’attività cerebrale dei neurotrasmettitori, tanto che la fototerapia è impiegata con successo nella cura della depressione, possiamo formulare l’ipotesi di un aumento del flusso di tale radiazione. L’ipotesi sarà presto confermata se si verificherà un allargamento del buco dell’ozono. In questo caso c’è da augurarsi che le maggiori capacità intellettive saranno impiegate per un miglioramento obiettivo della condizione umana sulla scala più ampia possibile.
Conclusioni.
L’antica cultura dei Maya e delle altre popolazioni del Centroamerica sarà grandemente rivalutata quando ci accorgeremo che essi erano a conoscenza di un millenario ciclo naturale che l’uomo moderno ancora ignora quasi del tutto. Conoscevano perfettamente anche il ciclo della precessione degli equinozi, la cui scoperta oggi viene invece attribuita all’astronomo greco Ipparco di Nicea, vissuto nel II secolo a.C.. Si parla molto di una “profezia” maya, ma sarebbe più corretto chiamarla previsione poiché non è stata concepita per merito della preveggenza di qualche indovino ma con una sapienza alimentata e tramandata attraverso osservazioni astronomiche protratte per decine di migliaia di anni.
Gli avvenimenti che avrebbero dovuto chiudere la loro quinta era non ci sono noti poiché il documento litico a cui ne era stata affidata la memoria è andato in parte perduto, tuttavia possiamo ritenere che consistessero in un acuirsi dell’attività sismica della loro regione. Paradossalmente, seguendo nuovi criteri di valutazione del comportamento del globo terrestre, con la fine del 2012 è possibile che la previsione maya si debba applicare non al Centroamerica ma ad altre regioni, tra le quali ricade purtroppo anche il nostro Appennino. Tra le aree particolarmente sensibili alle nuove sollecitazioni che si genereranno nella litosfera è possibile che vi sia anche il Canale di Sicilia, dove le due regioni che vi si affacciano potrebbero accelerare la velocità con cui attualmente si allontanano l’una dall’altra. Se ciò dovesse avvenire, potremmo contare su metodologie di previsione che, se fossero state note nel 1908, avrebbero potuto lanciare per tempo un allarme. Tra tali metodologie ne andranno prese in considerazione alcune volutamente trascurate, come quelle che ricorrono a misure della concentrazione del radon, all’idea di una dilatanza delle masse rocciose in prossimità delle superfici sismogenetiche, alle maggiori deformazioni mareali della crosta terrestre conseguenti ad allineamenti dei corpi del sistema solare. L’utilizzazione di tutte le metodologie, senza scartarne a priori nessuna, dovrebbe essere il criterio da seguire sempre, nelle aree che vengono riconosciute a rischio.
Ad iniziare probabilmente dalla seconda metà del 2012 vi saranno manifestazioni piuttosto diverse, ad indicare improvvisi cambiamenti dell’ambiente fisico. Oltre a paventate tempeste magnetiche, dovute ad una insolita attività solare, e a una probabile inversione del polo magnetico, potremo accorgerci dell’inizio di un nuovo ciclo naturale in quanto sarà segnato da un apprezzabile abbassamento del livello del mare, in controtendenza rispetto a quanto avviene da due secoli a causa del rilevante aumento dei gas serra nell’atmosfera. Tra gli aspetti positivi di tale fenomeno possiamo considerare la fine dell’arretramento delle spiagge.
Un altro segnale, forse il più sollecito, dell’avvento del nuovo ciclo verrà fornito da un intensificarsi delle frane sottomarine nelle zone di scarpata, con qualche ripercussione anche più in prossimità della costa. Alle frane saranno legati maremoti di entità generalmente modesta, ma non trascurabile se si considera una stagione estiva, quando le spiagge sono più affollate. È da tenere presente che in questo genere di maremoti la fase iniziale è di ritiro, a cui segue una rimonta proporzionale all’entità della prima fase.
Più lenta ad apparire, nei suoi gravi effetti, sarà la subsidenza della maggior parte delle aree costiere di recente sedimentazione. Una delle caratteristiche principali che rendono riconoscibili tali aree è di avere una morfologia piatta e quote di pochissimi metri sopra il livello del mare. Se nel sottosuolo sono presenti depositi argillosi o, peggio ancora, torbosi, nel volgere di alcuni anni essi si compatteranno a causa di pressioni indotte da cambiamenti nel campo elettrico della Terra solida, e il piano campagna si abbasserà. Nella maggior parte dei casi l’abbassamento del livello marino non sarà sufficiente a compensare il movimento di subsidenza, e l’area interessata finirà per venire sommersa dal mare.
La dimensione del fenomeno sarà tale da indurre milioni di persone ad abbandonare la loro terra, creando un problema di emigrazione imprevisto. Se si considera che il nostro pianeta, con i suoi 7 miliardi di abitanti, risente già da tempo di una carenza di provviste alimentari, c’è da ritenere che il problema diventerà ancora più grave e non potrà essere tenuto sotto controllo da miglioramenti di produzione.
Esiste tuttavia un motivo per essere relativamente ottimisti. Come accaduto all’incirca 5000 e 2500 anni con l’inizio di un nuovo ciclo di 2528 anni, a partire dal 2012 ci si dovrebbe aspettare un aumento diffuso di consapevolezza, un progresso non in senso tecnologico ma culturale. Forse gli aspetti nuovi con cui si presenterà la Natura faranno risvegliare nell’uomo più giusti e consapevoli sentimenti di appartenenza ad un tutto unico.
Indice
Prefazione 1
Introduzione 2
La profezia dei Maya 7
La fine del mondo 17
Impatti di meteoriti 20
Estinzioni di massa 23
Grandi innalzamenti del mare 24
Struttura della Terra 28
Il Tirreniano 30
Cambiamenti climatici 33
Carestie 49
Terremoti 51
L’Appennino 62
Vulcani 67
Tsunami 72
Bradisismi 77
Città scomparse per subsidenza 79
Consolidazione discontinua delle argille 83
I cambiamenti recenti del livello del mare 85
Abbandono di due città megalitiche 87
Cicli cosmici 97
Previsioni 105
Conclusioni 112
Indice 115
Quarta di copertina
Questo libro è scritto per chi vuole sapere quali avvenimenti naturali ci riserva il prossimo futuro e non accetta il fatalismo con cui le catastrofi vengono attese come inevitabili. C’è una profonda avversione nel mondo scientifico a parlare di questi argomenti, in parte per una cattiva impostazione data due secoli fa alla ricerca sulla natura e in parte perché alcuni, che devono prendere decisioni, cercano di sfuggire in vario modo alle responsabilità che il loro ruolo istituzionale imporrebbe. Se questa constatazione ci sorprende lo farà ancora di più scoprendo che i Maya su questi aspetti avevano un atteggiamento più maturo, che probabilmente deriva dalla loro maggiore vicinanza alla natura. Essi avevano anche una cultura molto più avanzata di quanto generalmente si pensa, con radici che andavano indietro nel tempo per almeno 10 mila anni. Ma il particolare più straordinario è che la famosa “profezia” del 21 dicembre 2012, originata più di 5000 anni fa, sembra avere i fondamenti e la precisione di una previsione scientifica.
Roberto Mortari ha insegnato per 40 anni Geotecnica nella Facoltà di Scienze dell’Università La Sapienza di Roma. Si è interessato e ha pubblicato lavori di rilevamento geologico, stratigrafia, variazioni del livello del mare, consolidazione di terreni recenti, subsidenza, frane sottomarine, attività vulcanica, faglie sismogenetiche, sollevamento dell’Appennino, glacialismo, variazioni climatiche, datazioni. Ha pubblicato un libro dal titolo I ritmi segreti dell’Universo, in cui espone le sue ricerche su ritmi naturali che prendono la loro origine da variazioni, di varia intensità e frequenza, del coefficiente di gravitazione universale.
Didascalie di Figure e Tabelle
Figura 1 – I segmenti verticali e i relativi numeri tra parentesi indicano le estensioni temporali delle cinque ere dell’umanità nella tradizione popolare del Centroamerica. Sulla sinistra appaiono gli anni in cui sono stati calcolati i limiti di cicli naturali ricorrenti ogni 2528 anni.
Figure 1 - The vertical segments and the relative numbers in parentheses indicate the temporal extensions of the five ages of humanity in the popular tradition of Central America. On the left are the years when we calculated the limits of natural cycles occurring every 2528 years.
Figura 2 – Cambiamento del livello del mare negli ultimi 30 mila anni. I nomi al disopra del grafico sono stati assegnati a morene frontali della calotta glaciale che ha ricoperto l’Europa. Come per gli stazionamenti del livello marino si sono alternate durate più e meno lunghe, così per le morene si osservano dimensioni alternativamente maggiori e minori. In basso figurano i quattro periodi climatici dell’Europa centrale, distinti sulla base dei caratteri della vegetazione, che si sono succeduti ogni 2500 anni circa a partire da 10 mila anni fa. Da Mortari (2010).
Figure 2 - Changes in sea level over the past 30 thousand years. The names above the graph were assigned to terminal moraines of the ice cap that covered Northern Europe. As for the stasis of sea level more and less durations alternated, so for the moraines alternately larger and smaller sizes were observed. Below are listed the four climatic periods of Central Europe, based on distinct character of the vegetation, that have succeded every 2500 years or so starting from 10 thousand years ago. From Mortari (2010).
Figura 3 – Cambiamento del livello marino durante la grande trasgressione che ha caratterizzato l’inizio dell’Età Tirreniana. La ricostruzione è stata possibile poiché tale cambiamento ha avuto un carattere discontinuo e le quote degli stazionamenti del mare si ritrovano identiche ovunque non siano intervenuti movimenti verticali della crosta terrestre. Da Mortari (2010).
Figure 3 - Changes in sea level during the great transgression that characterized the beginning of the Tyrrhenian age. The reconstruction has been possible since these changes had a discontinuous character and the elevations of the sea level stands were found identical anywhere no vertical movements of the Earth’s crust occurred. From Mortari (2010).
Figura 4 – Variazione della temperatura alla base dell’atmosfera nell’emisfero settentrionale secondo tre esperti dell’IPCC. Il grafico “dimostrerebbe” la causa esclusivamente antropica del recente riscaldamento globale. Da Mann et al. (1999).
Figure 4 - Variation of temperature at the base of the atmosphere in the northern hemisphere according to three IPCC experts. The graph "shows" the anthropical cause of recent global warming. By Mann et al. (1999).
Figura 5 – Variazione della temperatura determinata per mezzo del rapporto isotopico dell’ossigeno da carote di ghiaccio prelevate in un sondaggio meccanico in Groenlandia. Da Alley (2004).
Figure 5 - Variation of temperature determined by means of the oxygen isotope ratio from ice cores coming from a mechanic drill in Greenland. By Alley (2004).
Figura 6 – a) Variazione della temperatura negli ultimi 5300 anni stimata soprattutto in base a documentazioni storiche. I quattro acmi sono condizioni di optimum climatico che si sono realizzate nel medioevo (OCM), nel periodo dell’antica Roma (OCR), nell’età del bronzo (OCB) e in corrispondenza del culmine interglaciale (OCI). L’estensione a tratti della curva indica quale avrebbe potuto essere l’andamento naturale se non fosse intervenuta l’attività antropica. b) Variazione del livello marino nello stesso periodo e proiezione nel prossimo futuro. Si notano stazionamenti “primari” durati 2200 anni circa e altri, “secondari”, di circa 150 anni; tra i due compaiono transizioni della durata di circa 80 anni.
Figure 6 - a) Temperature variation in the past 5300 years estimated primarily on the basis of historical records. The four peaks are conditions of climatic optimum that were present in the Middle Ages (MCO), in the period of ancient Rome (RCO), in the Bronze Age (BCO) and at the peak of the interglacial (ICO). The dashed extension of the curve indicates which could have been the natural course if anthropic activity were not occurred. b) Changes in sea level during the same period and projections in the near future. "Primary" stands can be noticed lasted about 2200 years and more, and "secondary" stands of about 150 years; between the two transitions appear transitions lasting about 80 years.
Figura 7 – Il grafico inferiore illustra come è cambiata la concentrazione del radon nell’aria (in Bq/m3) a L’Aquila dal 15 gennaio al 15 aprile 2009. Il grafico superiore riporta la magnitudo locale delle maggiori scosse nello stesso periodo. Da Giuliani (2009).
Figure 7 -
Figura 8 – a) Stato recente della pianura compresa tra Siviglia (S) e la foce del Guadalquivir. Qui si ritiene che fosse ubicata la città di Tartesso (T). b) La stessa area al tempo della conquista romana era occupata da una grande laguna, chiamata da Avieno “Lacus Ligustinus”.
Figure 8 - a) Recent condition of the plain between Seville (S) and the mouth of the Guadalquivir river. Here it is considered that it was located the city of Tartessos (T).b) The same area at the time of Roman conquest was occupied by a great lagoon, called by Avieno "Lacus Ligustinus".
Figure 9 - Reconstruction of sea level changes over the past 10 thousand years, compared with the radiocarbon dating of sealevel indicators collected in stable areas. From Mortari (2005).
Figura 9 – Ricostruzione della variazione del livello del mare negli ultimi 10 mila anni, confrontata con datazioni con il metodo del radiocarbonio di indicatori di livello marino raccolti in aree stabili. Da Mortari (2005).
Figure 10-13 – Mura megalitiche di Santa Severa, sulle quali al tempo della conquista romana è stata edificata Pyrgi, nel Medioevo è sorta una torre saracena a difesa del porto locale e successivamente è stato costruito un castello con il suo borgo. Sui blocchi di pietra utilizzati si trovano in abbondanza fori lasciati da litodomi, molluschi che vivono nel mare a qualche decimetro di profondità.
Figura 14 – Massimi annuali del livello del mare registrati a Stoccolma (linea continua), in Italia (linea a tratti), a Wake, USA (triangoli vuoti), Chichijima, Giappone (triangoli pieni), Hilo, Hawaii (cerchi), Kwajalein, isole Marshall (croci) e Cocos, isola australiana al largo di Giava (quadrati). Nelle ordinate la numerazione dei giorni continua oltre il 31 dicembre per comodità di rappresentazione.
Figures 10-13 - Megalithic walls of Santa Severa, on which at the time of Roman conquest was built Pyrgi, in the Middle Ages arose a Saracen tower to defend the local harbor and was later built a castle with its village. On the blocks of stone can be found in abundance holes left by mollusks that live in the sea a few feet deep.
Figure 14 - Maximum annual sea level recorded in Stockholm (solid line), in Italy (dashed line), Wake, USA (open triangles), Chichijima, Japan (filled triangles), Hilo, Hawaii (circles), Kwajalein , Marshall islands (crosses) and Cocos island off the Australian island of Java (squares). In the axis of ordinates the day numbering continues beyond December 31 for convenience of representation.
Tabella 1 – Anni (e loro differenze) in cui si sono manifestati livelli marini particolarmente elevati oppure condizioni climatiche improvvisamente più calde.
Tabella 2 – Anni di più elevato livello del mare; in grassetto quando il livello è particolarmente elevato. d: differenza di tempo, in anni. N: cicli interi o semicicli. I triangoli indicano momenti di maggiore e minore attività solare.
Tabella 3 – Periodi e quasi-periodi (P) di cicli naturali con cui si manifestano variazioni del coefficiente di gravitazione universale. Gli effetti rilevati sono soprattutto variazioni del livello marino. Il valore minimo di P si riferisce a una pulsar estremamente regolare. Nella seconda colonna sono i rapporti r tra le durate medie dei cicli. Per le altre colonne si veda il testo.
Table 1 - Years (and their differences) when extremely high sea levels or suddenly warmer climatic conditions occurred.
Table 2 - Years of higher sea level, in bold when the level is particularly high. d: time difference, in years. N: whole cycles or half-cycles. The triangles indicate times of greater and lesser solar activity.
Table 3 - Periods and quasi-periods (P) of natural cycles interesting changes of the coefficient of universal gravitation. The effects detected are mainly variations in sea level. The minimum value of P refers to a extremely regular pulsar. In the second column are the ratios r between the average duration of the cycles. For the other columns see the text.